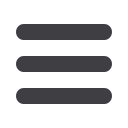
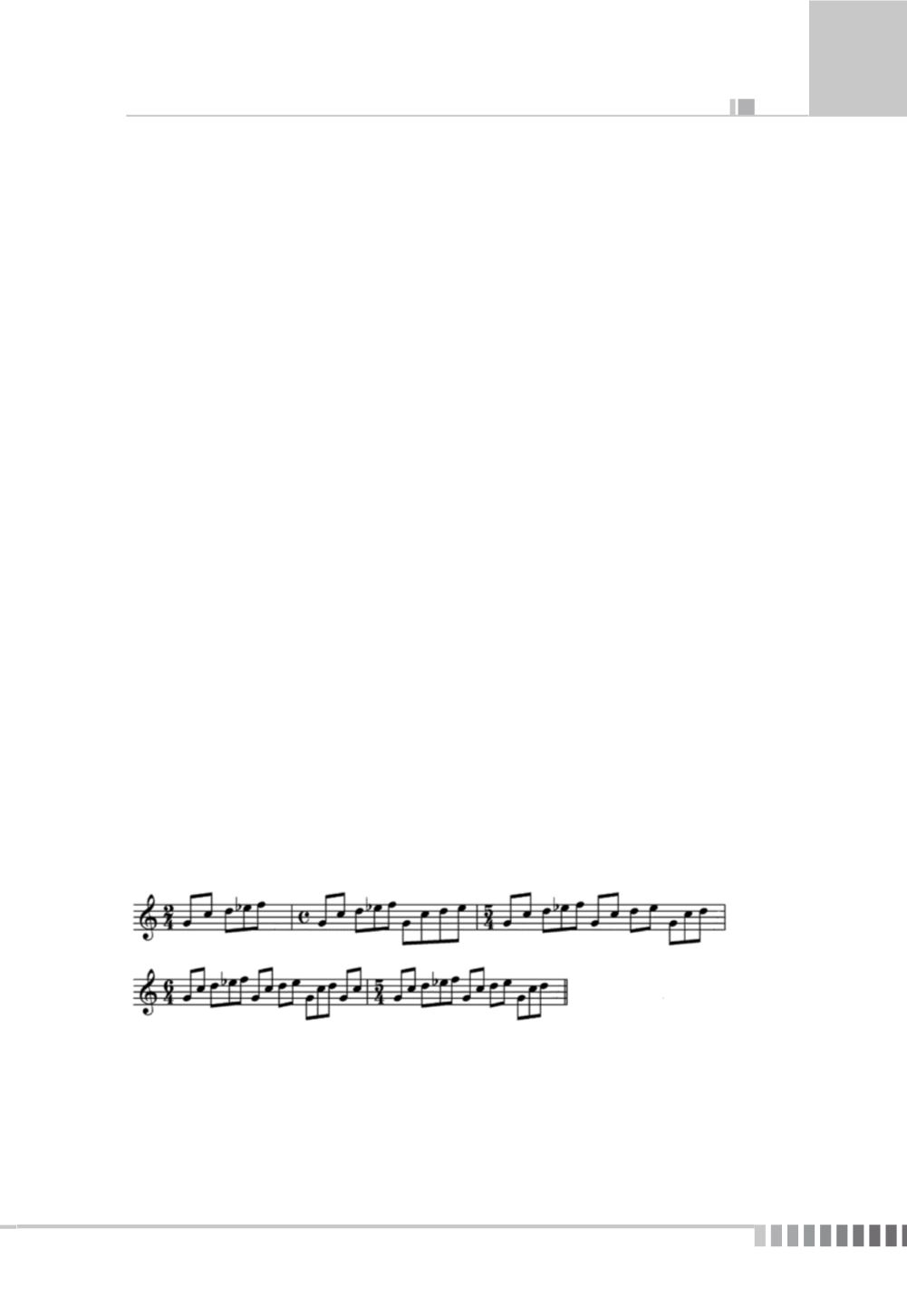
275
Risposte commentate
•
Prova ufficiale a.a. 2014 - Accorpamento 3
8) A.
Nel XVIII secolo la denominazione “dramma giocoso per musica”
designa l’opera buffa. Proprio nel Settecento, infatti, l’opera buffa conosce la
sua grandiosa fioritura, distaccandosi dall’opera seria ed organizzandosi con
maggiore libertà di forme e contenuti. La
Serva padrona
di Pergolesi (1733)
dà il via al grandissimo successo dell’opera buffa in tutta Europa. Essa viene
arricchita, oltre che con recitativi e arie, anche con duetti, terzetti, concertati
ed elaborati finali. Alla fine del secolo l’opera buffa, più libera ed aperta al
rinnovamento delle idee, trionferà su quella seria, diventando modello della
futura opera romantica.
9) C.
Con il termine
mélodrame
(francese) o
Melodram
(tedesco) si designa
una scena di teatro di parola con accompagnamento orchestrale. Questo ter-
mine si traduce in italiano con la parola melologo, che corrisponde ad un testo
letterario recitato, spesso con un unico attore, e accompagnato dalla musica,
che ne fa solo da commento.
10) B.
L’Accademia d’Arcadia, il fenomeno letterario che tanta importanza
rivestì nella storia della musica italiana, si costituì a Roma nel 1690, sotto il
patrocinio della regina Cristina di Svezia. Era un’accademia letteraria fon-
data da Gian Vincenzo Gravina e Giovanni Mario Crescimbeni. Quattordici
letterati, appartenenti al circolo letterario della regina Cristina di Svezia, si
incontrarono nel convento annesso alla chiesa di San Pietro in Montorio e die-
dero vita all’Accademia, considerata in tutto il Settecento non solo come una
semplice scuola di pensiero, ma come un vero e proprio movimento letterario
che si prefiggeva il ritorno alla tradizione e alla semplicità dei pastori-poeti
dell’Arcadia, in contrapposizione al cattivo gusto del Barocco.
11) C.
Si designa con il termine “minimalismo” una corrente stilistica tardo-
novecentesca che si fonda su microstrutture ripetitive e additive. Negli anni
’60 questa corrente si afferma e viene conosciuta anche con l’espressione di
“musica ripetitiva”. Essa si basava sulla riduzione delle strutture musicali ai
minimi termini e sulla ripetizione di brevissimi incisi ritmici e melodici.
Questo inciso è tratto da «Two Pages» di Ph. Glass ed esemplifica molto chia-
ramente il procedimento dell’addizione delle cellule musicali. L’inciso della
prima battuta viene ripetuto dalla seconda battuta in poi, ma aumentando
di volta in volta l’indicazione di tempo e ripetendo ciclicamente le note della
cellula base.
















