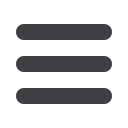

Capitolo 1
Plurilinguismo, identità culturali e bisogni educativi
5
www.
edises
.it
ca forma di incontro che possa dar vita a una
forma mentis
nuova e realmente
inclusiva. La costruzione della nuova
forma mentis
dev’essere realizzata accan-
tonando ogni forma di etnocentrismo, combattendo i pregiudizi, alimentando il
dialogo. Tutto ciò può accadere soltanto attraverso l’attivazione di forme reali e
continue di ascolto reciproco, conoscenze e incontro privi di pregiudizio. Quello
del “meticciamento” è un modello che si fonda sulla pratica dell’incontro/scam-
bio/dialogo, che rende possibile nel tempo cambiare in maniera significativa e
profonda l’identità e il modo degli individui di pensare a se stessi e alla propria
comunità di appartenenza. Quando il meticciamento si realizza in modo pieno
e corretto, esso genera una nuova identità, costruita con il contributo delle cul-
ture originarie e comune a individui che hanno le più disparate provenienze.
Qual è, dunque, il compito della scuola? Per definirlo, occorre innanzitutto com-
prendere il ruolo che l’istituzione scolastica svolge nella realizzazione di una
società interculturale. È un ruolo cruciale, poiché la scuola è il luogo sia fisico
sia mentale di incontro e di scambio in cui avvengono forme importanti di me-
diazione culturale in un contesto strutturato. La scuola offre occasioni continue
per lavorare per decostruire i pregiudizi, per promuovere il decentramento cul-
turale anche attraverso lo studio delle discipline, per costruire, in situazione,
pratiche di relazione e di dialogo costruttivo.
Se la scuola italiana e le scuole europee intendono dunque realizzare il proprio
progetto in una prospettiva interculturale devono porsi innanzitutto l’obiettivo
dell’anti-etnocentrismo, che richiede l’attuazione di una rivoluzione culturale
dei saperi, non solo della storia e della geografia, che sono da sempre considera-
te cruciali in quest’ottica, ma del sapere tutto, promuovendo un’esplorazione
della conoscenza che tenga conto delle tradizioni culturali e delle forme di pen-
siero di ogni parte del mondo.
I processi di formazione dovrebbero essere in grado di promuovere cultura e
quindi una società più che pluriculturale, più che multiculturale: interculturale.
Come? Promuovendo conoscenza attraverso il dialogo, formando menti aperte e
guidate da forme di pensiero divergente, educando gli individui e la società a
una cultura autocritica.
Una volta fissati gli obiettivi e gli strumenti, la scuola deve individuare e formare
le figure guida di tali cambiamenti: mediatori culturali, docenti, educatori, pro-
fessionisti dotati di strumenti di carattere personale, quali la capacità di cogliere
la differenza come valore, l’attitudine all’ascolto e al dialogo, la capacità di co-
struire conoscenza stando “tra le culture”.
La loro azione quotidiana deve essere sorretta e ispirata da alcuni principi fon-
damentali: quello della “differenza come risorsa”, che dovrebbe guidare ciascu-
no di noi a prescindere dalla prospettiva interculturale; quelli di uguaglianza
(come esseri umani), parità dei diritti, tolleranza reciproca, dialogo come stru-
mento e scopo. Attraverso l’esercizio quotidiano di questi principi, è possibile
costruire uno spazio dell’incontro permanente, entro il quale costruire l’intercul-
tura e guardare se stessi, le proprie identità culturali, le proprie appartenenze
attraverso il filtro di una nuova lente.
Ma che cosa significa e come si pratica la rilettura della propria identità? E come
si costruisce la nuova identità condivisa? Il primo passo necessario è liberare la
















