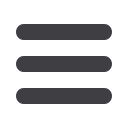

X
Premessa
modernità: illuminismo, idealismo, marxismo appaiono insufficienti a spiegare la
molteplicità dei fenomeni della società contemporanea. La modernità è finita. Ci
troviamo nella postmodernità. Lyotard, nel descrivere e valutare le problematiche
della postmodernità, anche di fronte alle crisi esistenziali, al nichilismo e ai diso-
rientamenti dell’uomo frammentato dell’età postmoderna, valuta la molteplicità
come ricchezza di opportunità. Coloro che sono capaci di elaborare conoscenze
e sviluppare competenze, infatti, possono percorrere questo mondo diventato un
villaggio globale e possono vivere dimensioni di cittadinanza attiva con nuove op-
portunità di inclusione nella società e nel mondo del lavoro ormai parcellizzato e
delocalizzato. Sono nuovi scenari che si aprono ai giovani. Conoscenze e compe-
tenze sono gli strumenti per decodificare e comprendere la postmodernità.
Le connotazioni del contesto sociale richiedono alla scuola strategie e modalità
di adattamento nuove: richiedono, in particolare, la strutturazione di un’offerta
formativa efficace, tale, cioè, da poter dare risposte adeguate ai bisogni emergenti.
L’apparato istituzionale, pertanto, deve essere ridotto al minimo, estremamente
esemplificato, tale da risultare agile e funzionale agli scopi prefigurati. La sua strut-
tura e la sua articolazione devono essere pervasive e capillari sul territorio perché
l’azione formativa risulti efficiente ed efficace.
La pluralità e la simultaneità degli stimoli che investono gli individui determinano
in questi ultimi nuovi stili di apprendimento di tipo reticolare, fondati, cioè sul me-
todo della comparazione, su procedure di top-down ovvero di analisi discendente
di fenomeni complessi da decodificare, sull’esigenza di individuare le relazioni esi-
stenti tra fatti, fenomeni ed eventi che caratterizzano il nostro tempo. Si richiede,
pertanto, alla scuola, di individuare strategie didattiche adeguate agli stili cognitivi
emergenti e di adottare metodologie che introducano un apprendimento “non
monotono”, congruente, cioè, con l’intensità e la varietà delle stimolazioni ricevu-
te. Ciò fa convergere l’attenzione sulla qualità e sull’efficacia della didattica.
I linguaggi massmediologici ed informatici emergenti dalle tecnologie e dalla cul-
tura multimediale, ad esempio, insieme con il ritmo accelerato della ricerca scienti-
fica, sollecitano gli allievi ad acquisire nuovi saperi che, non ancora codificati nelle
discipline curricolari, si presentano con la forza dei “saperi sociali”. Ciò sollecita la
scuola ad una revisione dei contenuti disciplinari e dei curricoli.
Così come cambia la società deve cambiare la scuola. La nuova mission è includere
il bambino ed il giovane nei processi sociali, promuovendo competenze ed obiettivi
formativi di cittadinanza attiva; la vision è il nuovo umanesimo dell’uomo “plane-
tario”, capace di interpretare, mediante l’unità del sapere, senso e significato dei
fenomeni in atto.
Le Indicazioni Nazionali 2012 per la costruzione del curricolo verticale colloca-
no l’allievo nello scenario della postmodernità. Esse fanno ampio riferimento al
quadro delle politiche dell’Unione Europea che coniugano cultura ed economia,
formazione dei giovani e sviluppo sociale e mirano al raggiungimento di obiettivi
di mobilità e di occupabilità dei giovani, di coesione sociale.
Per realizzare gli obiettivi dell’Unione Europea e promuovere lo sviluppo econo-
mico e sociale e migliorare, così, le condizioni di vita dei popoli, occorre formare i
giovani ad una nuova cittadinanza attiva.


















