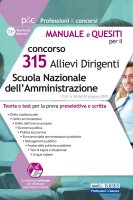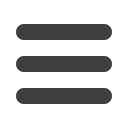

www.
edises
.it
Capitolo 1
Dalla cooperazione di settore all’Unione europea
329
Il Trattato si componeva di 448 articoli ed era diviso in un Preambolo e in altre quat-
tro parti:
>
il
Preambolo
de niva i valori fondamentali di cui l’Europa si è fatta portatrice e che
ha ereditato dal suo passato;
>
la
Parte I
(articoli 1-60) conteneva disposizioni in cui è nettamente prevalente il
carattere costituzionale (la de nizione e gli obiettivi dell’Unione, i diritti fonda-
mentali dei cittadini, il quadro istituzionale, la ripartizione delle competenze, la
vita democratica dell’Unione);
>
la
Parte II
(articoli 61-114) incorporava la
Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea
, proclamata a Nizza il 7 dicembre del 2000;
>
la
Parte III
(articoli 115-436) riuniva le disposizioni relative alle politiche dell’Unio-
ne e al funzionamento delle istituzioni, riprendendo e adattando la maggior parte
delle disposizioni dei Trattati in vigore, in modo da armonizzarle con le disposizioni
della Parte I;
>
la
Parte IV
(articoli 437-448) recava le disposizioni generali e nali.
La denominazione uf ciale dell’atto era
Trattato che adotta una Costituzione per l’Euro-
pa
. Da un lato, quindi, si trattava di un Trattato, dunque di un accordo internaziona-
le, un atto che nasce dall’incontro delle volontà di una pluralità di Stati che mettono
in comune sfere di sovranità senza rinunciare alla loro personalità internazionale;
dall’altro, era il frutto di un negoziato condotto non in modo esclusivo dagli Stati
membri, vista l’ampia partecipazione alla stesura anche di rappresentanti della so-
cietà civile, delle istituzioni europee e di altri soggetti non riconducibili direttamente
alla volontà di uno Stato. Quest’atto aveva la pretesa di dare una
Carta costituzionale
ad un’entità che, anche se non può de nirsi Stato, sicuramente coinvolge direttamen-
te la vita di tutti i cittadini dei Paesi che vi aderiscono.
Il Trattato-Costituzione non ha avuto vita facile, soprattutto a seguito dei
referendum
negativi circa la sua rati ca, svoltisi in Francia e in Olanda nel 2005, e ha generato
un lungo periodo di
impasse
politico-istituzionale terminato con la “bocciatura” dello
stesso.
1.9
Il Trattato di Lisbona (o Trattato di Riforma)
Dopo la bocciatura del Trattato costituzionale si è parlato di “fallimento costituzio-
nale” dell’Europa. Di certo, occorreva un periodo di ri essione in cui l’Unione euro-
pea avrebbe dovuto ripensare e, in parte, ridimensionare le proprie ambizioni.
Tale periodo si è concluso con l’approvazione, il 13 dicembre 2007, del
Trattato di
Lisbona
; alla conclusione della consueta procedura di rati ca in tutti gli Stati mem-
bri, tale atto è entrato in vigore dal 1° dicembre 2009.
L’accordo raggiunto ha aperto la strada ad una fase di rilancio, enunciando una
chiara e concreta ipotesi di lavoro: abbandonare il Trattato costituzionale rmato nel
2004, mantenendone tuttavia largamente intatta la sostanza. Per conseguire quest’o-
biettivo si è reso necessario adottare uno strumento essenzialmente tecnico e di bas-
so pro lo politico.
Pertanto, alla stregua dei precedenti Trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza, e
in contrapposizione al Trattato costituzionale, il Trattato di Lisbona non ha un’esi-
stenza propria: è un mero trattato modi cativo dei due trattati esistenti. Si compone,