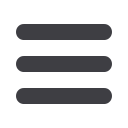

Capitolo 1
Dalle scuole speciali all’inserimento
5
www.
edises
.it
L’art. 415, infine, stabiliva che quando gli
atti di permanente indisciplina
fos-
sero tali da lasciare il dubbio che potessero derivare da
anormalità psichiche
,
il maestro poteva, su parere conforme dell’ufficiale sanitario, proporre l’allon-
tanamento definitivo al direttore didattico, il quale avrebbe curato l’assegnazio-
ne dello scolaro alle classi differenziali o, secondo i casi, iniziato d’accordo con
la famiglia le pratiche opportune per il ricovero in istituti per corrigendi.
Nel 1933 vennero introdotte le scuole speciali per i ragazzi «affetti da malattie
contagiose, fanciulli anormali e minorati fisici».
Una normativa, dunque, quella del ventennio fascista, che caratterizza la scuola
comune come istituzione rigida. In nessun conto vengono tenuti i bisogni e le
possibilità dei singoli fruitori: gli allievi che mal si adattano a recepire passiva-
mente quanto viene loro trasmesso o imposto, manifestando atteggiamenti d’in-
sofferenza e indisciplina, rischiano di essere avviati alle classi differenziali
1
.
Con la fine del fascismo e l’instaurazione della Repubblica, la Costituzione ita-
liana sancisce alcuni principi fondamentali che investono in modo diretto il
tema dell’integrazione. L’
articolo 2
richiama l’idea di cittadinanza basata sulla
solidarietà politica
,
economica
e
sociale
, l’
articolo 3
quella dell’uguaglianza
di tutti i cittadini davanti alla legge e della pari dignità sociale “senza distin-
zione di condizioni personali e sociali”. Per garantire tale uguaglianza e pari
dignità la Costituzione individua come strada da percorrere la rimozione degli
ostacoli di ordine economico e sociale che possono impedirne il compimento.
“Rimuovere gli ostacoli” non significa avviare le persone che “rappresentano
una differenza” alla “normalizzazione” o all’omologazione, bensì creare i pre-
supposti per realizzare una società nuova, realmente fondata sulla differenza
come valore, in quanto caratteristica propria dell’identità di ciascuno di noi. La
Costituzione è stata scritta nel periodo storico in cui la questione dell’integra-
zione accomunava la disabilità all’emigrazione. I cittadini italiani provenienti
dalle aree rurali del Sud o del Nord-Est, infatti, nel secondo dopoguerra, vessati
dalla povertà e dal malessere sociale, furono costretti a trasferirsi in massa ver-
so le aree più industrializzate del Nord. Qui nacquero grossi sobborghi urbani
che cambiarono la vita delle comunità locali. I cittadini della stessa nazione
scoprirono di essere lontani al punto da non riuscire a comunicare gli uni con
gli altri: essi parlavano dialetti differenti e reciprocamente incomprensibili. Alla
scuola toccò, dunque, il compito di far conoscere e usare a tutti la lingua italia-
na. In una prima fase, però, il problema fu risolto con la formazione di classi
differenziali e scuole speciali tra cui gli alunni furono suddivisi in base alla
provenienza regionale.
La circolare ministeriale n. 1771/12 dell’11 marzo 1953 fornisce la definizione di
scuole speciali e chiarisce la differenza tra classi speciali per minorati, scuole
di differenziazione e classi differenziali: «Le
classi speciali per minorati
e
quelle di
differenziazione didattica
» – spiega la circolare – «sono istituti sco-
1
M
oretti
I.,
Dall’inserimento all’integrazione degli alunni handicappati nella scuola comune: evolu-
zione culturale e normativa
, Atri Onlus, 2011.
















