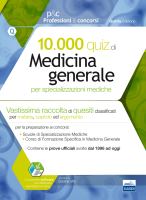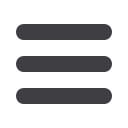
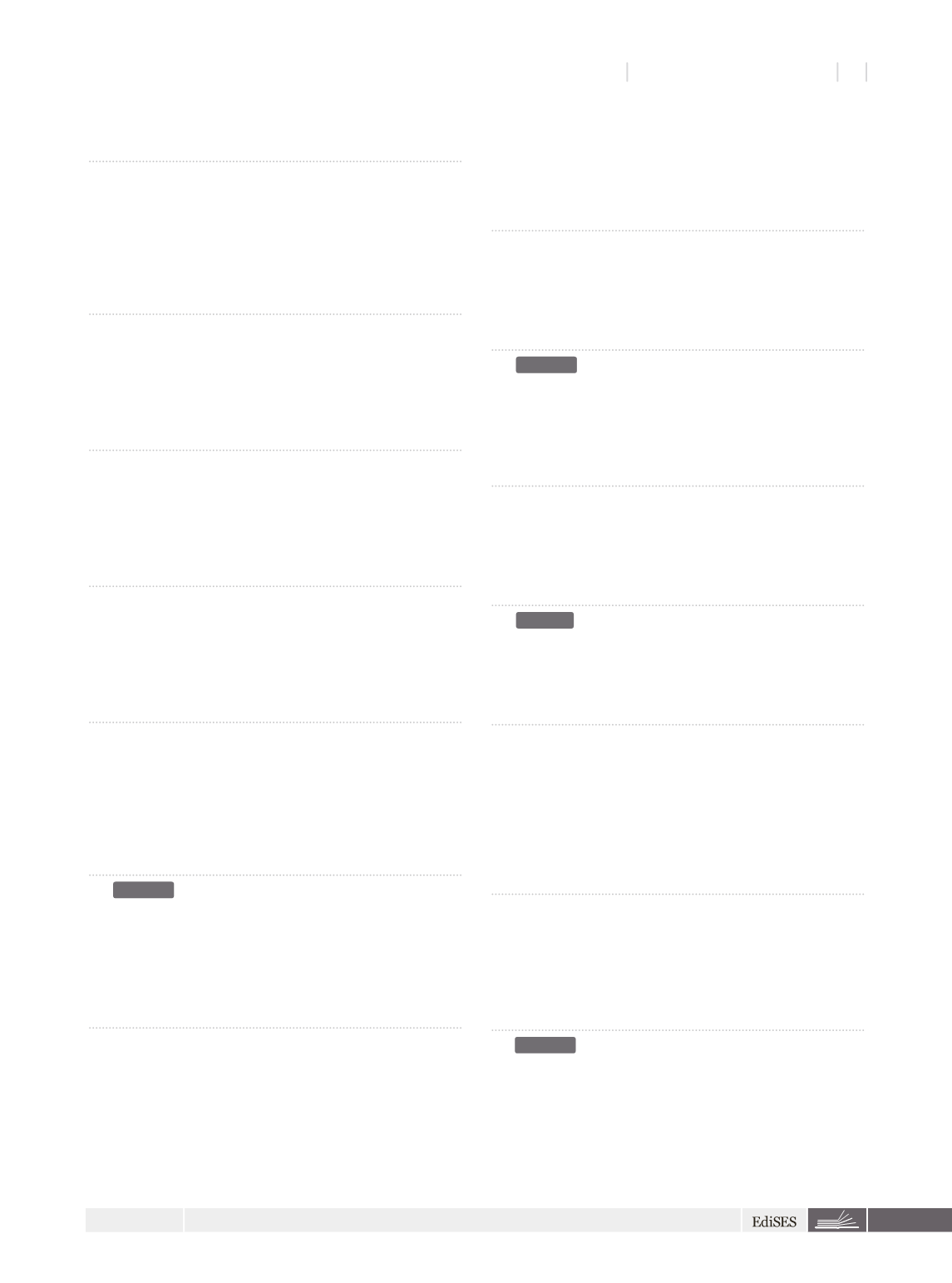
Apparato respiratorio
2.1 • Anatomofisiologia respiratoria
53
www.
edises
.it
E. La tensione superficiale dell’alveolo impedisce che
la depressione intrapleurica venga trasmessa agli al-
veoli
27) In quale circostanza vengono attivati i muscoli espira-
tori?
A. Quando necessitano flussi espiratori più elevati
B. Quando necessitano flussi inspiratori più elevati
C. Quando occorre assistere i mm espiratori nella successiva
inspirazione
D. Per avere un volume corrente più elevato
E. Per avere una capacità vitale più elevata
28) In che condizione fisiologica è predominante il control-
lo metabolico della respirazione?
A. Durante l’esercizio fisico
B. Durante la digestione
C. Nelle fasi di digiuno
D. Durante il sonno
E. Durante la veglia
29) A quale volume polmonare la distensibilità del polmo-
ne è minima?
A. In corrispondenza della capacità polmonare totale
B. In corrispondenza del volume residuo
C. In corrispondenza del volume di riserva inspiratoria
D. In corrispondenza del volume di riserva espiratoria
E. In corrisponenza della capacità vitale forzata
30) In quale circostanza viene persa la forza apposizionale
del diaframma?
A. In presenza di bassi volumi polmonari
B. In presenza di elevati volumi polmonari
C. In presenza di obliterazione dei seni costofrenici
D. In presenza di elevati flussi
E. In presenza di bassi flussi
31) Quale azione respiratoria predominante svolgono i mu-
scoli addominali?
A. Azione inspiratoria
B. Nessuna azione
C. Aumento della pressione intrapleurica
D. Azione espiratoria
E. Azione inspiratoria e aumento della pressione intrapleu-
rica
32)
MG • 2000
Una delle seguenti è la definizione
di“ventilazione polmonare”. Quale?
A. Scambio di O
2
e CO
2
fra aria e sangue a livello alveolare
B. Trasporto dei gas respiratori nel sangue
C. L’insieme di tutte quelle elencate
D. Scambio di O
2
e CO
2
fra aria e sangue a livello tessutale
E. Immissione di aria negli alveoli e sua successiva espulsio-
ne all’esterno
33) La capacità funzionale residua di un soggetto normale
di 70 kg è pari circa a:
A. 1 litro
B. 1.5 litri
C. 2 litri
D. 2.5 litri
E. 3.5 litri
34) La curva pressione-volume dell’apparato respiratorio
permette di misurare:
A. la compliance toraco-polmonare
B. la resistenza delle vie aeree
C. la capacità vitale
D. la capacità funzionale residua
E. il volume di chiusura
35) Cos’è la capacità funzionale residua polmonare?
A. Volume corrente + volume residuo
B. Volume di riserva espiratoria + volume residuo
C. Capacità vitale + volume residuo
D. Capacità inspiratoria + volume residuo
E. Volume di riserva inspiratoria + volume residuo
36)
MG • 2003
Come viene definito il volume di aria che ri-
mane nei polmoni dopo una espirazione normale?
A. Riserva inspiratoria
B. Volume corrente
C. Capacità funzionale residua
D. Volume residuo
E. Capacità vitale
37) La PO2 alveolare è normalmente uguale a:
A. la PO2 arteriosa + 10 mmHg
B. la PaCO2/R
C. la P barometrica – la PN2
D. la PO2 arteriosa – 10 mmHg
E. la P barometrica + la PH2O
38)
MG • 1998
Cos’è il Volume Corrente?
A. Il volume di aria di una inspirazione profonda
B. Il volume espiratorio massimo al secondo
C. Il volume di aria di una espirazione profonda
D. Il volume di aria di un singolo atto respiratorio
E. Il volume di aria di un atto respiratorio profondo
39) Il coefficiente di diffusione dell’ossigeno:
A. è maggiore del coefficiente di diffusione dell’anidride
carbonica
B. è minore del coefficiente di diffusione dell’anidride car-
bonica
C. è uguale al coefficiente di diffusione dell’anidride carbo-
nica
D. dipende dalla temperatura corporea
E. dipende dal volume polmonare
40) Durante la contrazione inspiratoria del diaframma la
pressione pleurica diventa:
A. uguale a zero
B. più positiva
C. più negativa
D. uguale alla pressione alveolare
E. uguale alla pressione atmosferica
41)
MG • 2003
I valori di PCO
2
negli alveoli sono maggiori
in quale fase della respirazione?
A. A metà dell’espirazione
B. All’inizio della inspirazione
C. A metà dell’inspirazione
D. All’inizio dell’espirazione
E. In tutte le fasi indicate