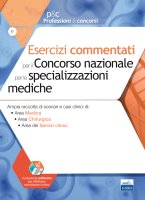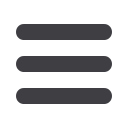
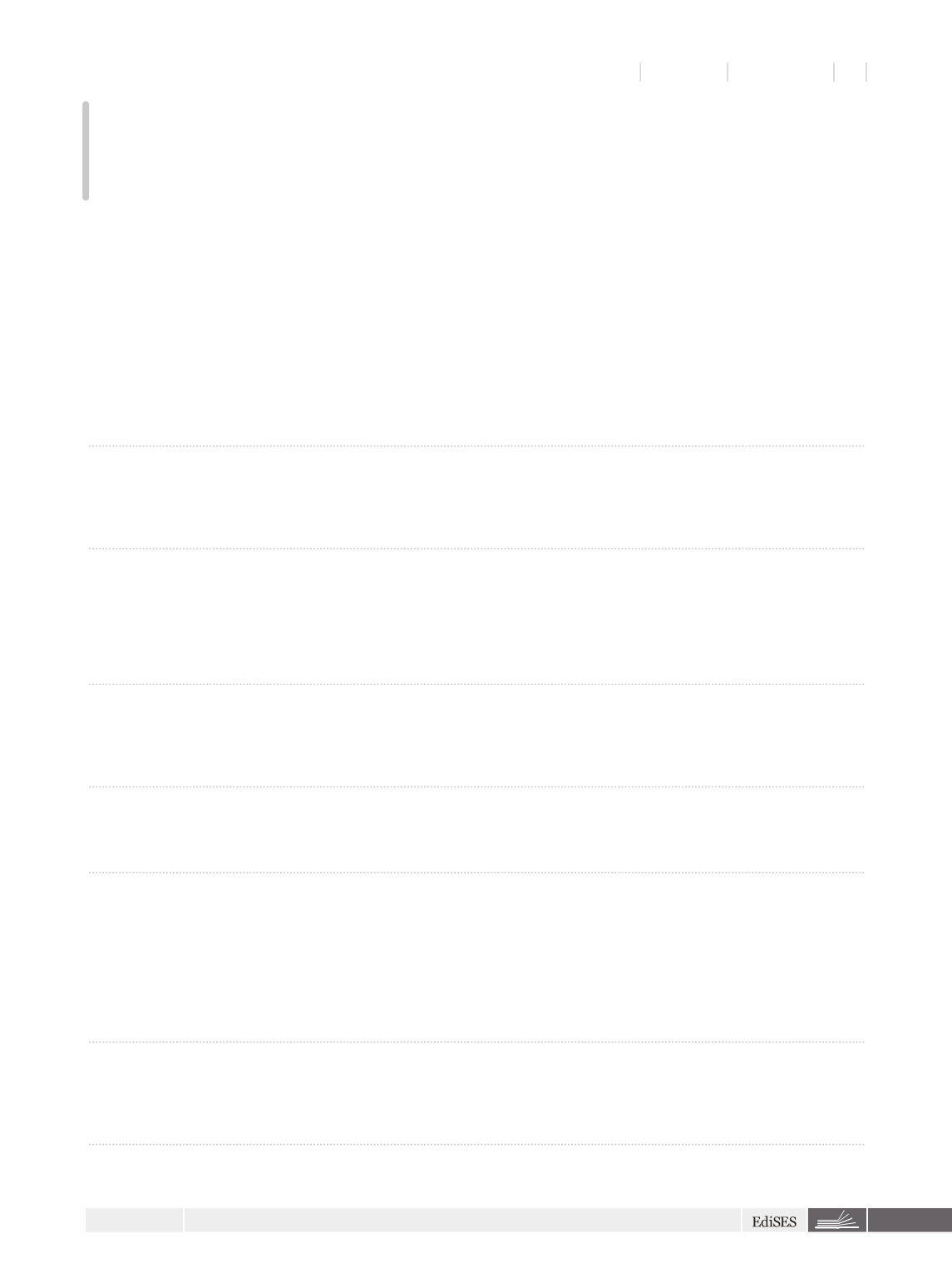
www.
edises
.it
RISPOSTE COMMENTATE
CAPITOLO
37
Patologia clinica
751
RISPOSTE COMMENTATE
Patologia clinica
1) B.
La più efficace, precisa diagnosi di DNA comporterebbe l’analisi dei due geni L-iduronidasi in un individuo, cercando
qualsiasi cambiamento di sequenza di DNA (sostituzioni, delezioni, duplicazioni) che altererebbe la funzione della proteina
L-iduronidasi. Forme alternative di un gene sono chiamate alleli, e un allele che è cambiato durante la trasmissione da genitore
a figlio può essere chiamato allele mutante. Molte caratteristiche umane sono codificate da geni che occupano ciascuno una
particolare sede o locus su un cromosoma. I geni sono costituiti da segmenti di DNA che codificano l’RNA. All’interno delle
regioni codificanti ci sono segmenti di DNA che vengono trascritti e poi tradotti in proteina (esoni), e quelli che sono trascritti
ma rimossi da RNA splicing (introni). Se una mutazione del DNA produce una malattia attraverso la sua proteina alterata, come
la mutazione del gene L-iduronidasi nella sindrome di Hurler, il gene mutante può essere chiamato anormale. Gli autosomi (dal
cromosoma umano 1 al 22) e i cromosomi X nelle femmine hanno due loci omologhi in ogni individuo, ospitando due alleli
identici (omozigoti) o diversi (eterozigoti). I maschi hanno un solo cromosoma X e spesso solo un allele per ogni cromosoma
sessuale perché il cromosoma Y ha materiale di codifica minimo. Il completo set di materiale genetico (tutti i geni e loci) in
ogni specie biologica è chiamato genoma.
2) B.
Nel modello classico a doppia elica del DNA proposto da Watson e Crick, le basi puriniche (adenosina e guanina) e le basi
pirimidiniche (citosina e timina) collegate allo zucchero sono perpendicolari all’asse e paralleli tra loro. Sono appaiate (A a G
o T a C) e tenute insieme da legami idrogeno. I filamenti di DNA (polimeri nucleotidici) sono uniti da legami tra il 3'-idrossile
di ogni pentoso (desossiribosio) e il 5'-fosfato del suo prossimo desossiribosio. Ogni filamento che compone la doppia elica è
diverso e antiparallelo. L’estremità 3' di un filamento è di fronte alla estremità 5’del suo complemento e viceversa.
3) B.
La temperatura di fusione Tm di DNA duplex è la temperatura alla quale metà delle coppie di basi vengono denaturate. Le
coppie di basi adenina-timina (AT) hanno due legami idrogeno, in contrasto alle coppie di basi citosina-guanina (CG), che hanno
tre legami idrogeno. Molecole di DNA duplex ricche di coppie di basi AT hanno una Tm molto inferiore a quelle ricche di coppie
di basi C-G. Il DNA viene riscaldato, e le frazioni di DNA ad un maggiore contenuto di AT tendono a fondersi o denaturare prima
di quelle con un contenuto maggiore di CG. La maggior parte dei mammiferi, compresi gli esseri umani, hanno frazioni di DNA
satellite che sono altamente ripetitive e raggruppate in particolari regioni cromosomiche. I DNA satelliti sono chiamati così per
la densità alterata (banda satellitare) su centrifugazione, causata dall’elevato contenuto di G-C. La loro funzione è sconosciuta.
4) C.
Il rilascio ipotalamico di GnRH regola la produzione di gonadotropine ipofisarie, FSH e LH. La risposta dell’LH allo sti-
molo con GnRH può aiutare a differenziare tra disfunzione primaria (problemi delle ovaie o dei testicoli) e disfunzione secon-
daria (ipofisi o ipotalamo). Vengono misurati i valori di LH prima e dopo somministrazione endovena di GnRH: un successivo
aumento di LH indica che l’ipofisi ha risposto al GnRH e suggerisce un disturbo che coinvolge le ovaie o i testicoli; un mancato
aumento di LH dimostra che l’ipofisi non ha risposto al GnRH e suggerisce una malattia che coinvolge l’ipofisi o l’ipotalamo.
5) A.
L’analisi del liquido seminale è molto importante nella valutazione dell’infertilità maschile. I campioni vengono raccolti dopo
un periodo di astinenza di 2 o 3 giorni. Il volume dello sperma e la sua composizione variano ampiamente tra i maschi sani e possono
essere necessarie diverse raccolte prima di trarre conclusioni. Il normale volume dell’eiaculato varia tra 2 e 6 mL e contiene più di 20
milioni di spermatozoi per mL, con una motilità nella norma in più del 50% e morfologia regolare in più del 15% di essi.
6) B.
L’impianto di uno zigote nella parete uterina comporta l’infiltrazione dell’endometrio dal sinciziotrofoblasto. La fecon-
dazione e scissione precoce dello zigote si verificano nel tube di Falloppio della donna. Dopo circa 3 giorni, lo zigote entra nella
cavità uterina, dove subisce ulteriori divisioni oltre un periodo da 3 a 4 giorni per formare una morula di circa 60 cellule che
viene trasformata in una blastocisti costituita dal sacco vitellino ed embrione. La digestione enzimatica della zona pellucida e
l’infiltrazione dell’endometrio dal sinciziotrofoblasto, che forma lo strato esterno della blastocisti, comportano l’impianto della
blastocisti all’interno dell’endometrio, dove erode i vasi materni. Durante queste prime fasi dell’embriogenesi, l’endometrio è
stimolato dal progesterone secreto dal corpo luteo nell’ovaio in risposta alla secrezione ipofisaria delle gonadotropine. Dopo
10-15 giorni, le gonadotropine placentari mantengono il corpo luteo fino alla sintesi da parte della placentare di progesterone,
intorno a 6 a 8 settimane di gestazione.
7) D.
La gonadotropina corionica è una glicoproteina, prodotta esclusivamente dal trofoblasto placentare, strutturalmente co-
stituita da due subunità: alfa, comune ad altri ormoni (FSH, ecc.), e beta, ormone-specifica. È dimostrabile in piccole quantità a
8-10 giorni dalla fecondazione, raggiunge valori massimi a 60-80 giorni (600.000 UI) e diminuisce rapidamente per mantenersi
su valori minimi dal 150esimo giorno di gravidanza (20.000 UI) a 8-10 giorni dopo il parto. La sua funzione è quella di tenere
in vita il corpo luteo nei primi tempi della gravidanza.
8) A.
La secrezione continua di progesterone dal corpo luteo è essenziale per lo sviluppo del feto. Durante il primo trimestre, la
produzione placentare di HCG sostiene il corpo luteo e garantisce una secrezione continua di progesterone. Durante il secondo