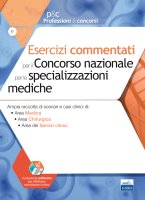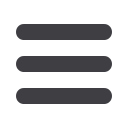
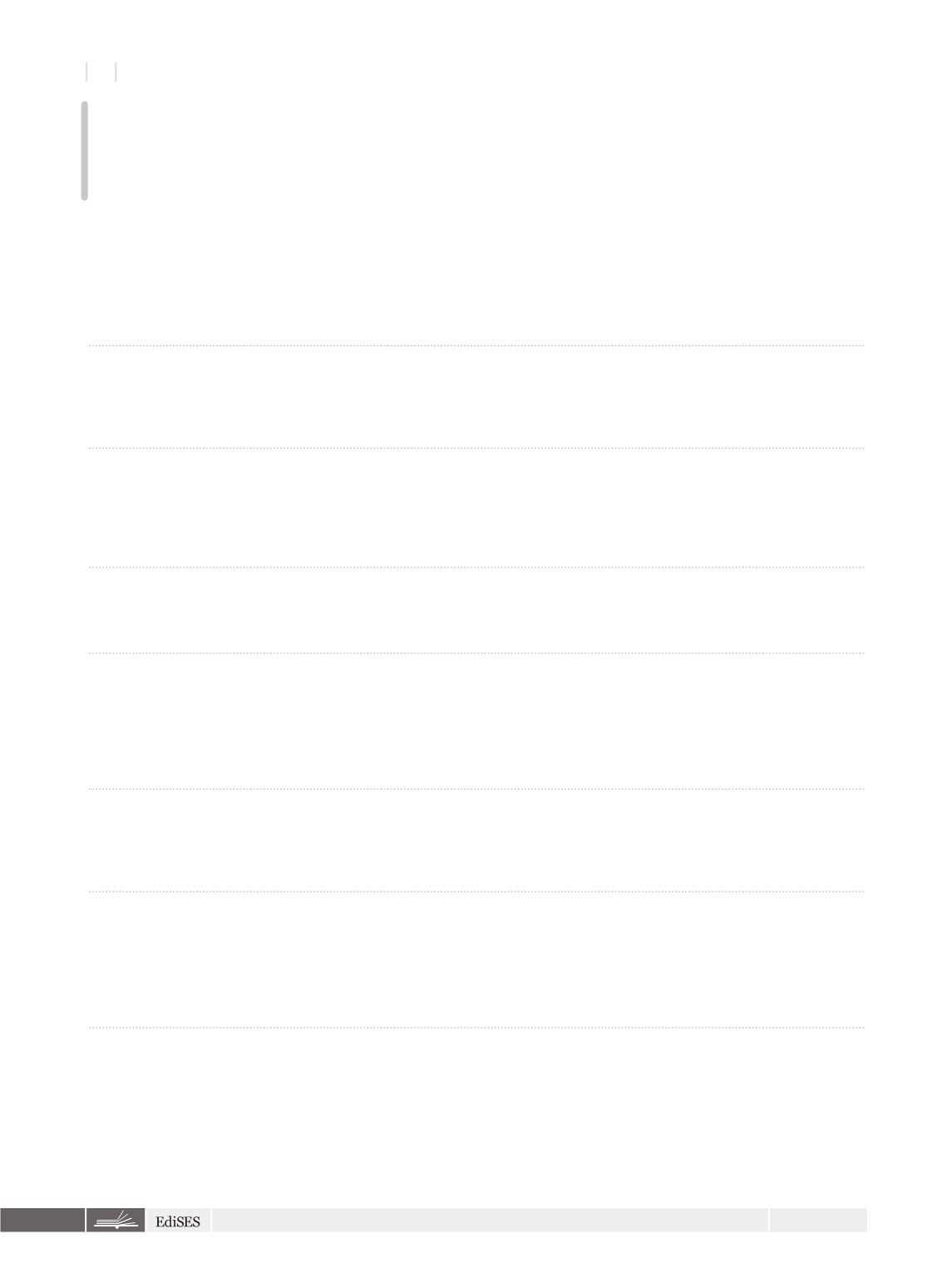
40
AREA MEDICA
www.
edises
.it
RISPOSTE COMMENTATE
Medicina dello sport
1) A.
La gittata cardiaca è il volume di sangue espulso da un ventricolo nell’arco di un minuto, di norma è la stessa per entram-
bi i ventricoli. La gittata cardiaca è data dal prodotto della gittata sistolica per la frequenza cardiaca e risulta essere pari a circa 5
litri di sangue al minuto. Dal momento che sia negli individui che praticano regolarmente sport che negli individui “sedentari”
a riposo si riscontrano valori paragonabili sia di gittata sistolica (circa 70 ml di sangue per battito cardiaco) che di frequenza
cardiaca (valori medi di 70-80 battiti al minuto) è facilmente intuibile come la gittata cardiaca a riposo in ambedue i gruppi di
individui sia assolutamente paragonabile.
2) D.
La VO
2
Max è il consumo di ossigeno in condizioni di metabolismo aerobico massimale. Essa dipende in grande misura
dalle caratteristiche genetiche del soggetto ed è migliorabile per un massimo del 20-30% con l’allenamento. Per esempio, nei
maratoneti la VO
2
Max è maggiore del 45% rispetto ai soggetti non allenati e questo è dovuto sia a fattori genetici (a questa
disciplina si dedicano soggetti con rapporto torace/taglia corporea maggiore di quello ordinario e con muscoli respiratori più
forti), che al duro allenamento a cui si sottopongono questi atleti.
3) D.
I fattori che penalizzano la prestazione in gara di un maratoneta sono: presenza di uno stato anemico, alimentazione pre-
gara povera di carboidrati e sovrappeso corporeo. Lo stato anemico determina debolezza generale e riduzione della resistenza.
Una dieta pre-gara povera di carboidrati provoca una riduzione delle scorte di glicogeno nell’organismo. Il glicogeno viene
utilizzato come fonte di energia per la contrazione muscolare, quindi, una sua carenza riduce la performance sportiva. Infine,
il sovrappeso corporeo determina un maggior dispendio energetico con conseguente riduzione della performance sportiva e
una più rapida percezione della fatica.
4) A.
Durante l’esercizio fisico intenso si ha l’aumento del metabolismo della cellula muscolare, con conseguente maggiore
produzione di anidride carbonica (CO
2
). L’aumento della pressione parziale di anidride carbonica (PCO
2
) nel sangue riduce
il pH (acidosi). A questo punto interviene, in maniera abbastanza rapida, il sistema tampone del polmone, che aumenta la fre-
quenza di ventilazione alveolare, con conseguente aumento dell’eliminazione di CO
2
e ripristino dei valori fisiologici del pH.
5) A.
La marcia (20 e 50 km) è stata inserita all’interno dei protocolli COCIS (Comitato Organizzativo Cardiologico per l’I-
doneità allo Sport) del 1995, assieme a numerose altre attività sportive (maratona, triathlon, canottaggio, canoa 500, 1000 e
10000 mt, super G e slalom gigante dello sci alpino per fare solo alcuni esempi) nel gruppo E, ossia quello che raggruppa le
attività sportive che richiedono un elevato impegno sia del cuore (in termini di frequenza e intensità del lavoro di pompa) che
dell’apparato circolatorio (che deve lavorare “contro” elevate pressioni e volumi). Queste attività sportive prevedono un livello
di rischio da medio a elevato, sul piano delle risposte emodinamiche che possono risultare importanti in specifiche malattie o
anomalie cardiovascolari.
6) B.
I segni di preeccitazione ventricolare sono determinati dalla presenza di fasci di fibre di miocardio comune che colle-
gano in maniera diretta gli atri ai ventricoli, costituendo delle vie di conduzione atrioventricolare anomale, che permettono il
passaggio dell'impulso in maniera indipendente dal nodo atrioventricolare favorendo così l'innesco di aritmie da rientro. In
questi soggetti è opportuno effettuare uno studio elettrofisiologico, per definire la sede della via anomale, verificare l'inducibi-
lità delle tachiaritmie e procedere a eventuale ablazione transcatetere.
7) C.
Gli adattamenti cardiocircolatori all’esercizio fisico assumono caratteristiche differenti a seconda se si svolga un’attività
aerobica (di resistenza o dinamica) o un’attività anaerobica (di potenza o isometrica). Durante l’esercizio fisico isometrico (ad
esempio il sollevamento pesi):
– l’aumento della frequenza cardiaca è minore e di durata più breve rispetto a quello che si registra nell’esercizio di resistenza;
– aumentano le resistenze vascolari arteriose totali per effetto dell’intensa vasocostrizione;
– il ritorno venoso dalla periferia è ostacolato per aumento della pressione all’interno del torace;
– aumentano significativamente sia la PAS che la PAD con incremento dunque della pressione arteriosa media.
8) C.
Secondo le linee guida COCIS 2009 ai pazienti con sindrome del QT lungo congenita è controindicato ogni tipo di
attività sportiva agonistica (anche in assenza di aritmie ventricolari maggiori documentate). La sindrome del QT lungo è una
malattia caratterizzata da un valore di QT corretto maggiore di 440 ms nell’uomo e 460 ms nella donna. Essa può essere conge-
nita o acquisita. La forma congenita è dovuta a mutazioni dei geni che codificano per i canali del sodio e del potassio. Le forme
più comuni sono: KCNQ1 che determina la variante LQT1 (canale IKs), HERG che determina la variante LQT2 (canale IKr)
e SCNSA che determina la variante LQT3 (canale I Na). Le forme acquisite sono dovute a disordini elettrolitici (ipokaliemia e
ipocalcemia), farmaci (chinidina, amiodarone, eritromicina, amitriptilina). Le manifestazioni cliniche sono rappresentate da:
tachicardia ventricolare detta a torsione di punta, palpitazioni, sincope che possono degenerare in fibrillazione ventricolare e
morte improvvisa. I fattori scatenanti sono lo sforzo fisico (LQT1), gli stimoli emotivi (LQT2), e la bradicardia (LQT3).