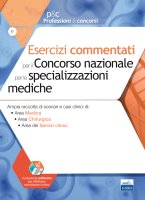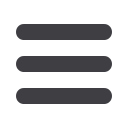
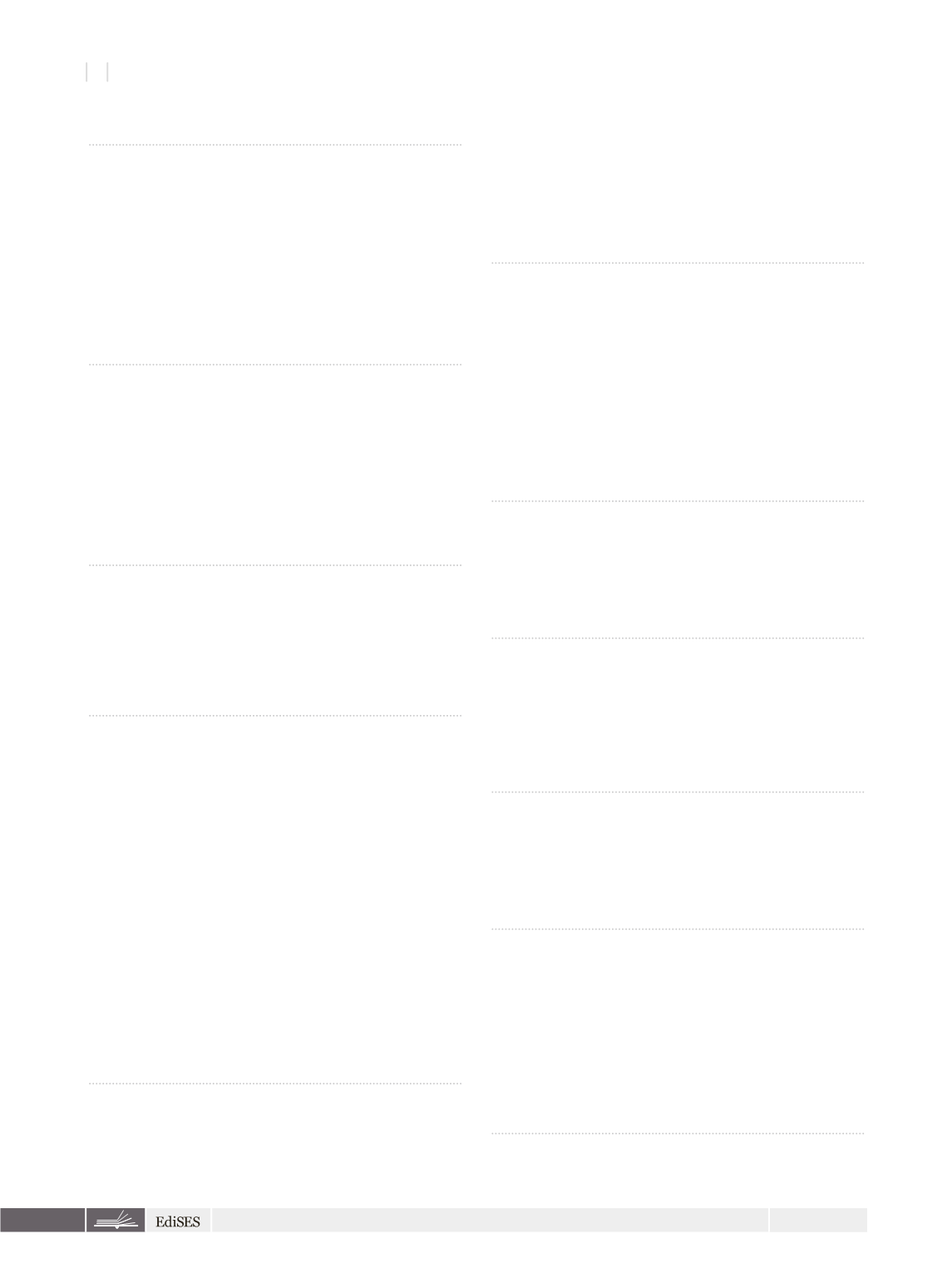
4
AREA MEDICA
www.
edises
.it
E. preparo un accesso venoso e somministro un bolo di 500
mL di fisiologica
12) Il
ruolo
della
defibrillazione
ventricolare
nella
riani-
mazione pediatrica:
A. è prioritario rispetto a qualunque altra manovra, perché
la fibrillazione ventricolare rappresenta la causa prima
di arresto cardiocircolatorio nel neonato secondaria ad
anossia post-partum
B. non va mai effettuata, perché può causare gravi ustioni
sulla pelle del neonato particolarmente sensibile
C. ha un ruolo secondario rispetto alla disostruzione delle
vie aeree
D. può innescare crisi convulsive e stato di male epilettico
E. nessuna delle alternative è corretta
13) Nel
calcolare
l’area
della
superficie
corporea
di
un’u-
stione
è
importante
ricordare:
A. il palmo della mano e le dita rappresentano circa il 5%
della superficie corporea ustionata
B. nel neonato l’intera testa rappresenta il 18% della superficie
corporea ustionata, mentre nell’adulto rappresenta solo il 9%
C. il perineo non è considerato nella misurazione dell’area
della superficie corporea
D. la regola del 9 è uguale sia per gli adulti che per i bambini
E. solo le ustioni di III grado sono considerate nel calcolo
dell’area della superficie corporea
14) Dopo
aver
calcolato
il
fluido
necessario
per
rianimare
un paziente ustionato, qual è
la velocità consigliata per
som-
ministrare
il fluido?
A. ½ nelle prime 8 ore, poi ½ nelle successive 16 ore
B. ¼ nelle prime 4 ore, poi ¾ nelle successive 16 ore
C. ½ nelle prime 12 ore, poi ½ nelle successive 12 ore
D. Tutti i fluidi somministrati in un unico bolo
E. 250 ml/h
15) Un
paziente
di
67
anni,
dializzato
peritoneale
da
3
anni,
si
presenta
al
Pronto
Soccorso
con
febbre
a
37.8°C,
brivido
da
5
giorni
e
leucocitosi. Qual
è
il
corretto
atteg-
giamento
che
il medico del Pronto
Soccorso deve
tenere di
fronte
a questo
caso?
A. dopo aver escluso altre possibili cause di sepsi, deve porre
il paziente sotto antibiotici ad ampio spettro, compren-
denti i gram negativi, ed allertare immediatamente il ne-
frologo ed il chirurgo per la rimozione, il prima possibile,
del tubo per la dialisi peritoneale
B. deve porre il paziente in osservazione nell’attesa che si
manifestino segni/sintomi peritoneali, senza i quali non
è possibile porre una diagnosi di sepsi addominale
C. deve effettuare la Rx diretta dell’addome e l’ecografia,
eventualmente ripetendoli a 12 e 24 ore per evidenziare
la presenza di una perforazione (anche coperta)
D. dopo aver escluso altre possibili cause di sepsi, deve effet-
tuare immediatamente terapia antibiotica a largo spettro
intra-addominale
E. deve inviare il paziente ad effettuare una TC addome non
appena compaiono segni addominali
16) La
sepsi è definita
come un’infezione
accompagnata da
sindrome
reattiva
infiammatoria
sistemica
(SIRS),
ovvero
almeno due
tra:
A. FC >90 b/min, FR >40 a/min oppure paCO
2
<22 mmHg,
TC <36°C oppure >38°C; Globuli bianchi <4.000 o
>12.000/mm
3
B. FC >90 b /min, FR >20 a/min oppure paCO
2
<32 mmHg,
TC <35°C oppure >40°C; Globuli bianchi <4.000 o
>12.000/mm
3
C. FC >90 b/min, TC <36°C oppure >38°C; Globuli bianchi
<4.000 o >12.000/mm
3
D. FC >90 b/min, FR >20 a/min oppure paCO
2
<32 mmHg,
TC <36°C oppure >38°C; GB <4.000 o >12.000/mm
3
E. FC >90 b/min, FR >20 a/min oppure paCO2 <32 mmHg,
TC <36°C oppure >38°C.; GB <4.000 o >12.000/mm
3
17) Quali
sono
le
variazioni
emodinamiche
presenti
nello
shock
ipovolemico?
A. ipotensione, bradicardia, resistenze periferiche normali o
ridotte, bassa pressione venosa centrale
B. ipotensione, tachicardia, resistenze periferiche aumenta-
te, bassa pressione venosa centrale
C. pressione arteriosa normale o aumentata, frequenza car-
diaca normale o diminuita, resistenze periferiche ridotte,
alta pressione venosa centrale
D. ipotensione, tachicardia, resistenze periferiche diminui-
te, bassa pressione venosa centrale
E. non ci sono alterazioni emodinamiche, perché vengono
messi in atto meccanismi di compenso
18) Quale
tra
le
seguenti
caratteristiche
differenzia
lo
shock
settico dallo
shock
ipovolemico?
A. astenia
B. tachicardia
C. tachipnea
D. cute calda
E. sopore
19) Quale
tra
le
seguenti
condizioni
emodinamiche
si
ca-
ratterizza
per
una marcata
riduzione
delle
resistenze
peri-
feriche
sistemiche?
A. shock ipovolemico
B. edema polmonare acuto
C. shock settico
D. shock emorragico
E. shock cardiogeno
20) La noradrenalina
è un
farmaco:
A. che può trovare indicazione nel trattamento dello shock
settico
B. ad azione alfa-litica
C. utile nel trattamento della crisi asmatica
D. nefrotossico
E. nessuna delle alternative è corretta
21) Quale dei
seguenti
fattori aumenta
(aumentano) la pro-
babilità di
sopravvivenza
in
caso di
arresto
cardiaco?
A. pazienti che hanno un arresto con testimoni
B. pazienti che ricevono la rianimazione cardio-polmonare
(RCP) dai presenti
C. pazienti che ricevono la rianimazione avanzata (ACLS =
Advanced Cardiac Life Support) dal personale del siste-
ma sanitario entro 10 minuti dall’insorgenza
D. pazienti che si presentano con un ritmo iniziale di fibril-
lazione ventricolare
E. tutte le alternative sono corrette
22) A
quali
intervalli
di
tempo
va
somministrata
l’adrenalina
nell’arresto
cardiaco durante
le manovre di
rianimazione?
A. ogni 3-5 minuti