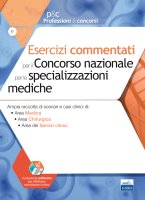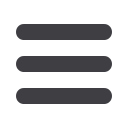
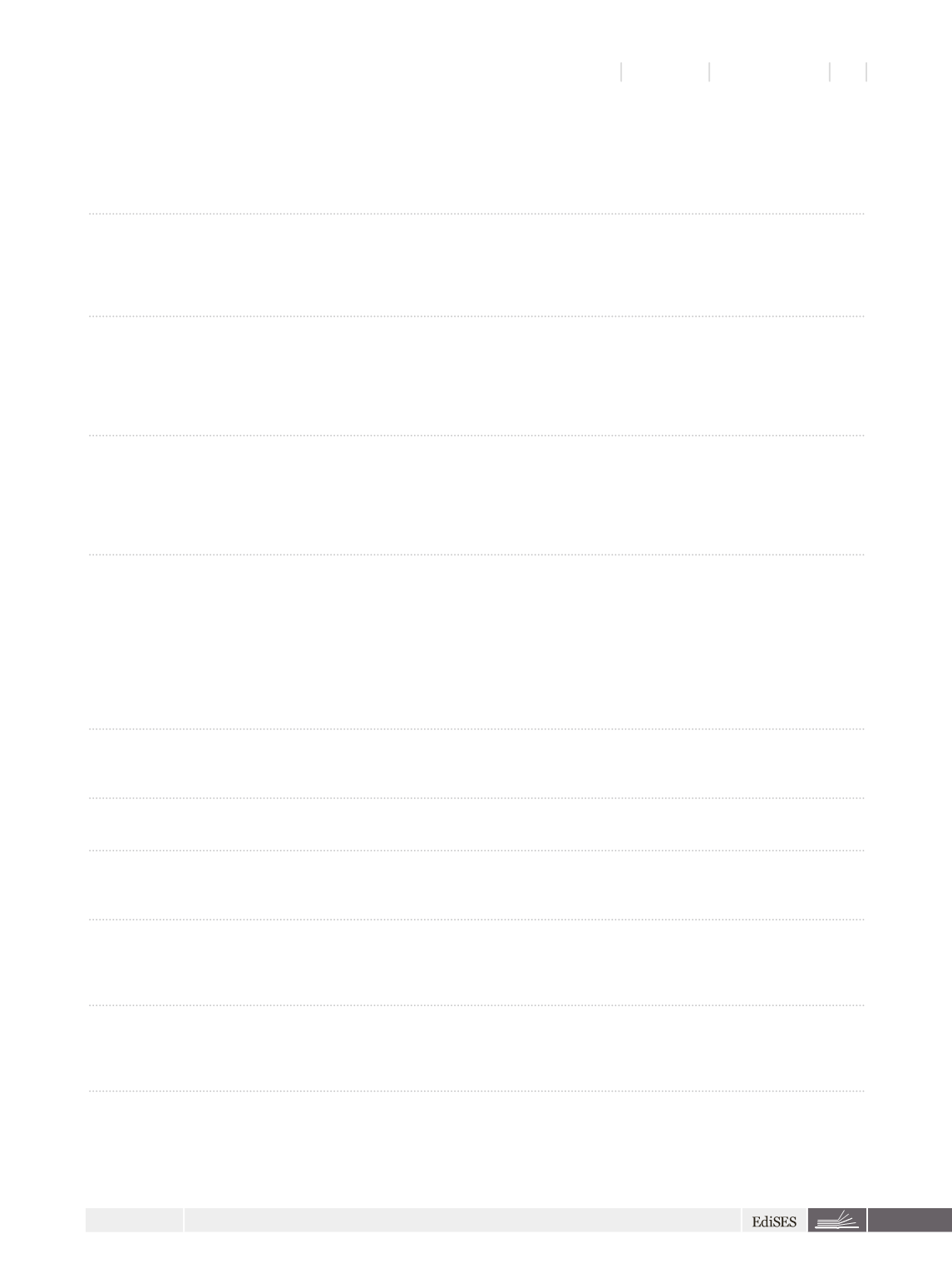
RISPOSTE COMMENTATE
CAPITOLO
20
Chirurgia generale
379
www.
edises
.it
136) C.
Il vomito ripetuto nella SIP provoca deplezione di liquidi, acido cloridrico e potassio. L’organismo bilancia la per-
dita di cloruri con aumento dei bicarbonati che porta ad alcalosi metabolica. Il rene compensa eliminando urine alcaline
(incremento dei bicarbonati urinari) con perdita anche di sodio e potassio. Se il vomito persiste, nel tentativo di espandere
il volume circolante, il rene riassorbe sodio e acqua con perdita di potassio. Ne consegue ipokaliemia e aciduria paradossa.
L’azotemia si eleva per disidratazione. Il respiro si fa superficiale ed irregolare nel tentativo di correggere l’alcalosi. La
facies
del bimbo disidratato è tipica, con occhi e fontanelle infossate e mucosa orale secca.
137) A.
La stenosi ipertrofica del piloro si manifesta tipicamente intorno alle 3 settimane di vita e provoca una perdita di peso
e una disidratazione del paziente che è impossibilitato ad alimentarsi per ostruzione funzionale del piloro. La terapia consiste
in un riequilibrio idroelettrolitico del paziente seguito dall’intervento correttivo: la piloromiotomia extramucosa secondo
Fredet-Ramsted. L’intervento consiste nell’incisione a lama fredda della sierosa pilorica nella sua parete anteriore, seguita
dalla divaricazione dei piani muscolari fino ad identificare la mucosa che ernia attraverso la breccia.
138) D.
Il vomito ripetuto nella SIP provoca deplezione di liquidi, acido cloridrico e potassio. L’organismo bilancia la per-
dita di cloruri con aumento dei bicarbonati che porta ad alcalosi metabolica. Il rene compensa eliminando urine alcaline
(incremento dei bicarbonati urinari) con perdita anche di sodio e potassio. Se il vomito persiste, nel tentativo di espandere
il volume circolante, il rene riassorbe sodio e acqua con perdita di potassio. Ne consegue ipokaliemia e aciduria paradossa.
L’azotemia si eleva per disidratazione. Il respiro si fa superficiale ed irregolare nel tentativo di correggere l’alcalosi. La
facies
del bimbo disidratato è tipica, con occhi e fontanelle infossate e mucosa orale secca.
139) D.
Il vomito ripetuto nella SIP provoca deplezione di liquidi, acido cloridrico e potassio. L’organismo bilancia la per-
dita di cloruri con aumento dei bicarbonati che porta ad alcalosi metabolica. Il rene compensa eliminando urine alcaline
(incremento dei bicarbonati urinari) con perdita anche di sodio e potassio. Se il vomito persiste, nel tentativo di espandere
il volume circolante, il rene riassorbe sodio e acqua con perdita di potassio. Ne consegue ipokaliemia e aciduria paradossa.
L’azotemia si eleva per disidratazione. Il respiro si fa superficiale ed irregolare nel tentativo di correggere l’alcalosi. La
facies
del bimbo disidratato è tipica, con occhi e fontanelle infossate e mucosa orale secca.
140) B.
L’esame ecografico è l’indagine di elezione per la SIP. È di elevata sensibilità e specificità ed è facilmente ripetibile. I
falsi negativi sono minimi e rilevati nelle fasi iniziali della patologia (motivo per cui, nel caso di diagnosi ecografica dubbia,
è consigliabile ripetere l’esame a distanza). L’ecografia permette di identificare l’oliva pilorica che appare, in sezione trasver-
sale, come immagine “a coccarda” (muscolare ispessita anecogena e mucosa iperecogena). Si possono anche apprezzare l’au-
mento della peristalsi e la difficoltà allo svuotamento gastrico. La protrusione del piloro ispessito nel bulbo duodenale viene
identificato come il “segno della cervice”. Per la diagnosi di SIP vengono presi in considerazione 3 parametri:
– diametro trasverso massimo del piloro > 1.2-1.5 cm (normale < 1 cm);
– lunghezza del canale pilorico > 1.8 cm (normale 1.2-1.5 cm);
– spessore del muscolo pilorico > 4 mm (normale = 2 mm).
141) B.
Il paziente con SIP è generalmente un lattante nato a termine che presenta vomito a getto tra la terza e la sesta set-
timana di vita, raramente dopo il quarto mese. Nei prematuri l’esordio è più insidioso, e si verifica dalla prima settimana di
vita fino ad oltre il terzo mese.
142) C.
L’adenocarcinoma della testa del pancreas, quando resecabile può infiltrare il duodeno e/o il coledoco. La non rese-
cabilità è data dall’infiltrazione dei vasi mesenterici superiori, dell’aorta o vena cava.
143) A.
Il segno di Courvoisier-Terrier è la presenza di colecisti palpabile (dilatata), associata ad ittero colestatico, cioè da
compressione della via biliare. Essa è tipica delle ostruzioni neoplastiche al di sotto del dotto cistico. Si manifesta senza dolore
in quanto l’ostruzione lenta e progressiva comporta la distensione della colecisti nell’arco di settimane o mesi.
144) C.
Quando il coledoco è ostruito da una massa neoplastica, il deflusso della bile dalla colecisti al duodeno è ostacolato.
Da ciò deriva che la bile refluisce verso la colecisti e si accumula, portando ad una progressiva distensione del viscere. L’in-
grandimento volumetrico porta a dolore, mentre all’esame obiettivo, soprattutto in soggetti magri, sarà possibile apprezzare
palpatorialmente la colecisti al di sotto dell’arcata costale destra (segno di Courvoisier-Terrier).
145) C.
Le neoplasie cistiche del pancreas sono tumori clinicamente indistinguibili dalle controparti solide. Possono essere
distinti in forme benigne (cistoadenomi) e forme maligne (cistoadenocarcinomi). Dei primi il più frequente è il cistoade-
noma sieroso, mentre dei secondi è il cistoadenocarcinoma mucinoso. Il sarcoma è una neoplasia maligna, ma solida e non
cistica, mentre il papilloma intraduttale è una neoplasia tipica della ghiandola mammaria.
146) D
. La colecisti dilatata è una condizione che viene rilevata solitamente in seguito all’osservazione di un paziente itterico
in cui non è presente malattia litiasica delle vie biliari. Viene chiamato segno di Courvoisier-Terrier ed è suggestivo di tumore
della testa del pancreas. L’accrescimento della neoplasia determina infatti l’ostruzione delle vie biliari, nel loro decorso dietro
la testa del pancreas e davanti alla vena cava, e spiega l’ittero ostruttivo. Inoltre, la dilatazione della colecisti non avviene in
caso di calcoli incuneati poiché l’intensa flogosi riduce la distensibilità dell’organo.