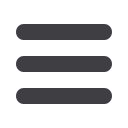

6
Scienze e tecnologie chimiche
000
www.
edises
.it
Il modello scelto da Bohr per rappresentare l’atomo di idrogeno si basava
sui seguenti postulati:
a
) l’elettrone descrive delle orbite circolari, attorno al nucleo;
b
) sono permesse solo quelle orbite per le quali il
momento
angolare
dell’elet-
trone, mvr, è un multiplo intero di h/2
p
(m rappresenta la massa dell’elet-
trone, v la sua velocità, r è il raggio dell’orbita ed h è la costante di Planck);
c
) l’elettrone non irradia quando si trova in un’orbita permessa (
stato
stazio-
nario
). Le emissioni di radiazioni avvengono soltanto se l’elettrone passa
da un’orbita più esterna ad una più interna permessa e la frequenza della
radiazione emessa si può ricavare tramite la relazione:
=
(E – E )
h
2 1
n
dove E
2
ed E
1
sono le energie dell’elettrone in due orbite differenti ed h è
la costante di Planck.
Sulla base di questo modello Bohr calcolò i raggi e le energie delle orbite
permesse. In particolare per il raggio dell’orbita di più bassa energia detta
stato
fondamentale
, ottenne il valore di 53 pm.
Bohr determinò una relazione fra l’energia posseduta dall’elettrone, il rag-
gio dell’orbita ed un numero intero positivo n.
Lo stato a più bassa energia è quello con n = 1, mentre gli stati con energie
più alte sono caratterizzati da valori più grandi di n. Il numero intero n è chia-
mato
numero
quantico principale
.
Se un elettrone passa da un’orbita con energia E
2
ad un’orbita con energia
E
1
si avrà emissione di energia secondo l’equazione di Planck, (E
2
– E
1
) =
D
E = h
n
.
L’impiego di spettrografi a maggiore risoluzione mise in evidenza che le
righe dello spettro dell’atomo di idrogeno non erano singole ma erano in
realtà costituite da due o più linee molto ravvicinate, dette
multipletti
. L’elet-
trone non descriveva un’orbita circolare ma piuttosto un’ellisse di cui il nucleo
costituiva uno dei due fuochi. La condizione di quantizzazione delle orbite
ellittiche richiese l’introduzione di un secondo numero quantico,
l
, detto
numero
quantico
angolare
, che si aggiungeva al
numero
quantico
principale
,
n
, e poteva assumere solo determinati valori interi compresi tra 0 ed (n – 1).
Quando l’elettrone percorre la sua orbita attorno al nucleo, genera un
campo magnetico simile a quello generato da una corrente elettrica che fluisce
in una spira. Studiando gli spettri degli atomi eccitati sottoposti ad un campo
magnetico esterno, vennero osservati ulteriori sdoppiamenti delle righe spet-
trali (
effetto
Zeeman
). Per giustificare questo effetto fu necessario introdurre
un terzo numero quantico,
m
, detto
numero
quantico magnetico
, che teneva
conto del fatto che il piano dell’orbita poteva assumere solo determinate
orientazioni rispetto alla direzione del campo magnetico. Per un’orbita di


















