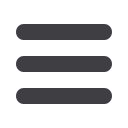

Capitolo
1
La natura della materia
3
www.
edises
.it
1.3
Le teorie atomiche
Dopo la scoperta dell’elettrone, Thomson propose un modello per interpreta-
re la costituzione dell’atomo, secondo il quale esso era costituito da una sfera
uniforme di cariche positive nella quale gli elettroni erano distribuiti come dei
granelli di pepe all’interno di una balla di cotone.
Tale modello si rivelò presto inadeguato in seguito ad alcuni esperimenti
eseguiti da E. Rutherford (1871-1937) sul potere penetrante delle
particelle
a
emesse da una sorgente radioattiva. Rutherford indirizzò un fascio di par-
ticelle
a
(nuclei di He privi di elettroni, cioè particelle “molto pesanti”, cia-
scuna dotata di due cariche positive) su una sottile lamina d’oro, e si accorse
che, nonostante la maggior parte delle particelle mantenesse la traiettoria
originale, alcune venivano fortemente deflesse o addirittura rimbalzavano
indietro.
Questo risultato era inaspettato poiché secondo il modello di Thomson la
massa e la carica dovevano essere distribuite uniformemente all’interno degli
atomi del metallo. In base a questi risultati Rutherford giunse alla conclusio-
ne che l’atomo dovesse consistere di un “nucleo” carico positivamente in cui
era concentrata tutta la massa e da elettroni posti esternamente al nucleo, in
numero tale da bilanciare la carica positiva.
Secondo Rutherford l’atomo era come un sistema planetario, con il nucleo
al posto del sole e gli elettroni al posto dei pianeti. Un tale modello, tuttavia,
rappresentava un atomo instabile. Infatti, secondo l’elettrodinamica classica,
essendo l’elettrone dotato di carica, nella sua rotazione attorno al nucleo
avrebbe dovuto continuamente dissipare energia sotto forma di radiazioni
elettromagnetiche e quindi in brevissimo tempo cadere sul nucleo. Per giu-
stificare il comportamento dei sistemi microscopici occorrerà abbandonare le
teorie della fisica classica e utilizzare i concetti della meccanica quantistica che
comincia a muovere i primi passi all’inizio del XX secolo.
È comunque utile sottolineare alcuni punti ricavati dal modello di Ruther-
ford, poiché essi sono ancora validi e riguardano essenzialmente l’ordine di
grandezza delle dimensioni del nucleo e dell’atomo.
Nel nucleo è contenuta praticamente tutta la massa dell’atomo, cioè i pro-
toni ed i neutroni (questi ultimi furono solo previsti da Rutherford) e le sue
dimensioni sono dell’ordine di 10
–12
cm. All’esterno del nucleo vi sono gli
elettroni che si trovano ad una distanza da esso che è circa 10.000 volte più
grande del raggio del nucleo. Queste dimensioni sono lontane dalla nostra
percezione. Infatti, se immaginiamo ad esempio che il nucleo sia dell’ordine
di 1 cm, in questo caso gli elettroni si troverebbero a circa 10.000 cm, cioè
a 100 metri di distanza. Quindi, come si afferma con un’espressione un po’
paradossale, l’atomo è “vuoto”. La maggior parte delle nostre conoscenze sulla
struttura degli atomi e delle molecole proviene da esperimenti nei quali avven-
gono delle interazioni tra la materia e la luce.
La luce è una forma di energia e può essere rappresentata da un insieme di
radiazioni costituite da onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio


















