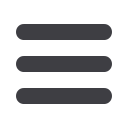
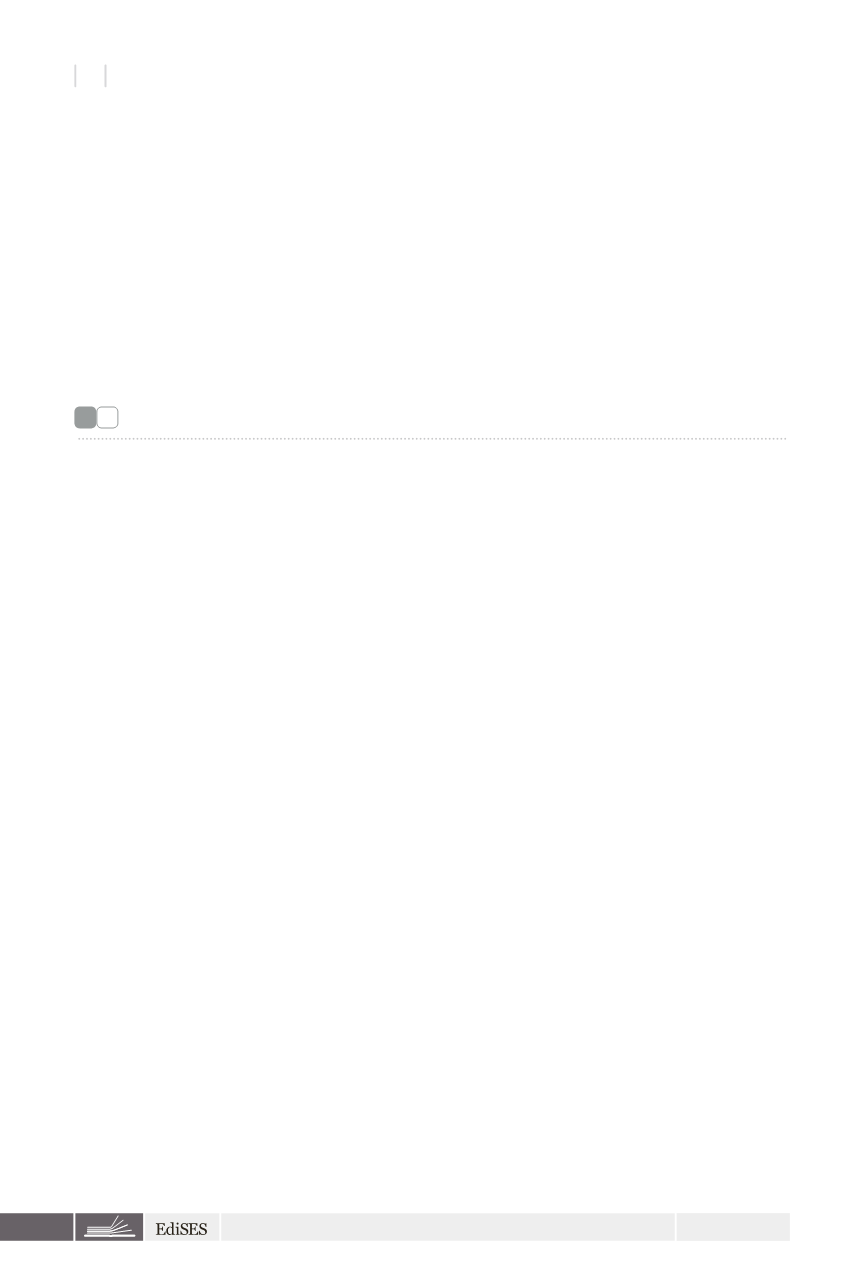
10
INTRODUZIONE
www.
edises
.it
Sotto il profilo sanzionatorio, si inseriscono, per la prima volta, le
misure di sicurezza
(
P. IV, Cap. III), applicabili congiuntamente o in sostituzione delle pene (sistema
del c.d. doppio binario).
Vengono tenuti fermi i principi garantistici di
legalità
e di
responsabilità morale
che tro-
vano in seguito riconoscimento anche a livello costituzionale.
Nell’ottica del principio di legalità e dunque della certezza del diritto, il legislatore
mira a
ridurre fortemente la discrezionalità
del giudicante: ad esempio, rispetto al codice
Zanardelli viene meno la distinzione tra le condotte dei concorrenti nel reato, si dà
ampio spazio all’istituto della responsabilità oggettiva (art. 42, co. 3, c.p.), nonché
a diverse ipotesi di presunzione legale (es. la imputabilità del reo anche in caso di
ubriachezza non derivata da caso fortuito o forza maggiore
ex
art. 92 c.p.).
1.3.3
•
La Costituzione Repubblicana
Con l’entrata in vigore della Carta costituzionale (1° gennaio 1948), trovano
ricono-
scimento costituzionale
i principi di
legalità
(art. 25) e di
colpevolezza
(art. 27, co. 1 e
3) e si individuano una serie di beni giuridici che, in dottrina, si ritengono coincidenti
con quelli tutelati dal diritto penale.
Da ciò conseguono
problemi di compatibilità
tra una serie di istituti previsti e disciplinati
nel codice Rocco e tali principi costituzionali.
Ciò vale non solo con riguardo al principio di legalità - si pensi, ad esempio, alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato di plagio (art. 603 c.p.) per vio-
lazione del principio di legalità (in tal caso specificantesi nel sottoprincipio di tassa-
tività) - ma anche e soprattutto per tutti quegli istituti che, in quanto espressione di
responsabilità oggettiva
, nell’ottica del codice che li ha introdotti dovrebbero operare a
prescindere dall’accertamento dell’elemento psicologico del reo e, dunque, in viola-
zione del principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost.: solo per citarne alcuni, può
farsi riferimento all’istituto delle condizioni obiettive di punibilità (art. 44 c.p.), al
reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116 c.p.), al mutamento
del titolo di reato per taluno dei concorrenti (art. 117).
Nella maggior parte dei casi in cui sono stati sollevati dubbi di legittimità costituziona-
le per incompatibilità tra tali norme e l’art. 27 Cost., la Corte costituzionale, piuttosto
che sancirne l’illegittimità costituzionale, ha preferito, con sentenze interpretative di
rigetto,
reinterpretare
queste norme, fornendone una
lettura costituzionalmente orien-
tata
e dunque riducendo la loro applicazione entro i limiti del principio di
colpevolezza
.
A titolo esemplificativo, può considerarsi l’art. 116 c.p.: la Corte costituzionale, al fine
di rendere tale norma compatibile col principio di colpevolezza, ha chiarito che si
risponde del reato diverso da quello voluto soltanto nel caso in cui il reato diverso
rappresenti uno
sviluppo logicamente prevedibile
della condotta inizialmente diretta a
realizzare il reato voluto (
"
P. III, Cap. III, par. 3.11).


















