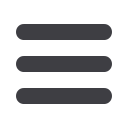
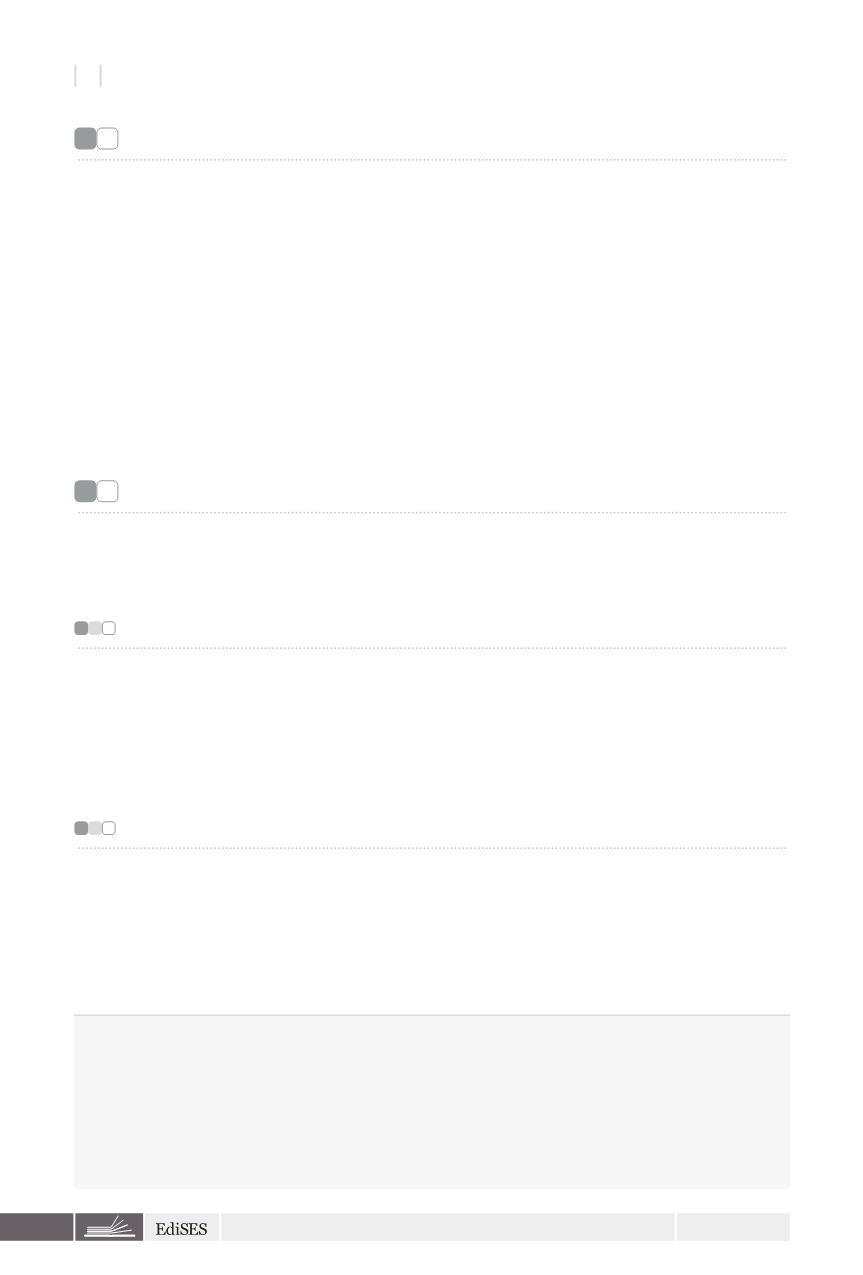
6
INTRODUZIONE
www.
edises
.it
1.2.3
•
Teoria costituzionalmente orientata
Secondo la teoria più moderna (Bricola), a fondamento della selezione dei beni me-
ritevoli di tutela penale, va posta la
Costituzione
.
In tale ottica, il bene giuridico oggetto del diritto penale deve necessariamente essere
dotato di rilevanza costituzionale.
Di fronte alle critiche di una parte della dottrina (Mantovani) che ritiene tale criterio
insufficiente
in quanto inidoneo a soddisfare le nuove esigenze di tutela derivanti dall’i-
nevitabile
evoluzione della realtà sociale
e a ricomprendere beni non ancora esistenti al
momento dell’emanazione della Costituzione, si osserva (Fiandaca-Musco) che il rilievo
costituzionale riconosciuto a tali beni potrebbe essere non solo esplicito (es. la libertà
personale tutelata dall’art. 13 Cost.), ma anche soltanto implicito (es. la fede pubblica,
la cui tutela è funzionale alla protezione del patrimonio, dell’economia e dell’ammini-
strazione della giustizia, a loro volta beni con rilievo costituzionale esplicito).
1.2.4
•
Principi
La dottrina ha individuato una serie di
principi
del diritto penale moderno, quali il
principio di materialità, di offensività, di soggettività (o colpevolezza), di sussidiarietà,
di frammentarietà, di autonomia.
Principio di materialità
Secondo tale principio, espresso nel brocardo latino
cogitationis poena nemo patitur,
non può parlarsi di reato se la volontà criminosa non si
esteriorizza
in un
comportamento
materiale
suscettibile di percezione sensoria (
nullum crimen sine actione
). Dal principio
di materialità, che secondo alcuni troverebbe riconoscimento normativo nell’
art. 25,
co. 2, Cost.
(laddove si parla di “fatto commesso”), deriva dunque che il mero
atteggia-
mento interiore
dell’individuo, sia pur dichiarato, non può integrare reato.
Principio di offensività e concezione realistica del reato
Per tale principio, il comportamento materiale che il soggetto agente pone in essere
deve essere tale da arrecare
effettivamente un’offesa
, sotto forma di lesione o di messa
in pericolo, al bene tutelato (
nullum crimen sine iniuria
). I classici esempi di condotta
inoffensiva che si fanno in dottrina sono quelli del furto del chiodo arrugginito o di un
acino d’uva.
ESEMPIO
A Tizio viene imputato il reato di cui all’art. 73, D.P.R. 9-10-1990, n. 309, in quanto
si accerta che è dedito alla coltivazione di diverse piante da cui possono ricavarsi
sostanze stupefacenti. In sede processuale però la relazione peritale attesta che,
in realtà, la sostanza stupefacente ricavabile da tali piante (nella specie, una pre-
parazione della canapa indiana), pur essendo ricompresa nelle tabelle I, II, III e
IV previste dall’art. 14 del citato D.P.R. n. 309/1990, è priva di qualsiasi ef cacia
farmacologica e, quindi, inidonea a produrre effetto drogante a causa della per-


















