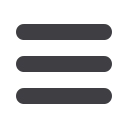

www.
edises
.it
660
Libro IV
Diritto del lavoro e legislazione sociale
Sezione II
Legislazione sociale
Tale piano d’intervento appare evidente in un signi cativo documento, la
Carta del
lavoro
del 21 aprile 1927 in cui era stata affrontata la questione della previdenza pub-
blica, che avrebbe necessitato di maggiore coordinamento ed uni cazione da parte
dello Stato, attraverso gli organi corporativi e le associazioni professionali.
All’entrata in vigore della Carta del lavoro fascista, che tra l’altro sancì l’obbligo per
gli organi dello Stato di sorvegliare l’osservanza delle leggi sulla prevenzione degli
infortuni e la polizia del lavoro, seguì l’istituzione dell’
Ispettorato corporativo
che,
con il R.D. 28 dicembre 1931, n. 1684, ampliò il campo d’intervento assumendo la
funzione di vigilanza per l’attuazione di tutta la legislazione del lavoro nelle aziende
industriali, commerciali, negli uf ci, in agricoltura, oltre al controllo sull’esecuzione
dei contratti collettivi, sulle attività previdenziali, assistenziali ed igienico-sanitarie
che le nuove leggi apprestavano a favore dei prestatori d’opera.
Venne teorizzata la concezione della
solidarietà corporativa
tra appartenenti al medesimo
gruppo o categoria, e tra datore e prestatore di lavoro. Tale concetto si prestava a giusti-
care sia l’estensione della tutela previdenziale anche ad eventi non (necessariamente)
dipendenti dallo svolgimento dell’attività lavorativa – quali l’invalidità e la malattia, o,
comunque, non incerti, come la vecchiaia e la morte – sia meccanismi redistributivi di
ricchezza interni al gruppo, capaci di mantenere sostanzialmente indenne la nanza pub-
blica da oneri economici aggiuntivi.
• In particolare, si devono alla
legislazione del ventennio fascista
:
• l’istituzione dell’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1927);
• l’istituzione dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per la gente di mare
(1929);
• l’estensione dell’assicurazione contro gli infortuni anche alle malattie professionali
(1929);
• l’istituzione degli assegni familiari
(1934);
• il riordino sia della legislazione antinfortunistica che di quella in materia di assicura-
zione per l’invalidità e la vecchiaia e di assicurazione contro la disoccupazione (1935);
• l’istituzione dell’assicurazione contro le malattie comuni (1943).
Non vanno dimenticate le fondamentali disposizioni dettate dal
Codice civile
appro-
vato nel 1942: la ripartizione tra datore e prestatore di lavoro dell’obbligo contributivo
(art. 2115), il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116), il vincolo di destina-
zione dei fondi speciali per la previdenza e l’assistenza dei lavoratori (artt. 2117 e 2123).
La tutela assicurativa venne, poi, espressamente estesa a categorie di lavoratori non
subordinati, tra i quali i soci delle cooperative e i soci prestatori d’opera delle società
anche di fatto (R.D. 1422/1924).
D’altra parte, lo spiccato interessamento dello Stato verso l’organizzazione previden-
ziale (che si manifestò anche con l’accentramento delle funzioni presso pochi enti ri-
gidamente regolamentati) fu giusti cato dall’ingente quantità di risorse nanziarie,
che, per effetto del sistema di gestione fondato sulla
capitalizzazione
, vennero accu-
mulate dagli enti previdenziali: risorse che furono ampiamente utilizzate dal regime
anche per ni diversi da quelli propri degli istituti di previdenza (opere pubbliche,
boni che agrarie, iniziative di credito fondiario, attività belliche ecc.).
















