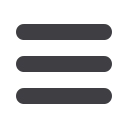

www.
edises
.it
658
Libro IV
Diritto del lavoro e legislazione sociale
Sezione II
Legislazione sociale
quell’eterogeneo complesso normativo, con il quale, per la prima volta, lo Stato otto-
centesco, abbandonando a poco a poco la sua tradizionale posizione di “neutralità”
in materia, si è determinato ad intervenire a tutela dei lavoratori e ad arginare le
spinte prorompenti del capitalismo (Cinelli).
Lo Stato liberale, infatti, non operava in alcun modo nel settore, lasciando che le
spinose questioni riguardanti il lavoro fossero tendenzialmente affrontate grazie a
forme di solidarietà autonome e volontarie, che presero il nome di
società di mutuo
soccorso
.
Tali società si fondavano sulla mutualità, sulla solidarietà ed erano strettamente le-
gate al territorio in cui nascevano: la spinta alla loro creazione e diffusione venne da
una progressiva presa di coscienza da parte dei lavoratori della propria condizione di
sfruttamento e della ricerca in sé stesse, prima ancora che nelle istituzioni politiche,
della forza e degli strumenti necessari per fare fronte al loro precario stato.
L’esperienza delle società di mutuo soccorso
entrò in crisi per le loro stesse caratte-
ristiche intrinseche, dal momento che quelle associazioni potevano essere costituite
soltanto dalle categorie più abbienti, e, quindi, coinvolgere un numero ristretto di
soggetti, con la conseguente impossibilità di costituire risorse nanziarie adeguate.
D’altro canto, si faceva sempre più forte l’interesse dello Stato a “regolamentare” il
settore, sia per esigenze di controllo sul fenomeno mutualistico (esse iniziavano ad
assumere sempre più carattere sindacale) sia per sedare le crescenti contraddizioni
sociali. Proprio le differenze sociali e i contrasti tra le classi, connessi all’economia
capitalistica, non poterono più essere ignorati dallo Stato liberale, quando la miseria
in cui versava il proletariato divenne tale da costituire una minaccia per l’assetto po-
litico instaurato e gestito dagli stessi detentori del potere economico. Peraltro i primi
interventi normativi di tutela furono nettamente repressivi. Il legislatore dell’epoca
non intese tutelare la classe operaia diseredata, bensì proteggere l’ordine sociale
esistente contro le rivendicazioni che apparivano pericolose.
Abbandonando la propria posizione di neutralità, lo Stato cominciò ad interessarsi
alla forza lavoro, razionalizzandone l’impiego
attraverso
l’introduzione di forme mi-
nime di tutela del lavoro e stabilendo alcune limitazioni, con particolare riferimento
alla durata della giornata lavorativa ed all’impiego di donne e bambini.
In concreto, tale intervento venne realizzato sia attraverso misure repressive di utilizzazioni
sostanzialmente fraudolente delle regole del diritto comune, sia attraverso norme dirette
ad incidere direttamente sul rapporto di lavoro (così, ad esempio, l’assicurazione obbliga-
toria contro gli infortuni o le leggi sul riposo settimanale), sia attraverso disposizioni più
genericamente indirizzate a migliorare le condizioni di lavoro e di vita del lavoratore (quali
quelle sul lavoro di donne e fanciulli, o sulle industrie insalubri o pericolose) (Cinelli).
1.4
L’avvento dello Stato unitario
Soltanto a partire dalla seconda metà del XIX secolo, dopo l’avvento dello Stato uni-
tario, furono avvertite realmente le esigenze di tutela della classe operaia e furono
emanate le prime leggi di carattere previdenziale.
Con la progressiva trasformazione dello Stato di matrice liberale e, di conseguenza,
con la piena e de nitiva affermazione dei diritti sociali
,
l’intervento pubblico mirava
alla diretta ed immediata soddisfazione di quei diritti.
















