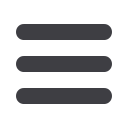

www.
edises
.it
6
Libro I
Diritto penitenziario
Volpicella, Beltrani-Scalia e Doria, direttori generali delle carceri, questi ultimi due
– il primo dal 1879 al 1898, con limitate interruzioni, e il secondo dal 1902 al 1912
– entrambi fermi sostenitori del sistema auburniano e, per le pene più lunghe, del
sistema progressivo irlandese.
Già dai primi dell’Ottocento era andata formandosi, in special modo fra gli studiosi
italiani, una
scienza delle prigioni
impegnata nella ricerca di nuovi modelli strutturali
di carcere, sia sotto il profilo disciplinare che architettonico, al fine di realizzarne la
funzione rieducativa e risocializzante. Se si accettava che la recidiva aveva la sua causa
principale nelle orribili condizioni delle prigioni, la ricerca dei necessari correttivi im-
poneva una diversa concezione della fase di esecuzione della pena. Questa fase doveva
essere caratterizzata dall’isolamento non continuato, dal lavoro e dall’istruzione, oltre
che da condizioni seppur minime di benessere fisico, igienico e sanitario dei detenuti.
Sarebbe stata funzionale, alla realizzazione di tutto ciò, l’edificazione di nuove strut-
ture architettoniche, sul
modello del Panopticon
ideato da Jeremy Bentham nel
1791: edifici a pianta stellare (o a raggiera), fatti di bracci di celle e posti di guardia
(collocati su rotonde) da cui i carcerieri avrebbe potuto vigilare su tutte le celle.
Se nella
scuola classica
la pena è concepita come
misura afflittiva
, personale, inderogabile e
proporzionata alla gravità del reato – sia che si consideri la sanzione come
retribuzione morale
del male commesso (Grozio, Kant, Bettiol), sia che la si consideri come
retribuzione giuridica
a mezzo della quale lo Stato riafferma l’ordinamento violato (Carrara, Hegel, Messina, Pes-
sina, Rossi) –, nella
scuola positiva
la pena, più che punire l’autore del reato, deve tendere
al suo
riadattamento sociale
e, secondo Grolmann, a correggere “moralmente” il reo, ridu-
cendone l’inclinazione a violare la legge, con l’ovvia conseguenza che può essere definito
«reo», e quindi imputabile, solo chi è “rieducabile”, mentre gli “incorreggibili”, rispetto ai
quali sarebbe inutile qualunque percorso di rieducazione, devono semplicemente essere
neutralizzati e rinchiusi al fine di proteggere la collettività.
Spetta ai migliori esponenti della scuola positiva (Ferri, Garofalo, Lombroso, Pessina) il me-
rito di aver focalizzato l’indagine sul reo piuttosto che sul reato, al fine di puntare l’atten-
zione sul
detenuto in quanto persona
,
sulle sue individualità e sulle cause che l’hanno indotto
a delinquere, così da poter concepire il carcere come luogo destinato alla sua
rieducazione
.
1.4
Il diritto penitenziario
L’esistenza di un diritto penitenziario, quale complesso di norme legislative e re-
golamentari che disciplinano le modalità di esecuzione della pena detentiva e, se-
gnatamente, delle sanzioni penali costituenti privazione o limitazione della libertà
personale, fu ufficialmente riconosciuta coi lavori di due successive Commissioni pe-
nitenziarie internazionali, istituite nel 1890 e nel 1929.
Nel vigente ordinamento penale, il diritto penitenziario disciplina
sul piano formale
(Rubino):
>
>
la detenzione per
condanna a pena privativa della libertà
;
>
>
la detenzione per
sottoposizione a misure di sicurezza detentive
(assegnazione a una co-
lonia agricola o a una casa di lavoro, ricovero in una casa di cura e custodia, in un
ospedale psichiatrico giudiziario o in un riformatorio giudiziario);
>
>
la detenzione dipendente da
custodia cautelare
.
















