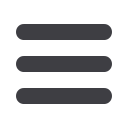

www.
edises
.it
4
Libro I
Diritto penitenziario
sulle patrie galere. Si può invece considerare la
workhouse
come l’embrione del carce-
re moderno, un luogo di rieducazione, nonostante i carcerieri fossero autorizzati a
reprimere duramente gli atti di insubordinazione e, non di rado, i vagabondi laceri e
debilitati, inabili al lavoro, raccattati nelle vie e condotti a forza di braccia nella casa
di correzione, vi fossero lasciati morire di fame sui tavolacci delle celle.
Di fronte all’aggravamento dei fenomeni criminali, fra il XVI secolo e il successivo,
si aprì in molti altri Paesi europei una riflessione profonda sull’efficacia deterrente
delle pene corporali, compresa quella dell’esecuzione capitale, e cominciò a farsi
strada l’idea di sostituirle con la detenzione in carcere.
Alcuni istituti correzionali “modello” nacquero in Italia proprio a partire dal XVII se-
colo: le Carceri Nuove in via Giulia a Roma (più tardi Clemente XI istituirà una casa
di correzione per ragazzi “discoli”, in piazza di Porta Portese); a Milano, nel corso
del XVIII secolo, videro la luce una casa di correzione per i colpevoli di reati minori,
detenuti in cellette individuali, e un ergastolo destinato ai condannati per reati gravi
(questi carcerati erano utilizzati per lavori di pubblica utilità); a Firenze, lo Spedale
di San Filippo Neri accoglieva, in luogo separato e celle singole, ragazzi minori di
16 anni con problemi di disadattamento (“che la notte dormivano per le strade, nei
cimiteri, nelle osterie”), al fine di “rivestirli, nutrirli, medicarli, trovar loro un lavoro
in botteghe esterne o in officine interne e istruirli nel santo timore di Dio”. Il sistema
delle celle individuali, già adottato ad Amsterdam nella casa di detenzione e lavoro
di Rasp-Huis (così chiamata perché l’attività lavorativa fondamentale era quella di
grattugiare il legno con una sega fino a farne una polvere utilizzata per tingere i fila-
ti) aperta nel 1596, permetteva di prevenire, grazie all’isolamento notturno, i danni
morali della promiscuità.
Ma, fatte queste eccezioni, la pena della reclusione continuerà a essere ispirata al
concetto di vendetta sociale, gareggiando per sofferenza con le pene corporali (Ge-
rardi): le condizioni di vita, all’interno delle carceri italiane, resteranno general-
mente disumane e aberranti, come a Napoli quelle del carcere della Vicaria o, anco-
ra, del monumentale Albergo dei Poveri, fra le più grandi costruzioni settecentesche
d’Europa, voluta da Carlo III di Borbone come istituzione caritatevole destinata a
dare asilo ai derelitti e agli orfani del regno e divenuto nel tempo un vero e proprio
reclusorio.
1.2
I fermenti illuministici
Con l’istituzionalizzazione della pena detentiva nasce, in seno alle dottrine giuridi-
che illuministe, l’idea che la prigione non debba essere un luogo di sofferenza ma
piuttosto di “rigenerazione”. Si comincia a parlare di “proporzione” o “equivalenza”
fra il crimine commesso e la pena, la quale deve essere inflitta nei limiti della giu-
stizia. Si afferma il principio della pena come strumento di prevenzione e sicurezza
sociale e si fa strada il principio di “umanizzazione” del trattamento, censurando del
carcere tutti quegli aspetti che nelle società dell’antico regime l’avevano caratteriz-
zato come sede di crudele prigionia (tortura, assenza di igiene e di luce, promiscuità
ecc.).
Il dibattito sulla finalità della detenzione, insieme a quello sull’abolizione della pena
di morte, poté trarre nuova linfa dalla pubblicazione, nel 1764, del volume
Dei delitti
















