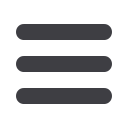
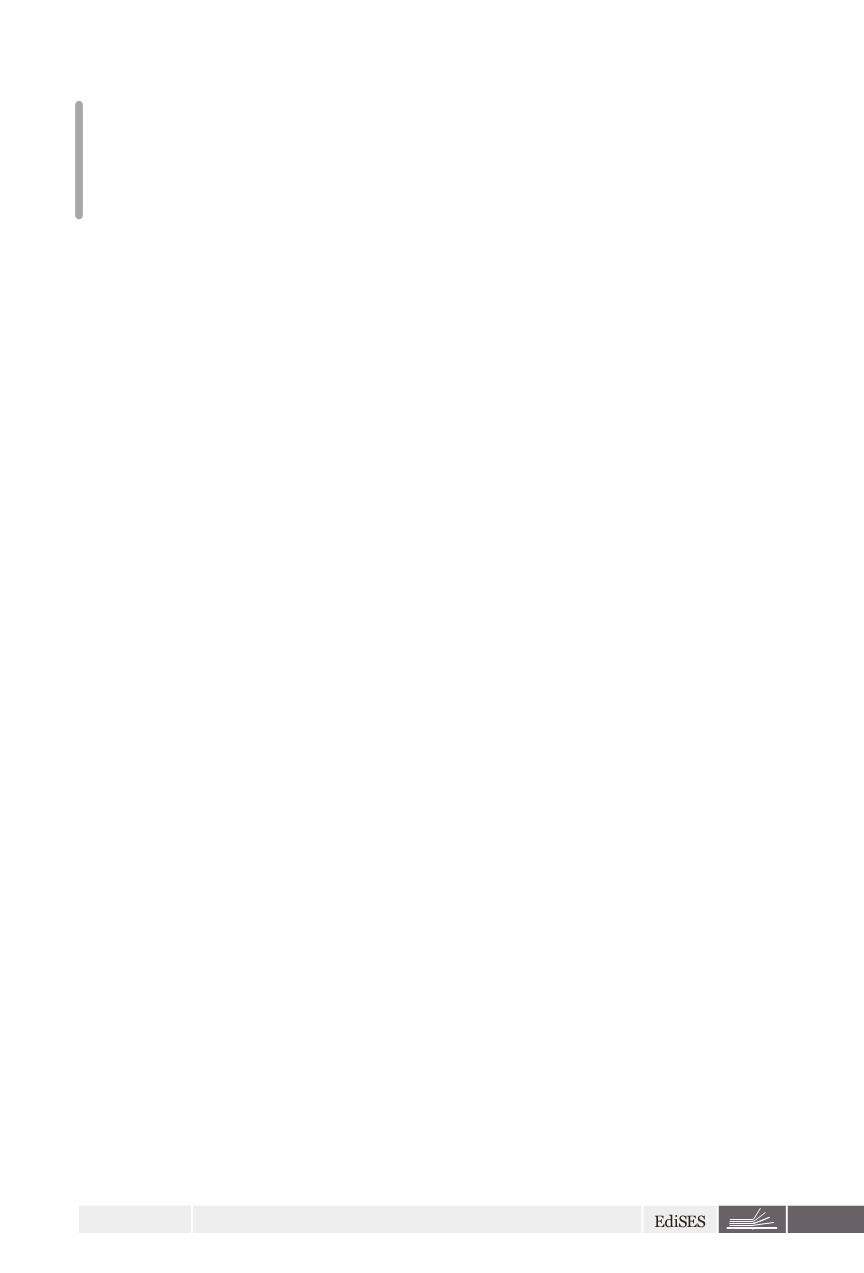
www.
edises
.it
Capitolo 1
L’origine dell’istituzione penitenziaria
1.1
Dal sistema punitivo romano alle prime carceri dell’età
moderna
Il sistema penale romano non utilizzava la carcerazione come misura punitiva, ma
piuttosto come strumento preventivo di coercizione, qualcosa di simile all’odierna
“custodia cautelare”, per assicurare il reo alla giustizia. Ciò in un ordinamento nel
quale le azioni delittuose commesse contro l’intera comunità (cd.
crimina
) erano per-
seguite, secondo la gravità del fatto, con
pene corporali
– prima fra tutte l’esecuzione
capitale (comminata, per esempio, per il reato di alto tradimento o lesa maestà o,
ancora, per l’uccisione di un uomo libero) – o con
pene non corporali
, come l’esilio, il
confino, la confisca del patrimonio o di parte dei beni (confino e confisca, per esem-
pio, venivano comminate per il crimine di adulterio).
L’istituto della reclusione, dunque, quale sanzione per i reati commessi, era scono-
sciuto al diritto criminale romano, come lo era per altri ordinamenti dell’evo antico:
il carcere (o prigione) non era un luogo di espiazione, ma era il luogo atto a “impedi-
re la fuga” di colui al quale doveva essere inflitta una pena mediante processo.
Si trattava, evidentemente, di una funzione ben diversa da quella dei penitenziari
contemporanei e che, dopo la caduta dell’impero romano d’Occidente, la prigione
continuò ad avere nell’ordinamento feudale, sia pure all’interno di un sistema che
vedeva la giustizia amministrata non più da un potere centrale, ma dal feudatario,
autoritario e dispotico, titolare di un feudo sul quale era chiamato a esercitare, se-
condo il proprio arbitrio e quasi sempre con modalità sommarie, una giurisdizione
largamente fondata sulla categoria etico-giuridica del “taglione”, che imponeva al
colpevole, come pena, la stessa sofferenza che egli aveva fatto subire alla vittima.
Scopo della punizione – corporale o meno che fosse – non era quello di “redimere” il
condannato, né quello di “rieducarlo”, ma piuttosto di “vendicare” l’offesa arrecata e,
più in generale, ripagare la violazione delle “regole” imposte dal signore a chiunque
si trovasse sui suoi domini.
L’idea che la pena servisse solo a “pareggiare i conti”, e che la carcerazione, non di
rado associata alla tortura, non avesse nessuna altra utilità che quella di indurre il
condannato a dichiararsi colpevole, onde utilizzare la confessione come prova, co-
minciò a perdere campo poco dopo la metà del XVI secolo, quando in Inghilterra
nacque la prima “casa di correzione” o
workhouse
: nel 1557, per volere della Corona,
il palazzo di Bridewell fu adibito a reclusorio per ladri, prostitute, vagabondi e altri
derelitti condannati per aver violato la legge e che avrebbero dovuto “riformarsi”
attraverso il lavoro e una ferrea disciplina.
Il fenomeno, antichissimo, dello sfruttamento dei prigionieri per l’esecuzione di la-
vori “pesanti”, in condizioni generalmente “disumane”, per l’espiazione dei delitti
commessi, conobbe forme impietose come la deportazione nelle colonie e la servitù
















