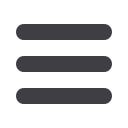

3.4 Descrizione della tavola periodica
71
3 . 4
Descrizione della tavola periodica
Come mostrato nella Figura 3.2, la tavola periodica può essere suddivisa in
4 blocchi principali, che prendono il nome dal tipo di orbitali occupati dagli
elettroni più esterni.
I metalli alcalini e alcalino–terrosi appartengono al
blocco s
poiché corri-
spondono al riempimento degli orbitali
ns
. Gli elementi degli altri gruppi prin-
cipali riempiono gli orbitali
np
per cui il loro insieme viene indicato come
blocco p
. Gli elementi di transizione costituiscono il
blocco d,
mentre gli ele-
menti di transizione interna (lantanidi e attinidi) fanno parte del
blocco f
.
Occorre notare che l’idrogeno, seppure presenti un solo elettrone di tipo s,
possiede proprietà completemente diverse da quelle degli elementi del gruppo
I A. Al contrario l’elio, pur non possedendo elettroni di tipo p, presenta le stesse
caratteristiche dei gas nobili del gruppo 0. Questi elementi, chiamati pure
gas
inerti
, presentano strutture di particolare stabilità corrispondenti alla completa
saturazione di tutti gli orbitali s e p corrispondenti ad un determinato valore del
numero quantico principale. Per esempio la configurazione elettronica del Ne è
1s
2
2s
2
2p
6
, quella dell’Ar 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
. Queste configurazioni possono essere
schematizzate come [Ne] e [Ar].
Esaminiamo con maggiore dettaglio la ripartizione degli elementi nei vari
gruppi. Nel quarto periodo lo Sc (Z=21) ha proprietà diverse da quelle dell’Al
poiché cominciano a riempirsi gli orbitali di tipo d. Con lo scandio comincia la
prima serie degli elementi di transizione, caratterizzati da due elettroni in un or-
bitale 4s e dal progressivo riempimento degli orbitali di tipo 3d. Gli elementi di
transizione mostrano alcune irregolarità nel riempimento degli orbitali
d
dovute
al fatto che gli orbitali 4s e 3d, 5s e 4d, 6s e 5d hanno energie molto simili tra
loro. Ad esempio il cromo ha la configurazione: [Ar] 4s
1
3d
5
invece della previ-
sta 4s
2
3d
4
poiché la presenza di orbitali d completi o semicompleti dà luogo a
configurazioni elettroniche di particolare stabilità, come confermato per esem-
pio nel caso del rame, Cu: [Ar] 4s
1
3d
10
, del molibdeno, Mo: [Kr] 5s
1
4d
5
, dell’ar-
gento, Ag: [Kr] 5s
1
4d
10
, dell’oro, Au: [Xe] 6s
1
5d
10
. Con lo Zn gli orbitali 3d
sono completamente riempiti e comincia il riempimento degli orbitali 4p: gli
elementi dal Ga al Kr presentano quindi proprietà simili a quelle degli elementi
dei corrispondenti gruppi del secondo e del terzo periodo. Nel quinto periodo
con l’ittrio comincia il riempimento degli orbitali 4d ed inizia la seconda serie di
elementi transizionali che finisce con il cadmio.
Nel sesto periodo, il Ce (Z = 58) ha proprietà molto simili a quelle del lanta-
nio e dissimili da quelle del Ti e dello Zr. Ciò è dovuto al fatto che con il cerio
inizia la prima serie degli elementi di transizione interna in cui vengono riempiti
i 7 orbitali di tipo f che hanno energia inferiore a quella degli orbitali 5d.
Le somiglianze chimiche tra questi elementi sono molto marcate poiché i
due orbitali esterni rimangono quasi immutati.
Dopo il Lu troviamo l’Hf con il quale inizia una normale serie di transi-
zione. Questa serie si completa con il Hg, dopo il quale vengono riempiti gli or-
bitali 6p.
Nel settimo periodo l’attinio costituisce il primo membro della seconda se-
rie degli elementi di transizione interna degli attinidi, che ricordano nelle loro
proprietà il lantanio.
Per i lantanidi e gli attinidi si possono notare molte irregolarità nella distri-
buzione degli elettroni ed alcune configurazioni risultano incerte poiché le
energie degli orbitali 6s, 4f e 5d o 7s, 5f e 6d sono simili tra loro. Nella Tabella
3.1 sono riportate le configurazioni elettroniche dei vari elementi.
















