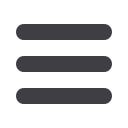

3 . 1
Proprietà chimiche degli elementi e loro periodicità
Il chimico tedesco J. W. Dobereiner fu uno dei primi ricercatori che tentò
una classificazione periodica degli elementi. Egli aveva notato che esistevano
parecchi gruppi di tre elementi, che definì
triadi
, che possedevano proprietà
chimiche simili, come per esempio litio, sodio e potassio, cloro, bromo e iodio
o calcio, stronzio e bario. Questo tipo di classificazione si dimostrò insufficiente
e grossolana, ma servì da stimolo per approfondimenti e studi successivi.
Nel 1863 l’inglese J. Newlands propose un altro criterio di classificazione,
che chiamò
legge delle ottave,
basato sulla disposizione degli elementi in ordine
crescente di peso atomico. Disponendo gli elementi in righe verticali di sette
elementi ciascuna, le righe orizzontali venivano occupate da elementi con pro-
prietà chimiche e fisiche analoghe. Questa teoria non ebbe tuttavia molta for-
tuna poiché presentava molte incongruenze e contraddizioni dovute al mancato
inserimento degli elementi che non erano ancora stati scoperti.
Alcuni anni dopo, il russo D. I. Mendeleev e il tedesco L. Meyer, lavorando
indipendentemente l’uno dall’altro, elaborarono un sistema di classificazione
che si basava sulle relazioni tra le proprietà degli elementi e i rispettivi pesi ato-
mici. In particolare Mendeleev elaborò una
tavola periodica
più completa poi-
ché comprendeva elementi ancora non noti, dei quali riuscì a prevedere non
solo l’esistenza ma anche le proprietà.
Mendeleev sistemò in una tabella gli elementi allora conosciuti, incolon-
nando in gruppi (o famiglie) quelli che avevano proprietà chimiche simili. Per
rispettare la periodicità delle proprietà, riservò dei posti ad alcuni elementi an-
cora sconosciuti, che chiamò ekaboro, ekalluminio ed ekasilicio. Quando, negli
anni seguenti, vennero scoperti lo scandio, il gallio e il germanio, si constatò che
questi elementi avevano esattamente quelle proprietà che Mendeleev aveva pre-
visto, ricavandole da quelle degli elementi vicini. Inoltre, usando la tavola perio-
dica, Mendeleev fu in grado di correggere il peso atomico di alcuni elementi
quali l’indio, il berillio e l’uranio.
La successiva scoperta dei gas nobili non provocò serie modificazioni nella
tavola periodica, poiché questi elementi che avevano la caratteristica di non
combinarsi con altri elementi,
1
furono sistemati facilmente in un gruppo a
parte. Tuttavia la classificazione secondo il peso atomico crescente mostrava
un’incongruenza nel caso di tellurio e iodio, le cui proprietà risultavano diverse
da quelle degli altri elementi dei gruppi dove rispettivamente risultavano collo-
cati. Per eliminare tale incongruenza, Mendeleev invertì la posizione dei due
elementi, supponendo erroneamente che la loro massa atomica fosse stata de-
terminata in modo poco accurato. In realtà nel sistema periodico esistono altri
tre casi per i quali si verifica un’inversione dei pesi atomici e cioè Ar–K, Co–Ni
e Th–Pa.
Queste apparenti anomalie vennero chiarite nel 1913 da G. J. Moseley, il
quale dimostrò che le proprietà chimiche degli elementi non sono una funzione
periodica del peso atomico bensì del
numero atomico
, cioè del numero delle ca-
riche positive (i protoni) possedute dal nucleo atomico. Ordinando gli elementi
in base al numero atomico crescente viene rispettata perfettamente la periodi-
cità delle proprietà degli elementi. Il motivo per cui il peso atomico non pro-
cede sempre di pari passo con il numero atomico è dovuto al fatto che in natura
gli elementi sono usualmente presenti come miscele di isotopi, che hanno lo
stesso numero atomico ma diverso numero di massa. Il numero atomico viene
usato come base della moderna definizione di
elemento chimico
, cioè
un in-
sieme di atomi che hanno tutti lo stesso numero atomico.
66
Capitolo 3 Il sistema periodico
1
Solo successivamente furono sintetizzati alcuni composti dei gas nobili, vedi pagina 666.
















