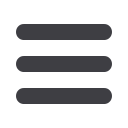

4
Parte Prima
Apprendimento, programmazione e valutazione
e capacità per approdare a sempre nuove conoscenze, sarà altresì
capace di connettere nuovi stimoli e materiali a conoscenze già
esistenti, e ciò anche e soprattutto oltre la vita scolastica.
Posto ciò, alla scuola del XXI secolo è richiesto un innovativo cam-
bio di prospettiva, anzitutto da chi la scuola “la fa”: l’insegnante.
Per essere educatori, diceva Platone, “
bisogna amare ciò che si inse-
gna e le persone a cui si insegna
”: il lavoro di educazione richiesto al
docente di oggi è quello di formare studenti in grado di appren-
dere per operare, renderli flessibili e ben disposti all’introiezio-
ne di nuovi e stimolanti
input
e informazioni, predisporli a porsi
problemi e criticità e a risolverli. La scuola, oggi, è cambiata pro-
fondamente, di pari passo con la società in cui viviamo: è multicul-
turale e, spesso, multilingue. Non solo; il continuo e inarrestabile
sviluppo delle tecnologie dell’informazione e la loro sempre più
facile accessibilità e potere di fruizione aiuta l’educazione stessa
nel formare cittadini in grado di vivere e operare in un mondo
globalizzato, che modifica continuamente i nostri modi di pensare
e conoscere.
Oggi è garantita a chiunque l’opportunità di accesso alla cultura e
all’apprendimento. La “circolarità” dei saperi è ormai cosa attua-
bile e fortemente auspicabile: non più una scienza o delle scienze
riservate agli esperti, a chi di settore, ma che ognuno possa far pro-
prie attraverso i vari canali e i contesti sociali o aggregativi. Edgar
Morin parla di “democrazia cognitiva”, alla quale sottende neces-
sariamente una riforma del pensiero, che ben si addice all’ambito
dell’insegnamento, richiedendo necessariamente “formazione dei
formatori” e “auto-rieducazione degli educatori”, educando gli
“educatori a un pensiero della complessità”, pur laddove essi tro-
vino ostacoli legati a strutture mentali e istituzionali preformate.
La “riforma culturale” auspicata da Morin vuole aprire la strada a
una conoscenza non più frammentata in singole discipline, ma ca-
pace di inquadrare i saperi e le informazioni in un insieme: “
ricon-
ciliare i saperi e gettare i ponti, stabilire corrispondenze tra discipline che
finora non comunicavano tra loro
”. In una parola, multidisciplinarità.
Il problema della centralità dell’apprendimento ha certamente
condizionato e condiziona la progettazione delle attività didatti-
che: apprendere in modo profondo e duraturo deve essere, per
ogni studente, l’obiettivo primario accanto alla formazione di in-
telligenze in grado di accompagnarlo e supportarlo nella risolu-
zione di problemi complessi. È pertanto fondamentale investire
















