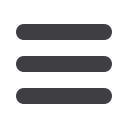

Unità di Apprendimento 2
Le
Þ
gure femminili nell’
epos
omerico
439
www.
edises
.it
ritorno, che prevede anche il passaggio attraverso l’Ade (vv. 483-495), rappre-
sentano il cammino di iniziazione cui Circe sottopone Odisseo; interessante a
tal proposito la lettura del commento critico sui riti di passaggio di Arnold Van
Gennep
8
.
Oltre all’elemento magico, Omero si sofferma anche realisticamente sulle oc-
cupazioni femminili e domestiche di Circe.
All’arrivo dei compagni di Odisseo, Circe è descritta mentre è intenta alla tes-
situra, all’interno delle mura domestiche, circondata dalle ancelle, accompa-
gnandosi con il canto (vv. 221-228: «e Circe dentro cantare con bella voce senti-
vano / tela tessendo grande e immortale, come sono i lavori delle dee […]; qui
dentro una che tesse gran tela soave canta, […] o donna o dea»).
Nel momento in cui Odisseo accetta l’invito a letto di Circe, ancora una volta
viene descritto l’interno domestico, con la maga attorniata dalle ancelle (vv.
348-359: «Le ancelle, intanto, in sala si affaccendavano, le quattro ancelle che
in casa le stanno […]. La prima gettava sui troni bei drappi […] la seconda da-
vanti ai seggi tirava le mense […] la terza nel cratere il vino, profumo di miele,
versava […] la quarta l’acqua portava e il fuoco accendeva»).
In un’ottica diacronica si può procedere a un cenno ai testi letterari latini in
cui viene ripresa l’avventura di Circe e Odisseo, vale a dire l’
Eneide
virgiliana
(VII, 10-24) e le
Metamorfosi
di Ovidio (XIV). Ciò al ne di far cogliere agli stu-
denti la ricorrenza nella tradizione letteraria degli stessi miti, che assumono va-
lenza differente in relazione alla sensibilità del poeta e all’epoca che li esprime.
Calipso
Il primo riferimento alla ninfa si ha nel
libro I
dell’
Odissea
(vv. 11-62). Il libro si
apre, infatti, con un #ash-back sul destino degli eroi della guerra di Troia, che
sono tutti rientrati in patria e a loro viene contrapposto Odisseo, trattenuto ad
Ogigia da Calipso (vv. 11-15: «Allora tutti gli altri, quanti evitarono l’abisso di
morte, erano a casa, scampati dalla guerra e dal mare; lui solo, che sospirava il
ritorno e la sposa, la veneranda ninfa Calipso, la splendida dea, tratteneva negli
antri profondi, volendo che le fosse marito).
In questi versi vengono subito evidenziati gli atteggiamenti opposti dei due per-
sonaggi: Calipso, dea malinconica e innamorata, vuol trattenere a sé l’eroe (vv.
56-57: «con tenere, maliose parole lo incanta, perché scordi Itaca»), viceversa
Ulisse ha nostalgia di casa (v. 13: «che sospirava il ritorno e la sposa»; vv. 58-59:
«nel desiderio di scorgere sia pur solo il fumo, che balza dalla sua terra») e
riuterà il dono dell’immortalità offertogli dalla dea.
La dimora di Calipso si trova agli estremi conni occidentali, presso le Colonne
d’Ercole (v. 50: «nell’isola in mezzo all’onde, dov’è l’ombelico del mare»; v. 53
«regge le grandi colonne»). Ciò avvalora il mitologema del viaggio di Ulisse
come viaggio
oltre la morte
: anche se è probabile il debito di Omero nei confron-
8
A. Van Gennep,
I riti di passaggio
, 1909, citato in G. Guidorizzi,
Il mondo letterario greco
, vol.
I, Einaudi scuola, Torino, 2008, pp. 444-445.
















