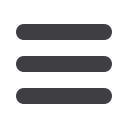

Unità di Apprendimento 2
Le
Þ
gure femminili nell’
epos
omerico
435
www.
edises
.it
to di Afrodite che avvolge Paride in un una nube e lo riporta al talamo.
Qui Afrodite convoca Elena, che dapprima si riuta (signicativo esempio
di
a
ἰ
dw;
~
femminile), poi cede ma esprime, a colloquio con Paride, il suo
disprezzo per l’eroe (vv. 428-429: «Sei tornato dalla guerra. Oh, se là fossi
morto, vinto da un uomo forte com’era il mio primo marito!»; vv. 435-436:
«non combattere, stolto, che troppo presto sotto l’asta sua non cada»).
>
Libro VI
, vv. 343-358: Ettore, dopo aver indotto la madre e le anziane a far
voti ad Atena, si reca a casa del fratello Paride per rimproverarne la viltà e
richiamarlo in guerra. Elena ribadisce il proprio senso di colpa (vv. 345-346:
«ah, m’avesse quel giorno, quando la madre mi fece, afferrato e travolto un
turbine orrendo di vento») e il suo disprezzo per Paride ( vv. 350-353: «avrei
voluto almeno essere sposa d’un uomo più forte […]. Costui non ha ora cuor
saldo e neanche lo avrà certo mai»).
>
Libro XXIV
, vv. 761-775: Riscattato il corpo di Ettore, anche Elena esprime
il suo compianto, consapevole che è morto un uomo gentile e affettuoso
con lei (v. 767: «e mai ho udito da te mala parola o disprezzo»; vv. 774- 775:
«nell’ampia Troia più nessun altro verso di me è buono, è amico»).
Nell’
Odissea
Elena è rafgurata a Sparta, ritornata in patria come sposa legitti-
ma di Menelao. Qui la incontra Telemaco, nel libro IV, giunto a cercare notizie
del padre. La descrizione di Elena è quella della
donna dedita alle faccende
domestiche
, in compagnia delle ancelle, ma anche quella della
maga
, prepa-
ratrice di ltri atti a colmare il dolore dei convitati che piangono ascoltando i
racconti dei lutti di Troia.
Nel
libro IV
, vv. 120-232, infatti: Elena si dedica al fuso e al telaio, ma il suo rango
la distingue dalle ancelle dal momento che lavora con attrezzi preziosi in oro
o argento (v. 122: «pareva Artemide dalla conocchia d’oro»; vv. 123-125: «Per
lei, dunque, Adreste, […] collocò un trono, e Alchippe portava un tappeto di
morbida lana, Filò portava il paniere d’argento»; vv. 131-132: «una conocchia
d’oro, […] un cesto a rotelle, d’argento»).
Quando poi, giunto Telemaco, il racconto delle gesta di Troia suscita il pianto
dei convitati, Elena allevia il loro dolore versando nel vino «un farmaco che
l’ira e il dolore calmava, oblio di tutte le pene» (vv. 220-221) donatole da «Poli-
damna […], la sposa di Tone, l’egizia» (vv. 228-229). Il riferimento allude a un
legame tra Elena e l’Egitto, per la verità mai esplicitato da Omero, ma presente
in Erodoto (che, nel II libro delle
Storie
, narra di un culto di Afrodite Straniera
in Egitto, identicando la dea con Elena, che proprio in quella terra avrebbe
soggiornato) e nell’
Elena
di Euripide (dove si fa riferimento alla versione del
mito secondo cui causa della guerra di Troia fu un fantasma di Elena, mentre la
vera eroina era stata trasportata in Egitto, dove venne raggiunta da Menelao).
Penelope
Nell’
Odissea
Penelope è presentata come la
donna saggia e prudente
, la cui
astuzia, nel tessere la tela, non ha alcuna valenza negativa, piuttosto si congu-
ra come un uso dell’intelligenza a difesa e salvaguardia dell’
o
ἶ
ko~
e della pro-
















