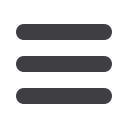
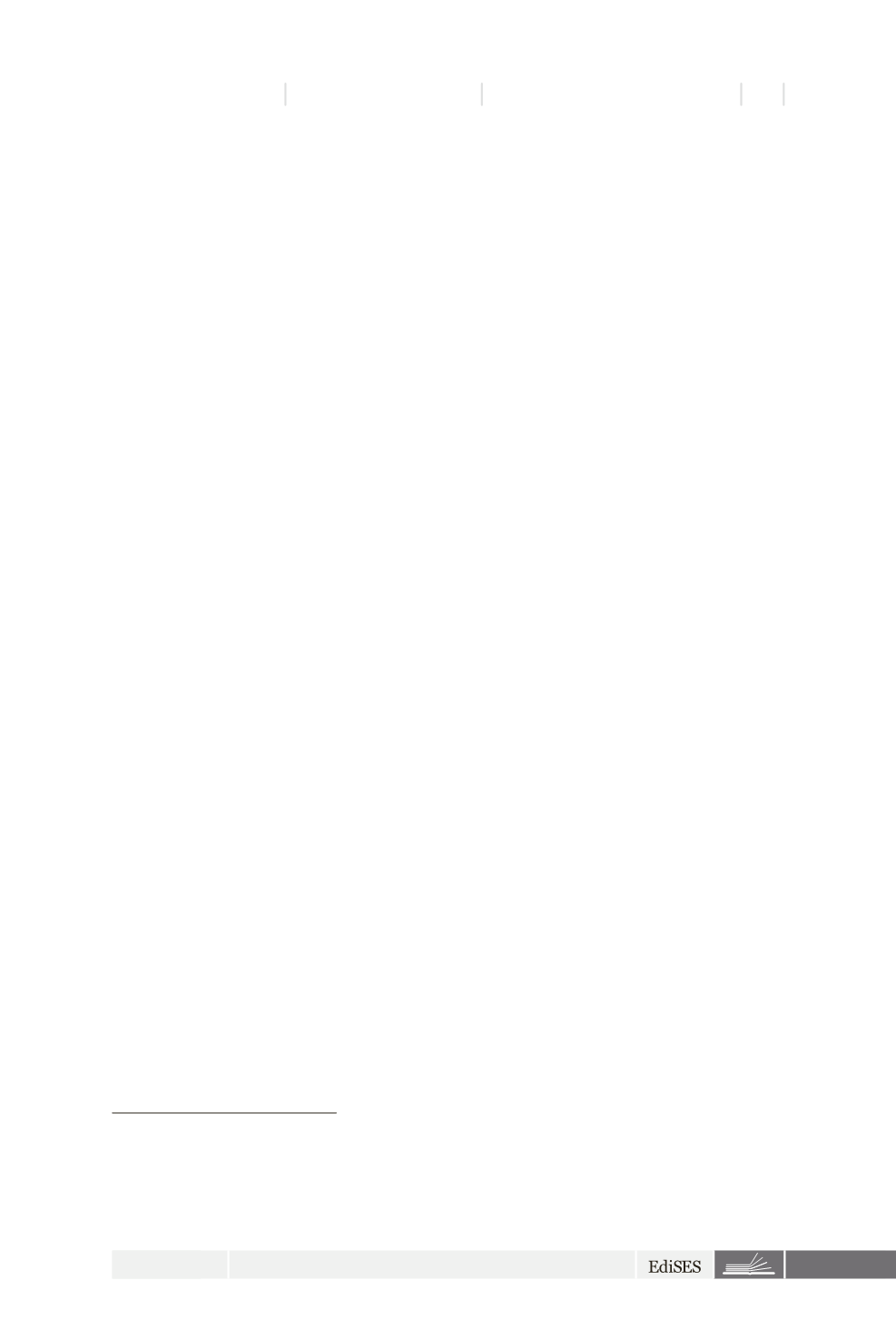
Unità di Apprendimento 2
Le
Þ
gure femminili nell’
epos
omerico
437
www.
edises
.it
in quest’ottica la funzione svolta dal letto nuziale (libro XXIII, v. 171: «Ma via,
nutrice, stendimi il letto») in quanto ribadisce il ruolo di
Re Sacro
propria del
paredro
, fecondatore della
Pov
tnia
e capace di ricreare il ciclo morte-rinascita
5
.
Ancora, come nota Chiarini
6
, non è casuale che la tela di Penelope venga det-
ta sudario (XIX, v. 144:
ta
ϕ
hv
i>
on
) a ribadirne l’inserimento in un processo di
nascita-morte-resurrezione.
Anticipando la presentazione del successivo personaggio femminile, Nausicaa,
può essere funzionale proprio l’utilizzo del motivo archetipico n qui illustrato
quale anello di congiunzione tra le due gure e ricorrente mitologema dell’
O-
dissea
. Nel modo in cui la donna si rivolge al naufrago Ulisse viene ripetuto
infatti il motivo della
Pov
tnia
(libro VI, vv. 298-299 e vv. 304-305: «domanda la
casa del padre mio»; «avvicinati alla madre»).
Nausicaa
Nel
libro VI
dell’
Odissea
vengono descritte le peculiarità di questa donna: la
bellezza
che Odisseo loda in quanto pari a quella di una dea (vv. 149-152: «Io mi
t’inchino, signora: sei dea o sei mortale? Se dea tu sei, di quelli che il cielo vasto
possiedono, Artemide, certo, la glia del massimo Zeus, per bellezza e grandez-
za e gura mi sembri»; vv. 162-168: «In Delo una volta […] vidi levarsi un fusto
nuovo di palma […] ammirandolo, fui vinto dal fascino […] come te, donna,
ammiro, e sono incantato»); la
cura per il proprio corpo
e
per il proprio abbigliamento
che Atena le suggerisce in sogno di avere (vv. 26-30: «Le vesti vivaci son là in
abbandono»); la
regalità
per cui lei
sola
si ferma alla vista di Odisseo, mentre le
ancelle fuggono (vv. 137- 140: « Pauroso apparve a quelle […] fuggirono qua e
là […] Sola, la glia di Alcinoo restò»); la
verecondia
e il
pudore
che la inducono
a invitare Odisseo a recarsi da solo in città per evitare i pettegoli commenti su
di lei e lo straniero (vv. 273-274: « Voglio sfuggire alle loro chiacchiere amare,
nessuno mi sussurri alle spalle!»); il
desiderio di nozze
(vv. 244-245: «Oh se un
uomo così potesse chiamarsi mio sposo, abitando fra noi, e gli piacesse resta-
re!»). In realtà, se Odisseo le augura nozze felici e la possibilità di diventare
garante della concordia dell’
o
ἶ
ko~
da lei costituito, non sarà lui a divenire il suo
sposo. È possibile inserire a questo punto un ulteriore riferimento di critica let-
teraria: dal punto di vista della tensione narrativa l’episodio si può catalogare
nell’ambito delle «attese disattese»
7
: il mancato matrimonio delude le aspetta-
tive del lettore.
Altro elemento di ri#essione è il confronto tra la vicenda di Ulisse e Nausicaa
e quella, per alcuni versi afne, di Simbad il marinaio narrata ne
Le mille e una
notte
. Entrambi gli eroi vivono l’esperienza del naufragio, perdono ogni cosa,
perno le vesti, approdano in una terra sconosciuta dove sperimentano l’acco-
5
A proposito del mitologema Grande Madre-Paredro cfr. J.G. Frazer,
Il ramo d’oro
, 1925.
6
G. Chiarini,
Kosmos, Itinerari nell’epica classica
, Bruno Mondadori, Milano, 1998.
7
M. Casertano, G. Nuzzo,
La produzione letteraria nell’antica Grecia
, vol. I, Palermo, Palumbo,
1999, p. 185.
















