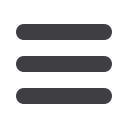
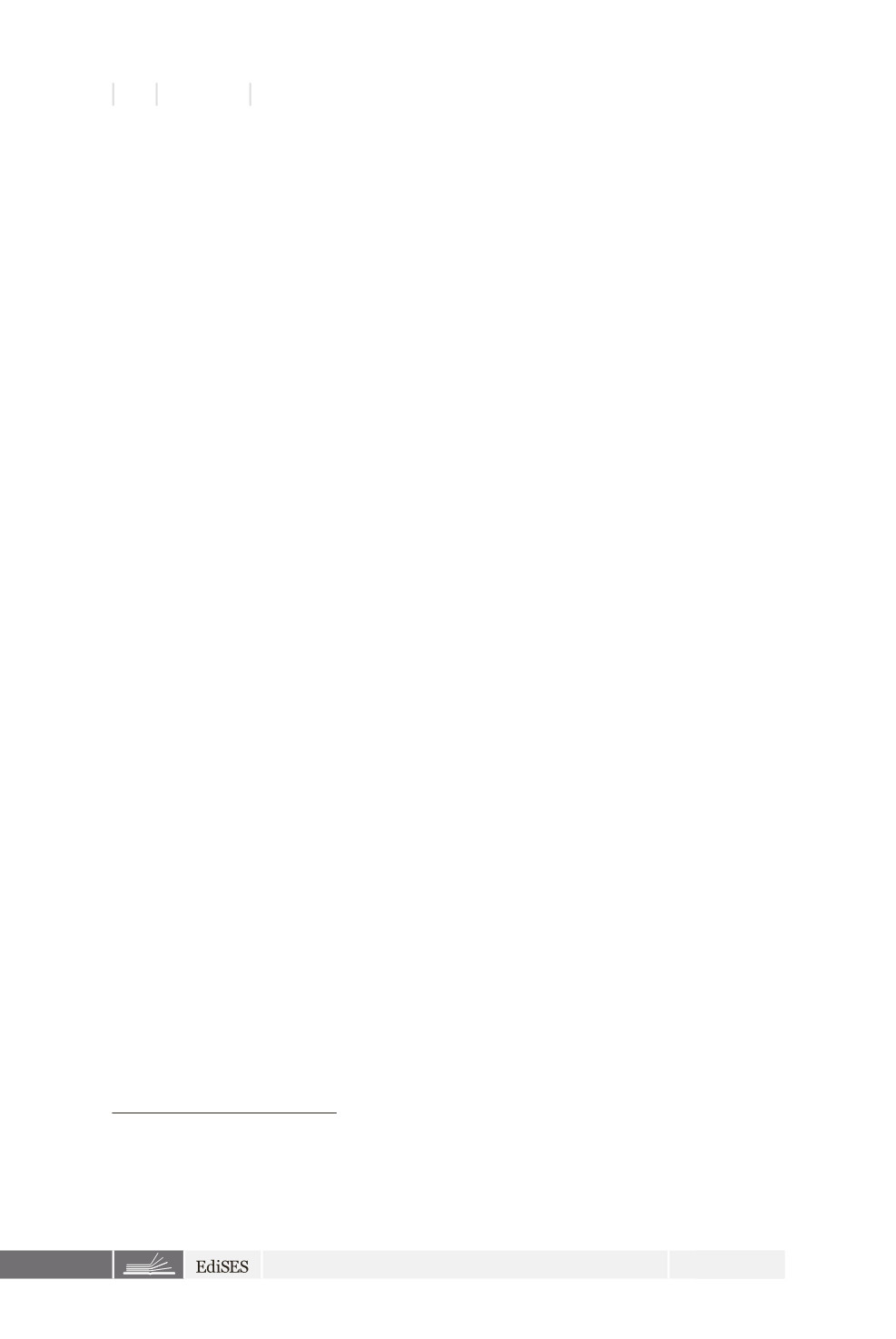
436
Parte Terza
Esempi di Unità di Apprendimento
www.
edises
.it
pria fedeltà a Odisseo. È inoltre garante del patrimonio lasciatole dal marito (il
poema epico si rivela in ciò il ri#esso degli usi di un’epoca, in particolare della
consuetudine che prevedeva che, secondo i vincoli del contratto matrimoniale,
la sposa rimanesse proprietaria del patrimonio, anche in assenza del coniuge,
nché non abbandonava l’
o
ἶ
ko~
per tornare alla casa del padre) e della concor-
dia familiare che si ristabilirà col rientro di Odisseo a Itaca.
Nel
libro XI
, vv. 435-446, la saggezza di Penelope è sottolineata da Ulisse e Aga-
mennone, a colloquio nell’Ade, in contrapposizione con la scelleratezza delle
cugine Elena e Clitemnestra (vv. 438-439: «per Elena quanti perimmo! E a te
Clitemnestra ordì inganno mentr’eri lontano»). Entrambe infatti hanno agito
per distruggere l’
o
ἶ
ko~
: Elena tradendo Menelao, Clitemnestra uccidendo il
marito Agamennone. Viceversa Penelope sarà fedele allo sposo (vv. 444-445:
«Pure, Odisseo, morte a te non verrà dalla tua sposa: troppo è saggia e di
pensieri sa in cuore»).
Nel
libro XIX
, vv. 123-163, durante il colloquio tra Penelope e il mendico (in re-
altà Odisseo) giunto a Itaca, la donna mette in risalto la sua astuzia nel tessere
la tela per ritardare le nuove nozze (v. 137: «e io lo inganni»; vv. 157-158: «non
trovo altro imbroglio»).
L’analisi testuale, n qui condotta, può essere arricchita dalla
lettura di pagine
critiche
, utili peraltro ad abituare gli allievi allo studio dei testi antichi anche
alla luce del commento letterario, introducendo così il concetto di critica lette-
raria. Interessante a questo proposito il riferimento al commento di Dario Del
Corno, che nota la “complementarità”, che non è “opposizione”, di Penelope
rispetto ad Ulisse: la donna, infatti, «rappresenta il polo statico verso cui tende
la dinamica dell’azione di Odisseo […] partecipa della sua astuzia», rappre-
senta l’approdo di Ulisse dopo aver sperimentato l’amore di altre donne, «che
hanno la funzione di ritardare […] il suo ricongiungimento alla sposa»
2
.
Altro interessante commento critico è quello che vede rivivere in Penelope,
come in altre gure femminili descritte nell’
Odissea
, «l’antico mondo medi-
terraneo delle Dee Madri»
3
,
mitologema adattato ad una nuova realtà stori-
co-culturale nella quale non è più prevista la morte del
paredro.
Il riconosci-
mento è, infatti, ritardato, non solo per un’esigenza narrativa di «tensione
drammatica»
4
, ma perché Penelope abbia il tempo di
riaccettare
lo sposo. La
stessa sua condizione di dominatrice a Itaca ribadisce il suo ruolo archetipico
di
Pov
tnia
(cfr. libro XXI, vv. 2-3 e vv. 73-74 dove Penelope indice la gara per lo
sposo «ebbene, pretendenti, vi si presenta una gara; v’offrirò il grande arco del
divino Odisseo»; vv. 63-64 e 68 alla sua apparizione, i proci tacciono: «Come tra
i pretendenti fu la donna bellissima, si fermò ritta accanto […] Sentite me, pre-
tendenti alteri». Nella terra di Penelope, Itaca, perno Odisseo entra furtiva-
mente, camuffato da mendicante e non nelle vesti di re). È signicativa dunque
2
D. Del Corno,
Letteratura greca
, vol. I, Principato, 1995, pp. 54-55.
3
M. Casertano, G. Nuzzo,
Storia e testi della letteratura greca
, vol. I, Palumbo, Palermo, 2003,
p. 178.
4
Ivi, p. 162.
















