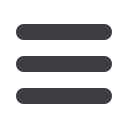

www.
edises
.it
Capitolo 50
Principali indirizzi del Novecento
737
La critica sociologica ha sviluppato al suo interno diversi orientamenti, in base alle
diverse concezioni della società e della storia, cioè in base ai diversi presupposti ideo-
logici e filosofici.
Indubbiamente l’orientamento che nel corso del Novecento (e del secondo Novecen-
to) ha dominato la critica sociologica è quello marxista; tuttavia, esempi di critica
d’impostazione sociologica sono anche lo storicismo romantico, in particolare quello
di De Sanctis (la letteratura come specchio dello sviluppo complessivo della nazione)
e parte della critica positivistica: per esempio, il francese Taine come criteri interpre-
tativi utilizzava “l’ambiente, la razza, il momento” per spiegare le caratteristiche delle
opere letterarie in base a fattori geografici, sociali, antropologici e storici.
50.6
La critica marxista
Il fondamento di tale indirizzo critico è la dottrina marxiana, più propriamente marx-
engelsiana. Secondo Marx ed Engels tutta la produzione culturale e artistica è “sovra-
struttura”, cioè dipende dalla realtà socio-economica e dai rapporti fra le classi sociali
(la “struttura”) determinati dai modi di produzione di una certa epoca. Il punto no-
dale nel pensiero dei teorici del marxismo è quello di non rendere meccanico il rap-
porto arte/società cercando delle mediazioni nelle leggi proprie dell’arte. Tuttavia, in
alcuni casi, tali mediazioni sono state ignorate trasformando la critica sociologica
marxista nell’individuazione di una serie di meccanici rapporti di causa/effetto tra
società e produzione letteraria e nella precisazione del punto di vista di classe dello
scrittore, cioè il suo orientamento ideologico.
Alcuni studiosi hanno reagito all’eccessiva semplificazione e tra essi va ricordato
G. Lukács
, critico ungherese che elabora una teoria estetica del tutto personale fon-
data sul concetto di “rispecchiamento”, secondo la quale l’arte è contemporaneamen-
te prodotto e rispecchiamento della società; compito del critico è soffermarsi soprat-
tutto sul secondo aspetto, per cui un’opera d’arte è tanto più valida quanto più riesce
a rispecchiare la realtà sociale, indipendentemente dalla posizione ideologica dello
scrittore. Può accadere, per esempio, che un monarchico come Balzac riesca a rispec-
chiare le condizioni sociali del suo tempo in maniera più profonda di uno scrittore
progressista. In generale, Lukács tende a privilegiare l’arte realistica perché vi trova
un esempio efficace di rispecchiamento sociale; al contrario, le avanguardie e gran
parte della letteratura novecentesca non lo interessano perché distanti nei criteri e
nei modi dal più tipico realismo ottocentesco. In questo senso, si può affermare che
la critica crociana e quella lukacsiana hanno un punto in comune: la scarsa compren-
sione della contemporaneità.
Alcuni critici e teorici, riconducibili all’impostazione sociologica, reagiscono al crite-
rio dell’arte come rispecchiamento della società reale. Vanno brevemente ricordati:
>
>
L. Goldmann
,
che ha cercato di coniugare marxismo e strutturalismo (la genesi
dell’opera d’arte non è in rapporto con le strutture economiche ma con la menta-
lità dell’autore e dell’epoca);
>
>
W. Benjamin
e
la scuola di Francoforte
,
che affidano all’arte il compito di prospet-
tare una soluzione utopica alle contraddizioni, reali, del presente non il rispecchia-
mento della società reale. In Italia, tale indirizzo di ricerca influenzerà la riflessione
del critico
F. Fortini
.
















