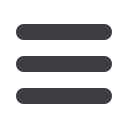
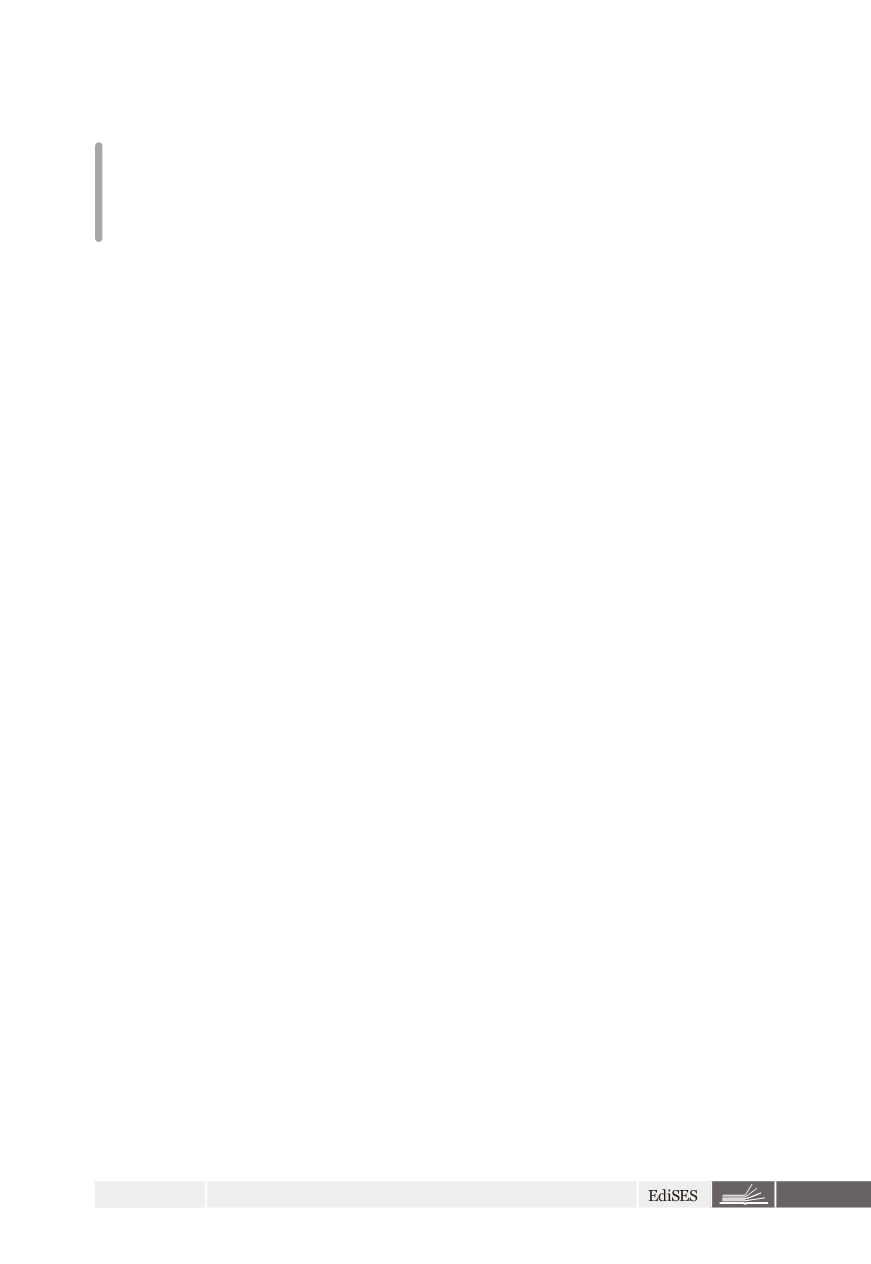
www.
edises
.it
Capitolo 49
Critica dell’Ottocento
49.1
Introduzione
La nozione di “critica storicistica” si sviluppa nella temperie culturale dello “storici-
smo”, in particolare lo storicismo idealistico hegeliano. Secondo Hegel (1770-1831)
tutta la realtà è spiegabile in termini di “divenire”, e in modo particolare lo spirito, la
società, le istituzioni, l’arte dell’uomo sono fenomeni decifrabili essenzialmente in
termini storici. In questa prospettiva rientra la riflessione critica ottocentesca, soprat-
tutto l’opera di F. De Sanctis (1817-1883), che attraverso lo sviluppo della letteratura
mira a interpretare la storia dell’intera civiltà nazionale.
49.2
Lo storicismo romantico
Per meglio comprendere tali aspetti si può ripercorrere lo sviluppo degli studi critici
in senso diacronico, affermando che con la cultura del Romanticismo la critica lette-
raria, da un lato, recupera l’impostazione speculativa connessa alla sua attività esege-
tica, dall’altro, vede nascere la figura intellettuale – tra l’artista, il filosofo e il pedago-
go – del
critico letterario
: dagli Schlegel a Novalis, ai giovani romantici attivi nei primi
decenni del secolo (Jean Paul e Tieck), alla fondamentale estetica hegeliana. In In-
ghilterra vanno ricordati
Wordsworth
e
Coleridge
, con la loro ricerca di un linguaggio
“naturale”; in Francia,
Chateaubriand
,
M.me de Staël
(che sviluppano una più precisa
coscienza storica e sociale del fatto letterario) e
Sainte-Beuve
, critico, non solo della
letteratura, ma anche del costume, psicologo, moralista. Nella cultura italiana, con
Foscolo
e
Leopardi
, e con la polemica antiprecettistica di
Di Breme
,
Berchet
,
Manzo-
ni
, si afferma la consapevolezza che il rapporto con la tradizione può articolarsi in
maniera corretta solo nella coscienza e nel sentimento del “moderno”.
Tuttavia, indipendentemente dalle personali adesioni alle poetiche romantiche, sono
sintomatiche del secolo le diverse prospettive storiografiche che emergono da opere
di forte caratterizzazione ideologica. Sono da evidenziare:
>
>
quella “ghibellina” di
P.E. Giudici
(
Storia della letteratura italiana
, 1855);
>
>
quella di
C. Cantù
, clericale e moralistica (
Storia della letteratura italiana
, 1865);
>
>
quella di
L. Settembrini
(
Lezioni di letteratura italiana
, 1866-72), nella quale un acce-
so anticlericalismo si combina col recupero della tradizione classica.
È in questo clima di viva passione militante che matura la prospettiva storico-ideologi-
ca della Storia e dei saggi di
Francesco De Sanctis
, in cui si delinea una riflessione
sulla
letteratura come universo di procedimenti estetici
che elaborano un peculiare
linguaggio sentimentale, espressione di contemporanei valori storico-sociali e civili.
















