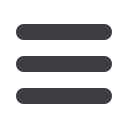

www.
edises
.it
732
Parte Quinta
La critica letteraria
La critica da interpretativa diviene essenzialmente valutativa: individua nel testo,
come valori, i segni dell’evoluzione storica e della capacità di rappresentare il conte-
sto etico-culturale.
49.3
La scuola storica positivistica
Lo storicismo romantico e idealistico trova poi un momento di sviluppo decisivo per
la critica novecentesca italiana nell’estetica e nella critica di
Benedetto Croce
, che
prende il nome di “storicismo assoluto” e di “critica estetica”. Tuttavia, per meglio
comprendere la teoria e il metodo crociani bisogna tenere presente che alcune sue
enunciazioni si spiegano in rapporto con la precedente critica positivistica, la cosid-
detta “scuola storica”, che mirava all’analisi di fatti oggettivi mettendo in secondo
piano l’interpretazione soggettiva dei testi. Tale scuola, infatti, si preoccupava di rac-
cogliere e descrivere documenti relativi alla biografia degli autori o alla composizione
materiale dei testi, alle fonti, alla fortuna delle opere, mirando a individuare a quale
persona reale o a quale luogo si riferisse uno scrittore nel delineare un personaggio o
un ambiente. Da questo indirizzo di ricerca derivano la maggior parte delle identifica-
zioni come, per esempio, quella della Silvia leopardiana con Teresa Fattorini (perso-
naggio reale). La “scuola storica” si era anche occupata dello studio dei generi lettera-
ri partendo dal presupposto che si trattasse di forme organiche da analizzare secondo
l’evoluzionismo darwiniano seguendo una logica di nascita, crescita, lotta per imporsi,
declino, morte. Tale rigorosa istanza di storicità sulla quale s’innesta la ricerca positi-
vistica si ritrova perciò in
Carducci,
nella cosiddetta “scuola storica”, nei filologi di fine
secolo (D’Ancona e Rajna), che analizzano non solo il rapporto della letteratura con
il suo contesto storico, ma avviano anche una ricerca della storia interna del sistema
letterario, con un recupero della filologia come verifica della tradizione.
Sul finire del secolo, la lezione desanctisiana si conservava, come ricerca della corret-
ta “forma” letteraria e del realismo del testo, nella critica militante di L. Capuana e
della
scuola verista
, al di là dell’adesione programmatica alla poetica del naturalismo
francese. Intanto, nelle culture tedesca, francese, russa, maturava l’esigenza di struttu-
rare la fenomenologia delle forme letterarie in un organismo sistematico: la teoria
della critica come attenzione al “momento” culturale in
H.-A. Taine
, il progetto di una
poetica moderna in
W. Dilthey
, l’idea di una “
descrizione completa delle forme esistenti o
possibili della produzione poetica
” in
W. Scherer
.
















