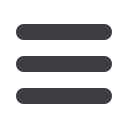
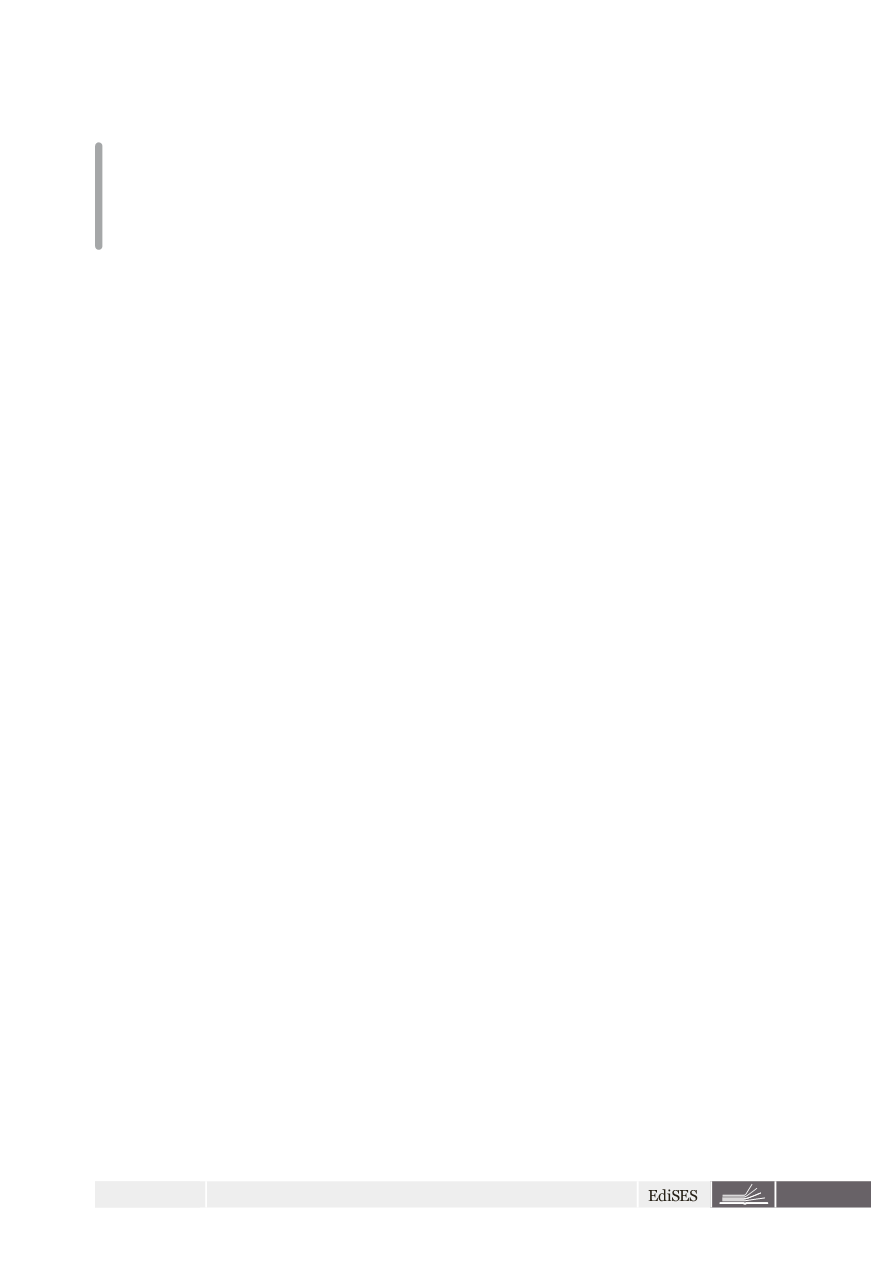
www.
edises
.it
Capitolo 50
Principali indirizzi del Novecento
50.1
Introduzione
Tra la fine del secolo XIX e i primi decenni del successivo, nelle ricerche dei russi
A. Veselovskij
e
A. Potebnja
, la “storia delle forme” vuol dire riesame della tradizione
con il sussidio delle analisi dell’antropologia, dell’etnografia, della storia artistica e
filosofica, della linguistica.
La cultura simbolista e decadente, in Francia e in Inghilterra, oltre che in Italia, aveva
elaborato una modalità di approccio al testo come enfatizzazione delle sue capacità di
evocare valori nascosti alla realtà quotidiana. Per esempio, nel simbolismo francese tale
approccio consiste nel riconoscimento del valore centrale del linguaggio e della plura-
lità di significati che, in un testo letterario, si trova a veicolare. Questa nuova sensibilità
formale va letta storicamente, in strettissima relazione con le esperienze delle avanguar-
die storiche in tutta Europa (all’interno della riflessione critica dell’Inghilterra degli
anni ’20, da T.S. Eliot a J.A. Richards) e prima ancora, a partire dal 1916, con l’elabora-
zione teorica e analitica del
formalismo russo
. Ancora riconducibili alle esperienze
d’avanguardia in Germania, negli anni ’20, i primi scritti di B. Brecht e W. Benjamin.
50.2
Lo storicismo crociano e la critica estetica
In Italia l’estetica crociana apre il Novecento fissando il ruolo della critica nella valu-
tazione dell’unità “intuizione poetica”/espressione. A una teoria che concepiva l’arte
come “fatto” e attribuiva alla critica cosiddetta “scientifica” il compito di accertare i
fatti,
B. Croce
contrappone una concezione dell’arte “come atto spirituale, come crea-
zione di valore” e assegna alla “critica estetica” il compito di formulare un giudizio di
valore, che stabilisca quanto sia bello e quanto sia brutto, che distingua la “poesia”,
cioè l’opera o la parte dell’opera esteticamente valida, dalla “non-poesia”, la poesia
dalla “struttura”. Ecco che la
“critica storica” diventa “critica estetica”
. Caratteristica
peculiare della critica crociana è il giudizio estetico sull’opera esaminata, per cui, per
esempio, nella
Divina Commedia
è possibile, secondo Croce, distinguere parti estetica-
mente valide da parti non altrettanto valide benché necessarie per la fisionomia
dell’opera; si assiste perciò a una svalutazione della “struttura” rispetto alla “poesia”.
La metodologia crociana presenta essenzialmente due preclusioni caratteristiche:
>
>
le spiegazioni tecniche sono inessenziali per la comprensione della poesia, che in-
fatti è un atto intuitivo e come tale determina automaticamente le modalità espres-
sive nell’atto stesso della creazione. In questa ottica il critico più che “letterato” o
“scienziato” (come era nella scuola positivistica) è visto come “filosofo”, il cui com-
pito è quello di formulare un giudizio estetico;
















