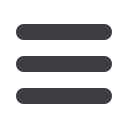

www.
edises
.it
734
Parte Quinta
La critica letteraria
>
>
realizzare una storia dei generi o una storia letteraria, come sviluppo della civiltà
nazionale, è un’operazione impropria: l’arte non è “fatto” o “documento”, bensì un
atto intuitivo individuale che va studiato proprio nella sua individualità per ricostruir-
ne la genesi psicologica e sottoporla a un giudizio estetico.
All’interno della critica crociana, che pur presenta una sua profonda coerenza, è pos-
sibile distinguere
due momenti di sviluppo
:
>
>
una prima fase, in cui l’
arte
viene concepita
come “intuizione lirica” e individuale
,
cioè manifestazione della personalità del suo autore. Compito del critico è quello di
ricercare il processo spirituale individuale che si manifesta nell’espressione artistica
in una serie di sentimenti particolari. Emblematico di questa prima fase è il saggio
su Verga del 1903 (B. Croce,
La letteratura della nuova Italia
, vol. terzo, 1915, pp. 18-
27), in cui Croce individua come motivo ispiratore dell’opera di Verga un “forte
sentimento di dolore e tristezza”. La teoria dell’impersonalità, fulcro della poetica
verista, è secondo Croce un concetto errato perché “l’arte è sempre personale”. Per
tale motivo,
Vita dei campi
e
Novelle rusticane
possono essere considerati veri capolavo-
ri perché, seguendo il sentimento di Verga, formano dei veri e propri “pezzi di vita”;
>
>
una seconda fase, in cui l’
arte
viene concepita come “
intuizione cosmica
”, vale a
dire non più intuizione dell’individuale, ma dell’universale, della vita nella sua to-
talità. Compito della critica è quello di ritrovare nell’individuale parola poetica
l’intuizione del reale nella sua legge eterna.
Ecco che la celebre definizione critica di Ariosto “poeta dell’armonia” si fonda sulla
nozione ariostesca dell’armonia che governa il mondo e che dà senso a tutta l’opera
dello scrittore. Tale nozione sarà poi estesa da Croce a tutti i poeti, poiché egli conce-
pirà l’arte come sentimento dell’armonia cosmica.
50.3
Lo storicismo dopo Croce
L’estetica e la critica crociane hanno esercitato un influsso profondo sulla critica let-
teraria italiana della prima metà del Novecento. Tuttavia, nell’ambito del comune
ambito storicistico si sono sviluppate diverse scuole particolari. Una sommaria classi-
ficazione di tali scuole può essere formulata distinguendo due linee di sviluppo e di
superamento dell’estetica crociana.
Dalle cosiddette preclusioni del metodo crociano discendono, come si è visto:
>
>
il rifiuto della storiografia letteraria per la monografia;
>
>
il rifiuto dell’analisi tecnica per il giudizio estetico “puro”.
I critici d’ispirazione crociana prenderanno le mosse da tali preclusioni e proporran-
no due principali tendenze di superamento:
>
>
quella di aggirare il gusto per la monografia per affermare una più integrale storia
della letteratura e della poesia (linea Russo-Binni);
>
>
quella di esprimere il giudizio di valore attraverso tecniche specifiche, cioè rendere
il critico meno filosofo e più letterato (Petrini e Fubini e la
critica stilistica
).
Una prima linea, la linea Russo-Binni, è caratterizzata dal tentativo di recuperare,
prima nell’ambito dell’estetica crociana, poi autonomamente, una prospettiva stori-
co-letteraria.
















