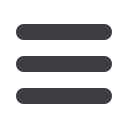

www.
edises
.it
Capitolo 50
Principali indirizzi del Novecento
735
Luigi Russo
da un lato si rifà allo storicismo desanctisiano e al suo intreccio di lettera-
tura, cultura e politica, dall’altro elabora una nozione di poetica come sostrato di idee
estetiche e di orientamenti etico-politici da cui si genera la poesia. La poetica perciò
è una mediazione tra poesia e storia. A proposito di Verga, allontanandosi dalla inter-
pretazione crociana, Russo afferma che l’adesione al verismo fu “il frutto di una crisi
morale dell’autore” (L. Russo,
Giovanni Verga
, 1934, p. 56). Il verismo come tecnica è
di conseguenza una cosa sola con l’arte e con la filosofia dell’artista. In ultima analisi
a Russo non interessa l’opera in quanto realizzazione estetica o la ricerca dell’intuizio-
ne che l’ha generata, ma anche il complesso di sentimenti, idee e passioni che rendo-
no possibile una precisa collocazione dell’opera e dello scrittore nella storia e una
giustificazione delle sue scelte sia tematiche sia formali.
Successivamente, sulla medesima linea,
Walter Binni
sviluppa il concetto di poetica
come programma che ogni artista segue e che spazia dai contenuti conoscitivi, etici e
politici alle forme che essi devono assumere nell’opera. Binni finirà con il capovolge-
re molti giudizi crociani (si pensi alla rivalutazione dell’ultimo Leopardi e del deca-
dentismo) puntando allo studio della letteratura nelle sue dinamiche storiche, anche
indipendentemente dal giudizio di valore sulle singole opere e dal nesso poetica/
poesia. Di fondamentale importanza in questo senso i saggi sulla
Poetica del decadenti-
smo
e sul
Preromanticismo italiano
nei quali sono analizzate dichiarazioni di poetica,
anche di autori minori, come esempi del diffondersi di un gusto e del delinearsi di
nuovi orientamenti stilistici. In questo modo si giunge a una vera e propria ridefini-
zione della storia letteraria, incentrata sullo sviluppo delle poetiche da cui nascono
tutte le opere indipendentemente dal valore estetico che possiedono.
La seconda linea di allontanamento dall’estetica crociana è quella
Petrini-Fubini
e
mira a recuperare le componenti tecniche delle opere, soprattutto quelle retorico-
stilistiche, che Croce aveva bandito dal proprio metodo critico. L’intento di questi
teorici è quello di rendere la critica meno “filosofica” e più “letteraria”: gusto, tecnica,
stile consentono una storicizzazione, cioè una descrizione evolutiva della poesia. Que-
sto nuovo orientamento è caratterizzato da un importante saggio di
M. Fubini
su
Me-
trica e poesia
in cui egli sostiene che “
fare la storia delle forme metriche italiane significa fare
la storia di tutta la poesia italiana
”; l’autore sottolinea anche che la critica nell’esamina-
re un’opera d’arte prende come punto di partenza alcune categorie retoriche, gram-
maticali, linguistiche, considerandole non come elementi fini a se stessi (come acca-
deva ai retori e ai grammatici antichi), ma come mezzi per arrivare a una completa
comprensione dell’opera d’arte. Così scriveva Fubini: “
Al di là del metro, quindi, noi
dobbiamo cogliere il ritmo: il metro è la misura, un aspetto del ritmo; il ritmo è la poesia, l’arte
stessa
”. Le affermazioni del critico rappresentano la base teorica per confrontare, per
esempio, le scelte stilistiche di Dante con la poesia di Petrarca, quella di Petrarca con
quella dei petrarchisti e così via, fino a delineare un tracciato evolutivo e storico della
poesia italiana attraverso lo studio dello stile. A questo punto si può già parlare di
cri-
tica stilistica
che, divenuta disciplina autonoma, accoglie altri modelli oltre a quello
crociano. Per esempio,
M. Fubini
fonde alcuni presupposti del metodo crociano,
come la caratterizzazione individuale degli scrittori, con apporti provenienti da espo-
nenti della critica stilistica europea, in particolare Vossler e Spitzer.
D. Petrini
, invece,
combina la lezione del maestro C. De Lollis e del critico d’arte L. Venturi, incentrata
sulla nozione di “gusto”, quella di Carducci e della scuola storica.
















