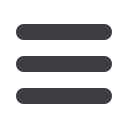

www.
edises
.it
736
Parte Quinta
La critica letteraria
Nella panoramica sullo storicismo andrebbero ricordati molti critici: da
F. Flora
ad
A. Momigliano
, a
N. Sapegno
(che compie una sintesi originale di crocianesimo e
marxismo). Un’intersezione di studi crociani, desanctisiani, gramsciani (storicismo
marxista) si rinviene in
R. Ramat
,
G. Petronio
,
C. Muscetta
e
C. Salinari
; nell’ambito
della fusione di storicismo e filologia possono essere annoverati alcuni dei maggiori
critici del secondo Novecento, da
G. Getto
a
V. Branca
, da
G. Petrocchi
a
L. Caretti
,
da
S. Battaglia
a
U. Bosco
e via dicendo. Un originale metodo critico è stato messo a
punto da
E. Raimondi
, il quale ha mediato storicismo e critica filologica passando at-
traverso la critica simbolica, antropologica e strutturalistica di matrice europea e nor-
damericana (E. Raimondi,
Tecniche della critica letteraria,
Einaudi, 1967; E. Raimondi,
Metafora e storia. Studi su Dante e Petrarca
, Einaudi, 1970).
50.4
La sociologia della letteratura
La sociologia della letteratura si occupa dello
studio della produzione, circolazione e
fruizione delle opere letterarie
servendosi dei metodi propri della sociologia. Tale
disciplina indaga, perciò, gli autori (
produzione
), i canali (
circolazione
), il pubblico (
frui-
zione
) senza prescindere dal contesto storico nel quale tali elementi s’inseriscono e
che contribuiscono a determinare. L’aspetto peculiare della sociologia della letteratu-
ra consiste nel suo metodo d’indagine: degli autori interessano soprattutto l’apparte-
nenza a un ceto o a una classe sociale piuttosto che la loro formazione culturale o le
vicende personali, i rapporti con le istituzioni, la carriera ecc.; delle opere si privilege-
rà in particolare il dato materiale, cioè l’opera come oggetto (il codice manoscritto, il
libro) in cui forme e contenuti sono i rivelatori dell’appartenenza dell’opera e del suo
autore a un determinato ambiente sociale.
Un impulso particolare alla sociologia della letteratura proviene da
C. Dionisotti
con
alcuni saggi compresi nel volume
Geografia e storia della letteratura italiana
(1967): qui
il critico compie una ricerca sulla condizione sociale degli scrittori e sui loro rapporti
con le istituzioni (Stato e Chiesa).
L’evoluzione di tale impostazione di studi ha trovato in seguito una sua sistematizza-
zione in un volume della
Letteratura italiana
della Einaudi intitolato
Produzione e consu-
mo
(sezione
Produzione, circolazione e fruizione
).
50.5
La critica sociologica
La critica sociologica è una disciplina diversa dalla sociologia della letteratura: il cam-
po d’indagine di tale metodologia critica è lo
studio e l’interpretazione delle opere
letterarie in relazione alla società in cui vengono prodotte
e nella quale gli autori
operano. Sia la storiografia (economica, sociale, politica ecc.) sia la sociologia della
letteratura forniscono dati importanti alla critica sociologica, tuttavia è bene precisare
che è critica letteraria a orientamento sociologico, non sociologia; le opere non sono
oggetti materiali ma testi e in quanto tali vanno descritti e interpretati, perché espres-
sioni del mondo e della società, condizionati da un contesto socio-economico-politi-
co. In poche parole, la critica sociologica non si sofferma esclusivamente sul rapporto
autore-contesto (società), ma va oltre, analizzando l’ideologia e la visione del mondo
che gli autori elaborarono nelle proprie opere in base ai condizionamenti sociali.
















