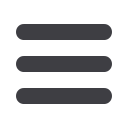
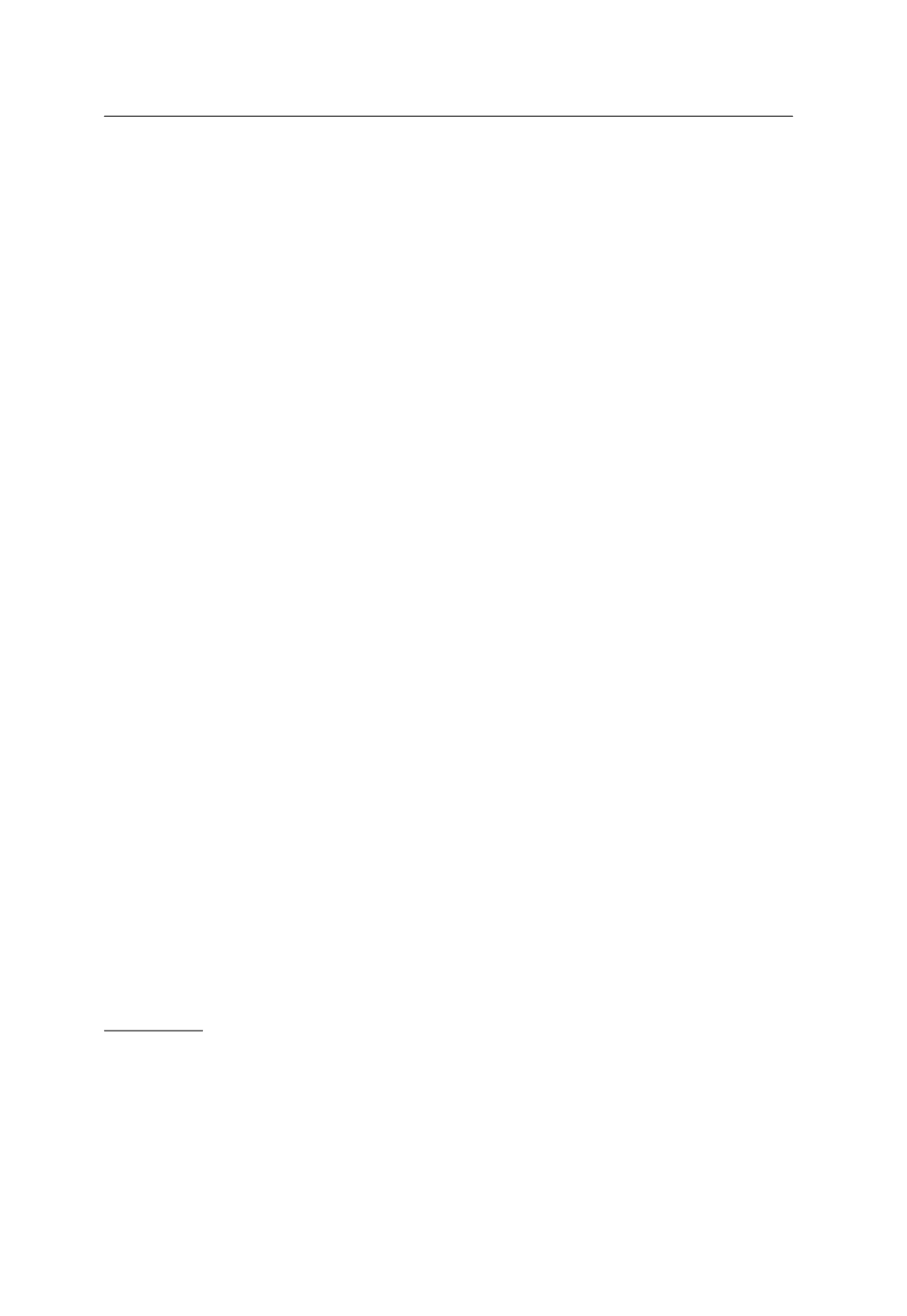
X
Prefazione
riuniti, magari anche solo “virtualmente”, in virtù della partecipazione a uno stesso
percorso (tra gli ultimi esempi, gli inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a
cattedra 2012, gli abilitati attraverso i tirocini formativi attivi o attraverso i percorsi
abilitanti speciali) o sulla base di una stessa, specifica problematica (i “ricorrenti” su
un particolare tema), che rivendicano e a volte ottengono una interlocuzione con la
politica e l’amministrazione parallela ai canali istituzionalizzati.
Non che ciascun attore non persegua, al di là dell’eterogenesi dei fini, un dise-
gno coerente. E non che l’ascolto sia di per sé negativo, anzi. È, sovente, il risultato
a deludere, perché prodotto dell’adozione simultanea di scelte culturali e operative
diverse, quando non divaricanti, in qualche modo conviventi e conniventi, anziché
di una rigorosa regia politica. Secondo il gusto tutto italico del mercanteggiamento,
difficilmente si dice completamente di sì o di no: si fa “un po’ per uno”, a prezzo della
coerenza del sistema. Si aggiungano la resistenza di tradizioni, o meglio di “abitudini”
e “prassi”, erte a scogliera contro la quale si infrange quasi ogni onda riformatrice; i
granelli di sabbia costituiti dalla ricerca di “accomodamenti” nella produzione delle
norme, o più spesso nella loro fase attuativa
10
, ritagliati per questa o quella categoria
o frutto di improvvisi ripensamenti e corrispettive invasioni di campo della politi-
ca nell’azione amministrativa (quanto è simile alle “grida” emanate dai governatori
spagnoli il continuo ribadire, a furor di legge, che la sfera amministrativa e la sfera
politica sono distinte!). L’incoerenza, va da sé, produce incertezza e un esponenziale
incremento di un’imbarazzante mole di contenzioso.
Questioni di tecnica
La materia scolastica subisce dunque, più di altre, l’esercizio di una tecnica nor-
mativa composita, fatta di norme bandiera, di rilegificazioni, di abrogazioni implicite,
sottoposta al continuo ondeggiare tra la riconduzione alle disposizioni che reggono il
pubblico impiego e l’evocazione della sua (assolutamente reale) peculiarità.
Lex gene-
ralis
e
lex specialis
, spesso sfortunatamente mal coordinate tra loro, si trovano in tal
modo spesso a collidere.
Si aggiunga un elemento. Il diritto scolastico manca, al momento, di uno statuto
epistemologico proprio e definito. Eppure, per molti versi, la scuola è una “istituzio-
ne”, nel senso dato al termine dal grande Santi Romano, e dunque “un ordinamen-
to giuridico, una sfera a sé, più o meno completa, di diritto obiettivo”
11
, un
hortus
conclusus
12
che attinge non solo alla congerie di norme specifiche (ivi comprese le
“circolari”, o meglio “note”, che pur non avendo spesso alcun fondamento giuridico,
10
Del mio periodo da consigliere ministeriale ricordo uno scontro furibondo con un Direttore
generale, peraltro persona intelligentissima, che opponeva alle mie richieste di pulizia e inequi-
vocabilità del dictus giuridico la considerazione in base alla quale, se fosse stata adottata una mia
proposta di formulazione, “l’amministrazione non avrebbe potuto adattare la norma”.
11
Santi Romano, L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto,
Pisa 1917, p. 40.
12
Cantico dei Cantici, (4, 12): “
Hortus conclusus soror mea, sponsa, hortus conclusus, fons signatus
”.
















