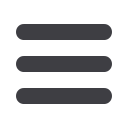
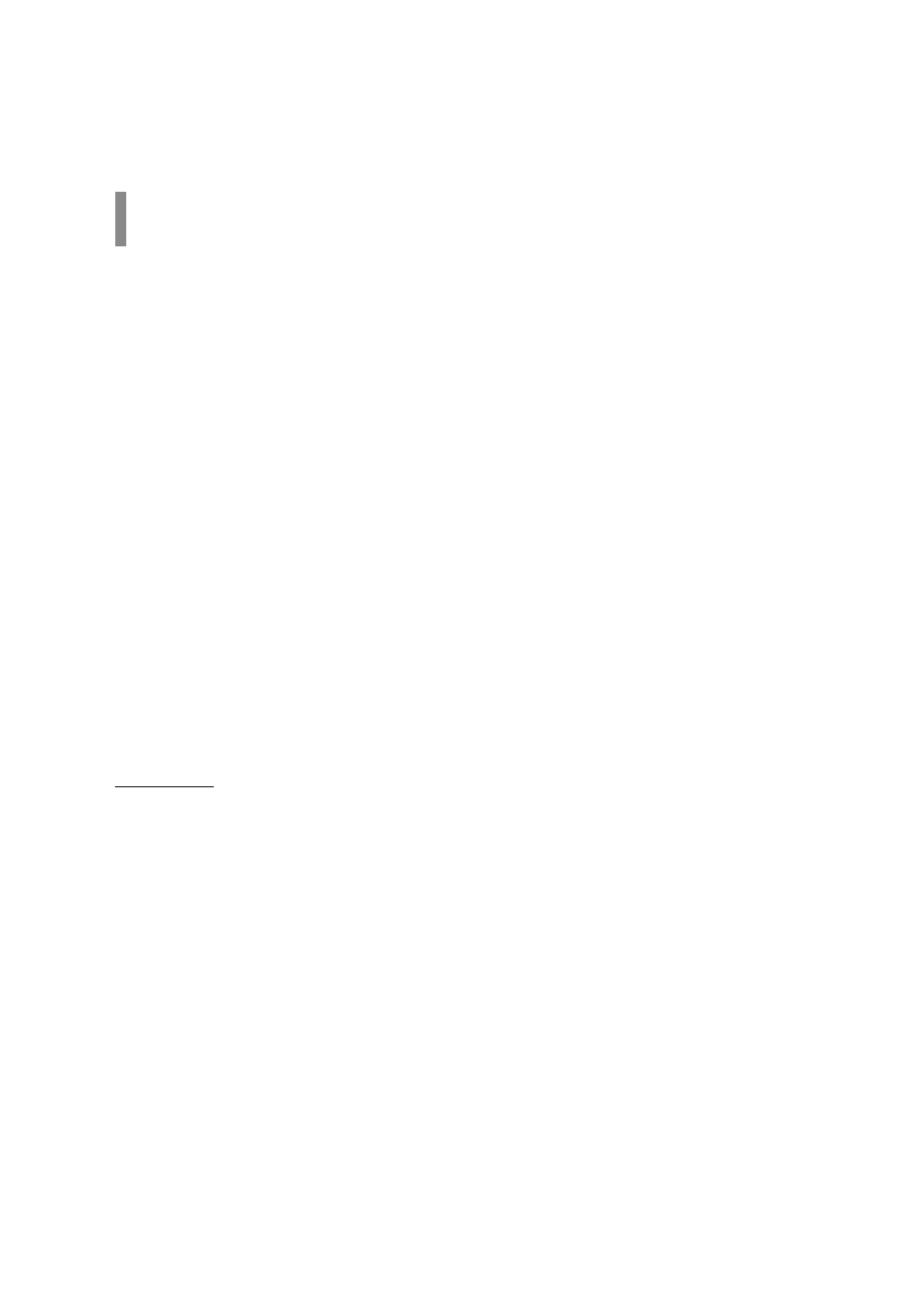
Introduzione
Il commentario alla legge 13 luglio 2015, n. 107, meglio nota come “La buona scuo-
la” dal nome del documento primigenio che ne sta a fondamento culturale, rappresenta,
al momento, un
unicum
, un esperimento senza immediati precedenti volto a traspor-
re, sulla normativa scolastica, le metodologie di lavoro proprie delle altre branche del
diritto: per l’appunto, il commentario. E, dunque, una trattazione per quanto possibile
sistematica, che possa essere di aiuto alla platea di ideali lettori: dirigenti scolastici e
amministrativi, insegnanti, decisori politici; ma anche docenti e studenti universitari.
L’esegesi della normativa scolastica in generale, e dunque della L. 107/2015, non
può che rifuggire dalla mera descrizione del fatto giuridico ed essere innanzitutto
“critica”, nel senso tecnico del termine
1
; “storica”e “filologica”
2
, nella ricostruzione
paziente della
ratio legis
e dei suoi eventuali ondeggiamenti. Pena, l’incomprensibilità
del fatto giuridico stesso.
La struttura finale della legge ha imposto un prioritario lavoro di ricomposizione
del testo, che risulta pertanto diviso in capitoli e paragrafi dal contenuto, per quanto
possibile, omogeneo. Del resto, una certa eterogeneità era propria anche dell’atto
originale, e risultava accentuata dall’attività emendativa parlamentare. L’articolo uni-
co è stato dunque suddiviso in 10 capitoli, con un ordine frutto delle, per quanto
opinabili, sensibilità del curatore.
Il capitolo I è dedicato all’autonomia delle istituzioni scolastiche, che rappresenta-
no il fulcro del provvedimento e della “buona scuola” che già è
3
.
1
Dal greco
κρὶνω
(distinguo), l’attività critica presuppone l’analisi e la valutazione del suo
oggetto.
2
“Filologia è quella onorevole arte che esige dal suo cultore soprattutto una cosa, trarsi da parte,
lasciarsi tempo, divenire silenzioso, divenire lento, essendo un’arte e una perizia da orafi della
parola, che deve compiere un finissimo attento lavoro e non raggiunge nulla se non lo raggiunge
lento. Ma proprio per questo fatto è oggi più necessaria che mai; è proprio per questo che essa ci
attira e ci incanta quanto mai fortemente, nel cuore di un’epoca del “lavoro”: intendo dire della
fretta, della precipitazione indecorosa e sudaticcia, che vuol “sbrigare” immediatamente ogni cosa
(…). Per una tale arte non è tanto facile sbrigare qualsiasi cosa perché essa ci insegna a leggere
bene, cioè a leggere lentamente in profondità, guardandosi avanti e indietro, non senza secondi
fini, lasciando porte aperte, con dita e con occhi delicati”, Friedrich Nietzsche, Prefazione ad
Aurora
, autunno 1886, tit. or.
Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile
, Chemnitz 1881.
3
Corre il piacere di ricordare, tra le tante iniziative di dirigenti scolastici “innovatori”, attuate
a normativa vigente, le opere di Salvatore Giuliano, dirigente dell’IIS “Ettore Majorana” di
Brindisi (Book in progress, utilizzo capillare delle tecnologie informatiche, etc -
http://www.majoranabrindisi.it/) e di Amanda Ferrario, dirigente del Liceo “Tito Livio” di Milano, volta
all’istituzione di un curriculum bilingue utile all’iscrizione nelle migliori università anglosassoni
(http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/09/01/news/milano_scuola_inglese-121983098/).
















