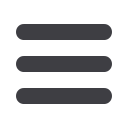
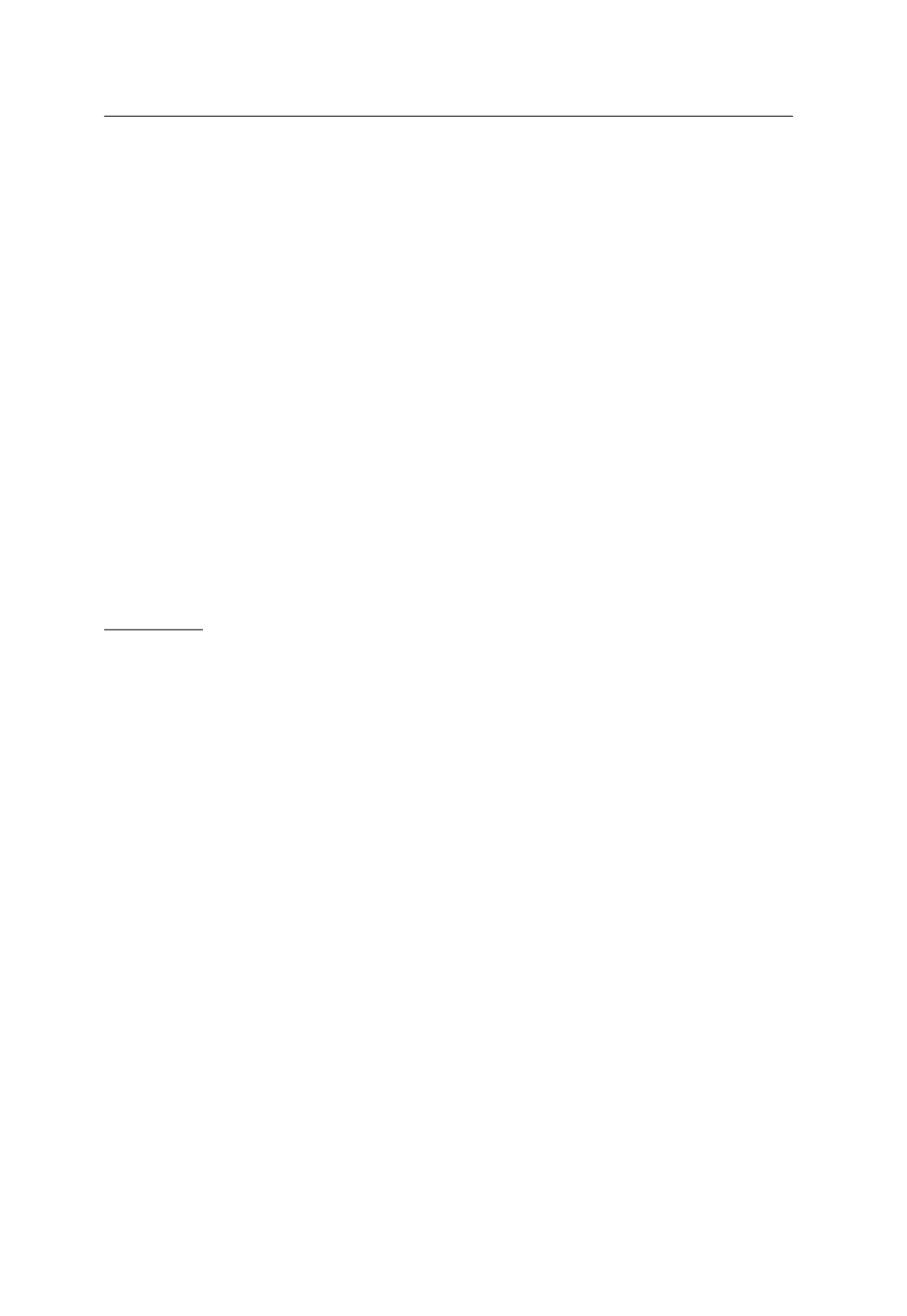
VIII
Prefazione
Occorrerebbe, per l’istruzione, insediare una
Law commission
4
, in grado di lavorare
stabilmente con una panoplia di robusti rasoi di Occam e che ne abbracci senza ten-
tennamenti la
lex parsimoniae
: “
Entia non sunt moltiplicanda praeter necessitatem
”; “
plu-
ralitas non est ponenda sine necessitate
”; “
frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora
”
5
.
Con l’avvertenza che, ad oggi, la metodologia risulta, all’opposto, volta a trasformare
il semplice in complesso attraverso l’inutile.
Ora, pure in tale marasma, alcune acquisizioni culturali riescono a resistere nel
tempo e a sedimentarsi. L’inclusività di Franca Falcucci, l’autonomia di Luigi Ber-
linguer, la personalizzazione e l’attenzione al rapporto scuola/mondo del lavoro di
Letizia Moratti sono, al di là degli schieramenti e delle furibonde polemiche (spesso
pretestuose) che li accompagnarono, elementi acquisiti nel “vocabolario scolastico”.
Decisamente meno fortunato, anche per la concomitante stagione di tagli, il “merito
dei docenti” di Mariastella Gelmini, tema sul quale peraltro si infranse il dicastero
Berlinguer
6
. Ma queste stesse istanze si trovano, sovente, soffocate da un reticolo
di disposizioni, di iura
7
e rescritti
8
, da un barocchismo procedurale (per rimanere
a Dante: “il troppo e il vano”), da un intrico di desideri fattisi diritti che rendono
le regole dell’istruzione un coacervo inestricabile di buoni e solidi principi e orrori
giuridici, ove spesso la moneta buona si ritrae spaventata di fronte all’inflazione e alla
pervicacia di quella cattiva. Consola, ma non troppo, pensare che il cattivo costume
4
http://www.lawcom.gov.uk/.Istituita nel 1965 attraverso il
Law Commission Act
, grazie
all’azione del Lord Cancelliere Gerald Austin Gardiner, è un organismo tecnico indipen-
dente, chiamato alla costante revisione della legislazione del Regno Unito con l’obiettivo di
mantenerla “
fair, modern, simple, effective
”; di condurre ricerche e consultazioni da tradurre in
raccomandazioni per il parlamento; di eliminare anomalie, sovrapposizioni, obsolescenze dal
corpus giuridico e di ridurre il numero degli “statutes”.
5
“
Non moltiplicare gli enti oltre il necessario; non considerare la pluralità se ciò non è necessario; è inutile
fare con più ciò che si può fare con meno
”. La prima massima si deve a John Punch (Cork, Irlanda, 1603-
1661), filosofo e teologo francescano, nella formula “
Non sunt moltiplicanda entia sine necessitate
”,
nel commentario alle opere di John Duns Scoto nel 1639; la seconda per l’appunto a Duns Scoto
(Ordinatio, 1300-1304), la terza a Ockham (Summa totius logicae, 1323).
6
Il CCNL comparto scuola del 1999 prevedeva, all’articolo 29, una maggiorazione economica
annua lorda pari a 6 milioni di lire a partire dal 1° gennaio 2001, destinata al 20% dei docenti
con almeno 10 anni di carriera. Il CCNI, all’articolo 38, stabiliva i criteri per il concorso
nazionale, articolato in 3 fasi: il curricolo professionale (25%), la prova strutturata nazionale
(25%), la verifica in situazione (50%). Indetto con Decreto direttoriale del 23 dicembre 1999,
il “concorsone” fu sospeso con Decreto direttoriale 7 febbraio 2000.
7
Col termine
iura
si definiscono, nel diritto romano, i principi estrapolati dagli Editti pretorii o
dalle opere dei giureconsulti. Nel 426, nel tentativo di mettere ordine al caos, l’imperatore Valenti-
niano III, con la Legge delle citazioni (Oratio Valentiniani ad Senatum), stabilì che avessero valore
vincolante le opinioni di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino.
8
Il
rescriptum principis
era la risposta data a un quesito, attinente a questioni giuridiche, rivolto
all’imperatore, la cui risposta, introdotta dalla clausola “
si vera sunt ea quae complexa est
”, assu-
meva il rango di indirizzo generale sulle questioni affrontate. Difficile non pensare alle odierne
“note” e “circolari”.
















