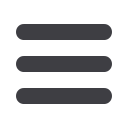
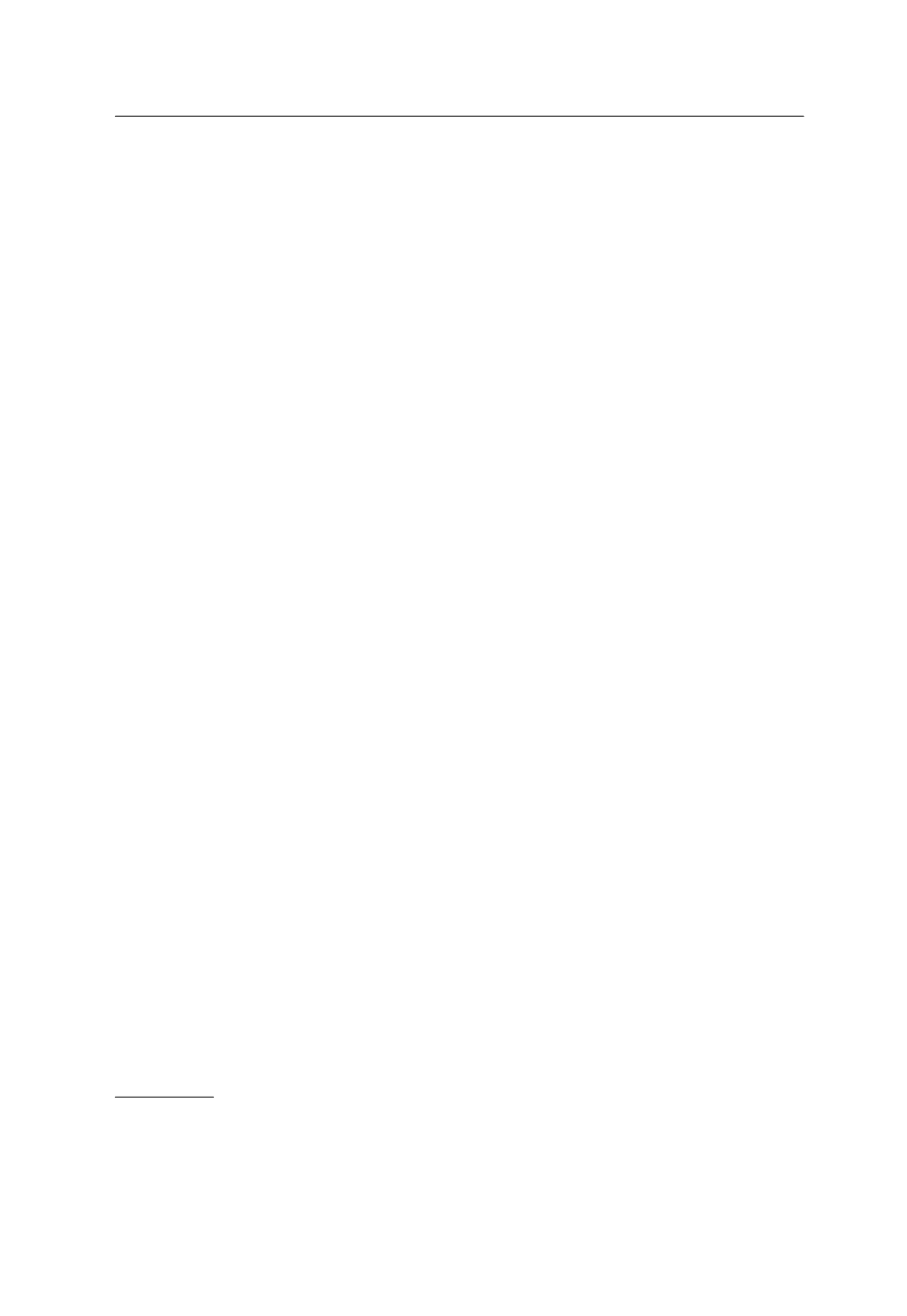
Prefazione
XI
assurgono nell’attività quotidiana al rango di Tavole della Legge), ma al diritto ammi-
nistrativo, al diritto del lavoro, al diritto civile e penale, al diritto comunitario. Pochi,
pochissimi esperti, spesso formati, come chi vi scrive, dalla pratica quotidiana, più
che da (inesistenti) scuole giuridiche. Non è previsto, accademicamente, un settore
scientifico disciplinare autonomo e l’insegnamento impartito negli Atenei, quando
c’è, è variamente attribuito ai settori pedagogici o giuridici. Mancano scuole di dot-
torato. Con l’effetto che il cultore della specifica disciplina è un “figlio di nessuno”.
Né i giuristi, né i pedagogisti lo riconoscono come proprio consanguineo e dunque
difficilmente si rendono disponibili a tradurre in cattedre, e dunque in “scuole”, un
impegno gravosissimo. Per non parlare della scelta di dove pubblicare, essenziale ai
fini del
cursus honorum
accademico. Dunque, nessun esperto “riconosciuto”
13
. Il che si
ripercuote sulla qualità delle disposizioni e del
corpus
complessivo, perché chi è chia-
mato alla consulenza tecnico-giuridica ha sovente una preparazione non specialistica,
tutt’al più parziale, e dunque difficilmente è in grado tanto di valutare sia le ripercus-
sioni sul sistema complessivo, sia le eventuali difficoltà nell’applicazione pratica di
quanto statuito.
La buona scuola
La legge in commento non sfugge ai condizionamenti sopra citati. La natura com-
posita del testo e passaggi parlamentari tutt’altro che indolori sono facilmente riscon-
trabili: né sono, va sottolineato più volte, dovuti al “colore” dei proponenti: quasi
ogni provvedimento che riguardi l’istruzione, qualsiasi sia lo schieramento che ne
è padre, mostra in misura maggiore o minore evidenti “zeppe” e “accomodamenti”.
Il che non significa che la legge 107/2015 non sia una buona legge, anzi: i suoi effetti
si vedranno, almeno così ci si può augurare, nel medio periodo, a partire dalle inno-
vazioni, puntualmente segnalate, che, a prescindere dalla necessità o meno di qualche
ritocco, più sono potenzialmente in grado di incidere sulla qualità degli apprendimenti.
Sempre che, come sovente accade, la fase attuativa non ne stravolga i connotati, e che i
veri “attori” (dirigenti scolastici, ispettori, docenti…) ne sappiano cogliere le opportu-
nità, al di là delle proteste o dell’adesione meramente formale a questa o quella parola
d’ordine, buone l’una e l’altra per la piazza o per le ritualità dei convegni, ma non per
un’aula scolastica.
La genesi del provvedimento, di cui è opportuno dare breve conto, ha come sca-
turigine l’ampio documento “La buona scuola”, presentato nel settembre 2014 e sot-
toposto, prima di tradursi in proposte normative, a un dibattito pubblico frontale
e telematico. Attraverso l’articolo 1, commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 (Legge di stabilità per il 2015) fu creato un capitolo dove accantonare le neces-
sarie (seppur parziali) coperture, volte in primo luogo alla definizione di un piano di
13
Tra i pochi “maestri” del Diritto scolastico, corre l’obbligo di ricordare Livia Barberio
Corsetti, capo dell’Ufficio Legislativo durante il dicastero Berlinguer, scomparsa nel 2008,
e Sergio Auriemma, oggi Vice procuratore generale alla Corte dei Conti, ma con una lunga
carriera in Viale Trastevere.
















