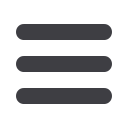

Prefazione
IX
non sia frutto dei tempi moderni, se è vero che a ridosso dell’unità d’Italia il Ministro
all’istruzione pubblica, Francesco De Sanctis, era costretto a rispondere a interroga-
zioni su sperdute graduatorie di bidelli.
Dietro la normativa
Perché? Alle spalle del decisore politico, ci sono, innanzitutto, “visioni di scuo-
la”, spesso alternative e, frequentemente, trasversali a parti di schieramenti. Manca,
sostanzialmente, una tavola di valori condivisa che consenta di stabilizzare il nocciolo
della normazione primaria. Alcune dicotomie classiche sono costituite, ad esempio, da
“centralizzazione
vs
autonomia”; “merito
vs
anzianità”; “competenze
vs
conoscenze”;
“inclusione
vs
selezione”. Per singolare paradosso, dette dicotomie si trovano non
solo a susseguirsi anziché sostituirsi, ma a convivere e a confliggere permanentemente
e non, come sarebbe auspicabile, a comporsi e ad integrarsi quando possibile e utile.
Nulla vieterebbe, ad esempio, di contemperare “selezione” e “inclusività”: solo
che raramente accade, e il quieto vivere induce alla diffusione di una deleteria pratica
di abbassamento delle asticelle, specie nella scuola primaria. Se, in un tempo non
troppo lontano, la parola d’ordine di ogni docente era “stare al passo del program-
ma”, oggi al contrario sembra prevalere la discutibile prassi di ragguagliare il ritmo
di marcia agli studenti più deboli. Non solo ciò è il contrario del concetto di perso-
nalizzazione che implicherebbe l’adozione di strategie differenziate al fine di portare
i discenti al più alto grado di istruzione possibile; ma si rivela sovente esiziale per la
gestione delle classi, ingenerando noia e indisciplina nei più svegli e preparati. Oltre
che essere una pratica, al fondo, classista, perché privilegia, indirettamente, gli stu-
denti con la possibilità di acquisire all’esterno gli stimoli deboli quando non assenti
nella quotidianità scolastica.
La logica appare prevalentemente quella del “ma anche”. Prendiamo l’autonomia
delle istituzioni scolastiche. Esiste dal 1999, “ma anche” esiste la gestione rigidamente
centralizzata del personale, che è, a ben vedere, in netto contrasto con i principi dell’au-
tonomia: uno sguardo ai sistemi scolastici internazionali mostra come l’autonomia è
sempre fondata, in primo luogo, sulla responsabilizzazione di chi è chiamato a erogare
il servizio anche in merito alla scelta del personale e dal necessario corollario di rigorosi
e trasparenti controlli
9
.
Un secondo aspetto va evidenziato. Nel processo decisionale hanno peso le atten-
zioni, più o meno pronunciate, ai portatori di interesse istituzionali. Confindustria,
sindacati, il mondo dell’associazionismo che raccorda i diversi protagonisti della
“repubblica scolastica” (docenti, genitori, studenti, senza dimenticare il vivacissimo
settore dell’inclusione), sono stakeholder, peraltro segmentati da coloriture politiche,
religiose e culturali, che intervengono nel processo di costruzione normativa.
Infine, con sempre maggiore incidenza, anche grazie all’avvento dei social network
e in particolare di Facebook, si fa sentire la voce di portatori di interessi settoriali,
9
Si rinvia al ricco materiale presente sul portale di Eurydice,
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page.
















