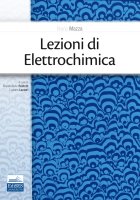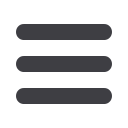
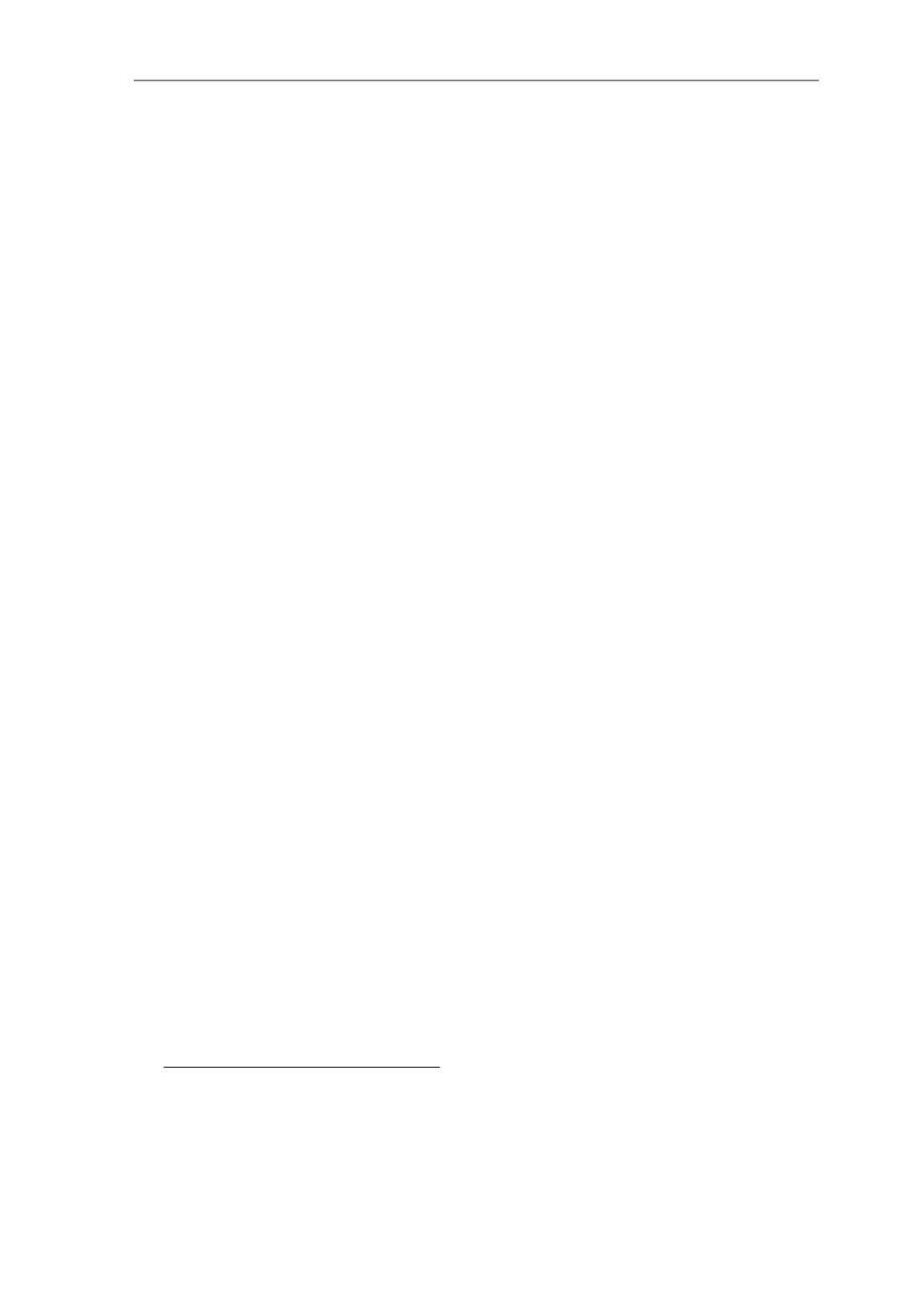
134
Bruno Mazza
Lezioni di Elettrochimica
e soluto. Facciamo ancora il caso generale in cui la dissociazione non sia completa, ma
corrisponda ad un equilibrio caratterizzato dal valore del grado di dissociazione.
Come si è visto, le attività ioniche individuali possono essere espresse come:
ελ
= γ
ε
∙
λ
,A
eq
Le molalità relative alle specie ioniche possono poi essere espresse, in funzione della
molalità stechiometrica bruta iniziale di W, come segue:
,A
eq
= ∙ ∙
W,A
ε
Sostituendo nella (8.1), otteniamo l’espressione dell’attività di W in ε riferita a D:
W
εD
= [ ( γ
+
ελ
)
+
( γ
−
ελ
)
−
] ∙ [
+
+
∙
−
−
] ∙ (
W,A
ε
)
Introducendo, a titolo di definizione, un
coefficiente di attività ionico medio
in ε:
±
ε
dato da:
(
±
ε
) ≡ ( γ
+
ελ
)
+
( γ
−
ελ
)
−
tenendo conto che
+
+
e ponendo:
Q =
+
+
∙
−
−
l'attività di W riferita a D risulta:
W
εD
= (
±
ε
∙ Q∙
W,A
ε
)
dove Q e
W,A
ε
sono grandezze stechiometriche.
8.3
Determinazione sperimentale delle attività
Le misure sperimentali di attività di W
5
permettono di risalire al coefficiente di attività
ionico medio,
±
ε
, confermando che:
1.
quelle che hanno significato operativo sono sempre grandezze relative alle specie
neutre;
±
ε
ha significato operativo, ma non i coefficienti di attività ionici
individuali;
2.
il coefficiente di attività che si determina sperimentalmente non solo è una media
relativa ai vari ioni, ma include un fattore derivante dal grado di dissociazione:
per via puramente termodinamica non è possibile separare gli effetti derivanti
dalla dissociazione parziale di W, da quelli derivanti dalle cause di scostamento
dal comportamento ideale della soluzione.
5
La determinazione sperimentale delle attività può essere effettuata, per quanto concerne il solvente, mediante
i seguenti metodi: osmotici, crioscopici, ebullioscopici e mediante misure di tensione di vapore del solvente.
Per quanto concerne il soluto, si può ricorrere ai metodi basati sulla determinazione di tensione di vapore del
soluto, su determinazioni di solubilità, di forze elettromotrici, di coefficienti di ripartizione tra solventi diversi,
ecc.. Sono note, inoltre, dal corso di Chimica-Fisica le relazioni generali tra le variazioni dei potenziali
chimici dei componenti di un sistema (
equazione di Gibbs-Duhem-Margules
), per cui dalle attività di un
componente si può risalire a quelle dell’altro.