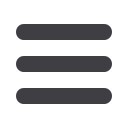
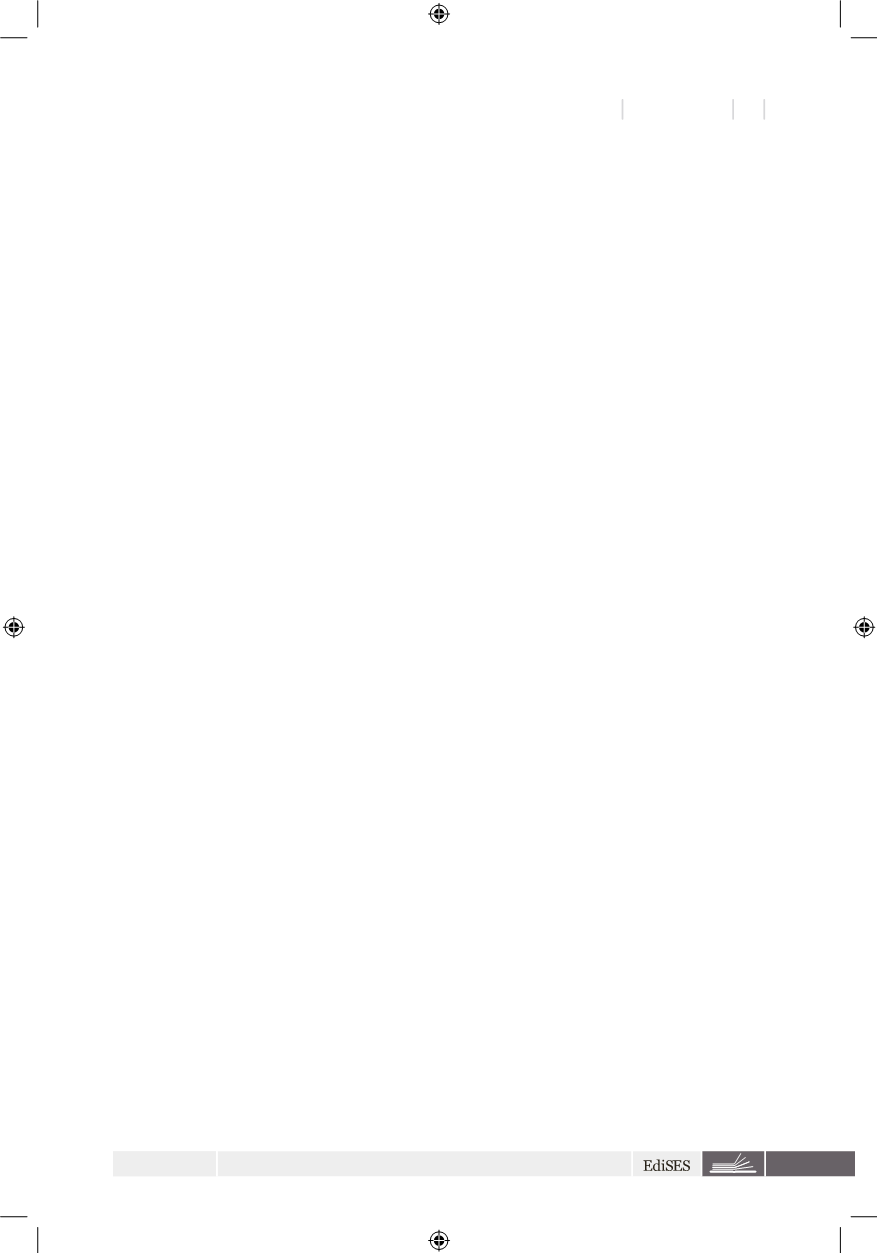
www.
edises
.it
CAPITOLO
4
Che cos’è la vita?
63
(capitolo 1) e allo stesso modo mostrare agli alunni che la biologia è ancora oggi una
disciplina nella quale si inseguono grandi domande.
Se attraverso un programma informatico fossimo in grado di fornire le istruzioni
per assemblare un organismo artificiale? È la grande sfida cui sta lavorando Craig
Venter e il suo gruppo di ricerca. Per chi non lo sapesse, Venter è una delle persone
che più ha contribuito a far progredire la biologia negli ultimi trent’anni. È noto al
grande pubblico soprattutto per aver sviluppato un criterio che ha accelerato enor-
memente il sequenziamento del genoma umano, innestando una competizione con
il consorzio pubblico, e giungendo alla fine alla presentazione simultanea dei risul-
tati (Venter, 2013).
In seguito ha sviluppato un programma particolarmente ardito, mediante il quale è
riuscito a trasformare una specie in un’altra. Quello che è stato fatto è trapiantare
da una specie all’altra l’intero genoma come DNA nudo. È stato prelevato il DNA
genomico da una colonia di
Mycoplasma mycoides
(un batterio) ed è stato inserito
in un altro batterio,
Mycoplasma capricolum
, precedentemente svuotato del suo DNA
originario. Queste nuove cellule risultano identiche a quelle di
Mycoplasma mycoides
(Lartigue
et al.
, 2007).
Nel 2010, assieme alla sua équipe, Venter pubblica un articolo (Gibson
et al
., 2010)
nel quale annuncia di aver realizzato la prima forma di vita artificiale: è una cellula
naturale completamente controllata da un DNA artificiale, pensato ed elaborato al
computer come fosse un programma di assemblaggio. In questo caso dunque il DNA
non è prelevato da un altro organismo, ma assemblato nucleotide per nucleotide
partendo da una sequenza immagazzinata in un computer.
Secondo Venter sarà possibile avere organismi unicellulari “artificiali” (ossia pro-
gettati al computer), assemblando nucleotide per nucleotide le istruzioni per svol-
gere determinati compiti, quali ad esempio il degrado e la digestione dei rifiuti, o
la produzione di idrocarburi, o ancora la lotta contro le malattie infettive. È una
strada pionieristica, i ricercatori che la stanno intraprendendo hanno appena mos-
so i primi passi. Però in questi anni è un campo che si è sviluppato e che, pur rac-
contato e comunicato con un certo sensazionalismo (si veda il capitolo 1), permette
di avvicinarsi ad alcune frontiere della scienza.
È difficile non rimanere allo stesso tempo turbati e affascinati da queste prospet-
tive. Diversi scienziati si sono posti dei problemi circa queste applicazioni (Dana
et
al
., 2012); lo stesso Venter si è reso conto che arrivare a progettare degli organismi
(finalizzati a uno scopo ben preciso) è qualcosa che va molto oltre quello che fino ad
ora ha fatto l’umanità, e che è necessario avere ben presente fin da ora che questo
approccio può essere un’arma a doppio taglio. Ma è stato così per quasi tutte le sco-
perte della storia dell’uomo.
La visione di Venter è completamente meccanicistica ed ingegneristica (non a caso
parla di hardware e software della vita), e per questo motivo diversi biologi la rigetta-
no (ci sono evidenze sperimentali per farlo). Gli insegnanti potrebbero trarre molti
spunti di riflessione mettendo in discussione critica l’approccio di Venter per eviden-
ziare rischi e opportunità.
















