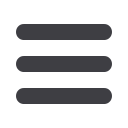

208
CAPITOLO
7
Sessualità, riproduzione e sviluppo
cellule sono facilmente distinguibili al microscopio
ottico dalle cellule germinali perché dotate di una
forma quasi triangolare, nucleo ovale e citoplasma
chiaro. Il loro ruolo nel fornire nutrimento e suppor-
to meccanico alle cellule germinali, così come nel
fagocitarle in caso di degenerazione, è essenziale.
Non a caso, tra le cellule germinali e quelle del Serto-
li si sono sviluppati fini meccanismi di comunicazio-
ne necessari perché la spermatogenesi si concluda
correttamente; essi includono giunzioni strette (tight
junctions) e comunicanti (gap junctions) (vedi Cap.
3), comuni ad altri epiteli, e le specializzazioni ecto-
plasmiche, tipiche del testicolo e ricche in actina.
Queste ultime giunzioni si possono distinguere, a
loro volta, in basali ed apicali: le prime, insieme alle
tight e gap junctions, formano la
barriera ematote-
sticolare
(
BTB
,
Blood-Testicular Barrier
); le seconde
consentono alle cellule del Sertoli di interagire con
gli spermatidi in allungamento. La barriera ematote-
sticolare controlla il passaggio di molecole tra il
compartimento basale e luminare, il primo caratte-
rizzato da attive mitosi delle cellule germinali, il se-
condo occupato prevalentemente dagli stadi meioti-
ci, impedendo che cellule germinali immature pos-
sano diffondere incontrollate. La barriera ematote-
sticolare evita anche che dal circolo ematico giunga-
no sostanze dannose capaci di interferire con la re-
golare progressione della spermatogenesi e che pro-
teine degli spermatozoi vengano emesse nel circolo
sanguigno, dove potrebbero innescare reazioni au-
toimmuni.
Le
cellule germinali
vanno incontro a ripetute di-
visioni mitotiche (fase di proliferazione), ricombina-
zione genetica e riduzione del patrimonio genetico
(fase di meiosi) e differenziamento (gli spermatidi si
differenziano in spermatozoi; fase di differenziamen-
to). Gli spermatogoni sono le cellule germinali più
immature ed indifferenziate, localizzate nella lamina
basale dell’epitelio seminifero. Esse sono capaci di re-
plicarsi ripetutamente. Così facendo, nella forma di
spermatogoni
di
tipo A
, possiedono caratteristiche di
cellule staminali, capaci cioè di self-renewal o auto
-
rinnovamento. Gli spermatogoni di tipo A sono an-
che capaci di dare origine a spermatogoni più maturi,
di
tipo
B
, che rappresentano le cellule progenitrici
degli spermatociti. Gli spermatogoni di tipo B accre-
scono il proprio citoplasma (processo di auxocitosi)
trasformandosi in
spermatociti
I
o
primari
, cellule di-
ploidi che entrano in meiosi. Ogni spermatocita I ge-
nera due
spermatociti
II
in seguito alla prima divisio-
ne meiotica. Gli spermatociti II sono cellule aploidi
che subiscono una seconda divisione meiotica per
dare origine a spermatidi rotondi. Così come previ-
sto dalla meiosi (vedi Cap. 6), i quattro spermatidi
rotondi prodotti (da ogni spermatocita I) hanno su-
bito un profondo rimescolamento genico risultando
così diversi tra di loro e dalla cellula che li ha genera-
ti. Ad ogni modo, gli spermatidi sono cellule roton-
deggianti ed immotili che dovranno subire impor-
tanti cambiamenti per diventare gli spermatozoi mo-
tili in grado di fecondare la cellula uovo. Tali cambia-
menti hanno luogo durante la
spermiogenesi
anche
detta
spermioistogenesi
. Questo processo di differen-
ziamento ha finalità importanti: la formazione dell’a-
crosoma e del flagello, la delocalizzazione dei mito-
condri verso il flagello, l’eliminazione di gran parte
del citoplasma così da assumere una forma aerodina-
mica.
Il primo ad identificare testa e coda dello sperma-
tozoo al microscopio fu il fiammingo Antony van
Leeuwenhoek nel 1677 che definì gli spermatozoi de-
gli “animalculi”, cioè piccoli animali, presenti nel
seme.
La
spermiogenesi
può essere suddivisa in quattro
fasi:
fase del Golgi
,
fase del
cappuccio
,
fase acrosomica
e
fase
di maturazione
. Durante la prima fase si assi-
ste alla formazione della vescicola acrosomiale a
partire dall’apparato del Golgi dal quale si staccano
numerosi granuli proacrosomici che si fonderanno
in un’unica grande vescicola. Durante la fase del
cappuccio la vescicola acrosomiale riveste il nucleo
dello spermatozoo anteriormente per due terzi; nel
frattempo, il centriolo prossimale migra posterior-
mente al nucleo, mentre il centriolo distale forma il
corpuscolo basale del flagello (o coda dello sperma-
tozoo). Durante la fase acrosomica il nucleo si de-
centra occupando la testa dello spermatozoo ed al
suo interno la cromatina sarà fortemente condensa-
ta; nel frattempo, i mitocondri migrano verso l’asso-
nema, ovvero lo scheletro del flagello (vedi paragra-
fo successivo). Durante la fase di maturazione lo
spermatozoo acquisisce l’aspetto caratteristico della
specie, elimina gran parte del citoplasma attraverso
l’espulsione di piccole vescicole dette
corpi
residui
che saranno fagocitati dalle cellule del Sertoli, così
da risultare una cellula con un maggior grado di ae-
rodinamicità.
Una struttura microtubulare fondamentale sia per
la morfologia della testa, sia per la formazione della
coda dello spermatozoo è la
manchette
. Si tratta di
















