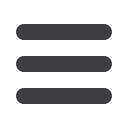

www.
edises
.it
62
Parte Prima
Competenze pedagogico-didattiche
talmente sugli stati di coscienza che appaiono irriducibili alle immagini
mentali e alle sensazioni.
26) B.
Lawrence Kohlberg, a partire dallo schema di Piaget, ha esteso lo
sviluppo morale fino all’età adulta, individuando sei stadi raggruppati in tre
livelli (moralità preconvenzionale, convenzionale e postconvenzionale).
Egli sottolinea il ruolo costruttivo del bambino nell’elaborazione del pensie-
ro relativo a soggetti morali e sottolinea, d’accordo con Piaget, lo stretto
legame tra lo sviluppo cognitivo e quello morale.
27) D.
Nell’immediato dopoguerra sorse negli Stati Uniti un movimento
psicologico che si occupò di studiare la percezione secondo un’ottica com-
pletamente diversa da quella allora dominante. Il
vecchio
punto di vista era
quello dei gestaltisti, che escludevano nel processo percettivo l’intervento
di qualsiasi fattore diverso da quelli propri della dinamica del campo per-
cettivo. Il nome
New Look on perception
fu dato al movimento da Krech
(1949). Gli psicologi del New Look volevano studiare l’influenza che fattori
quali le variabili personologiche, quelle sociali, i valori, i bisogni, le moti-
vazioni e i giudizi probabilistici hanno sulla percezione.
28) B.
Con il concetto di
forza dell’abitudine
, o
habit strength
, una variabile
interveniente introdotta negli anni ’30 da Clark Hull, si vuole intendere il
fatto che le risposte si associano agli eventi di stimolazione con differente
forza, e che tale forza dipende da un certo numero di variabili, tra le quali
hanno particolare rilevanza lo stato pulsionale dell’organismo che appren-
de le risposte, il numero di ripetizioni del compito, ecc.
29) C.
La nozione che altri pensano e provano sentimenti diventa sofisti-
cata e coerente con il passare del tempo. La capacità di immaginare degli
stati mentali negli altri e di vederli come la base di una condotta esplicita è
stata considerata come la prova che i bambini possiedono una
teoria della
mente
. Una tale teoria consente al bambino di spiegare eventi visibili (le
azioni delle persone) postulando l’esistenza di entità invisibili (convinzio-
ni, desideri e così via); essa rappresenta quindi uno stratagemma per capi-
re il comportamento sociale.
30) A.
Secondo Bandura, per valutare la nostra autoefficacia noi ci rifac-
ciamo a successi o fallimenti in cui siamo incorsi in situazioni simili; alle
esperienze vicarie, cioè guardando gli altri fallire o avere successo in situa-
zioni simili; alla persuasione, ossia al sentirci dire da altri che siamo capa-
ci di affrontare quel particolare compito; e allo stato fisiologico, ossia a
quanto la nostra ansia o le nostre paure possono incidere sull’esecuzione
del compito.
















