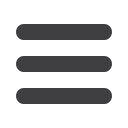
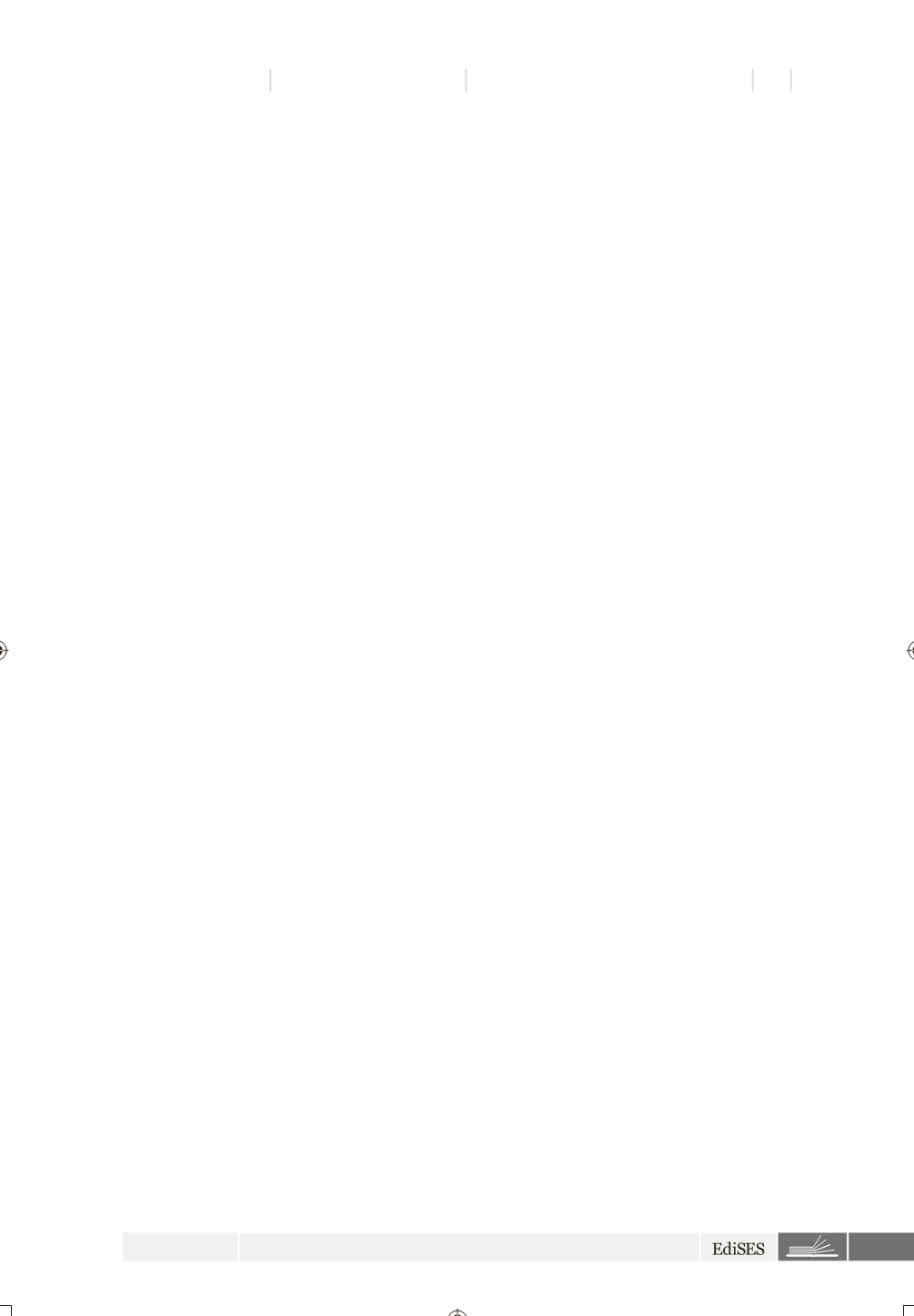
www.
edises
.it
Unità di Apprendimento 2
Il mito delle Sirene nella letteratura latina
517
“Notiamo come i fanciulli neppure dalle percosse si lascino distogliere dall’os-
servare e dall’indagare su tutto? Come, cacciati via, subito ritornino? Come
siano felici di sapere qualche cosa? Come siano smaniosi di raccontarla agli
altri? Come si incantino davanti ad un corteo, ai giochi pubblici e a spettacoli
del genere no a sopportare per queste manifestazioni la fame e la sete? E
poi, quelli che hanno il gusto dello studio e delle arti, non vediamo che non
s’interessano né della loro salute né degli affari di famiglia e resistono a tutto,
dominati proprio dal desiderio d’imparare e di sapere e si tengono ripagati
dalle gravi preoccupazioni e fatiche dal piacere che provano nell’imparare?
Perciò, ho l’impressione, Omero ha avuto presente una condizione simile nel
presentare il mito del canto delle Sirene. Infatti appare che non con la dolcezza
della voce o con una qualche novità e varietà del canto esse solevano incantare
i naviganti, ma perché proclamavano di sapere molte cose, cosicché gli uomini,
trascinati dal desiderio di sapere, restavano contti ai loro scogli. Ecco l’invito
ch’esse rivolgevano ad Ulisse (ho tradotto, insieme ad altri versi di Omero,
proprio questo passo):
O gloria degli Argivi, Ulisse, perché non volgi la nave
per poter prestare l’orecchio ai nostri canti?
Nessuno mai passò oltre nella sua rotta su queste onde azzurre,
senza prima essersi fermato, preso dalla dolcezza dei nostri canti,
per andarsene poi, saziato l’avido cuore di multiformi melodie,
a raggiungere, fatto più sapiente, i patrii lidi.
Noi ben conosciamo la guerra terribile e il disatro
che la Grecia, per volontà degli dei, apportò a Troia,
e tutti gli eventi che hanno lasciato traccia sulla vasta terra.
Omero si è reso conto ch’era impossibile dar credito al mito, se un eroe di
quella statura si fosse lasciato irretire da canzonette; promettono la scienza,
e non fa meraviglia che questa ad un uomo desideroso di sapere sia più cara
della patria”.
Tr. di F. Demolli
Il brano in questione acquista la sua importanza in quanto si presenta pale-
semente come il modello assunto da Dante per la costruzione del suo Ulisse
nel XXVI Canto dell’
Inferno
. L’esame contrastivo tra i due passi si impone in
sede didattica per rendere consapevoli gli studenti della rete di richiami e di
in%uenze che anima il discorso letterario. Si tratta, dunque, di un brano che
consente l’allargamento interdisciplinare: oltre agli scontati riferimenti al testo
omerico (
Odissea
XII 39-54; 184-191) e al già citato episodio dantesco, non va
dimenticata l’affascinante ricostruzione che ne fa Giovanni Pascoli nei
Poemetti
Conviviali
(XXI e XXIII).
















