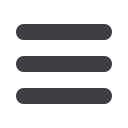

Capitolo
7
Socrate
71
7.2
Le linee generali della filosofia di Socrate e la
metodologia dialogica
La filosofia di Socrate, nonostante le difficoltà interpretative dovute al fatto che
il pensatore ateniese non ha lasciato alcuna opera scritta, presenta comunque
degli aspetti di fondo che la mettono in relazione con il contesto filosofico
precedente. Di particolare importanza è il rapporto che Socrate intrattiene
con i sofisti. Come questi ultimi, anche Socrate si distanzia in maniera netta e
decisa dalle esperienze delle indagini naturalistiche della scuola di Mileto e di
Elea. L’affinità con la sofistica porta però i suoi contemporanei a un equivoco
di fondo. Agli occhi di molti ateniesi e di Aristofane, infatti, Socrate viene assi-
milato alla filosofia sofistica, per cui le accuse rivolte a questa, soprattutto per il
suo estremo relativismo, vengono rivolte anche a lui. Bisogna però chiarire che
Socrate condivide sì con i sofisti l’oggetto della propria riflessione, ossia l’uo-
mo, e l’idea che tutto debba essere sottoposto alla critica della ragione evitando
il ricorso alla tradizione, ma da essi si differenzia per lo scopo della propria
ricerca filosofica consistente nel
recuperare la verità superando il relativismo
sofistico
. Egli concepisce la filosofia stessa come un’indagine in cui l’uomo
cerca di chiarire a se stesso la propria natura, ma, a differenza dei sofisti, non
farà mai uso della sua sapienza a scopi utilitaristici, né, soprattutto, giungerà su
posizioni estreme di scetticismo come quelle di Gorgia. Secondo Socrate esiste,
infatti, una
verità
che è
dentro di noi
. Il lavoro del filosofo deve essere quello
di far emergere tale verità attraverso il ragionamento. In questa prospettiva
Socrate fa suo il motto dell’oracolo di Delfi che recita
Conosci te stesso
: soltanto
guardandosi dentro l’uomo può giungere alla verità.
Come detto, Socrate, in ossequio ai suoi imperativi teorici, secondo cui la filo-
sofia è una continua ricerca che non può essere fissata con l’inchiostro, altri-
menti si arresterebbe, non ha lasciato scritti. Per questo motivo lo strumento
utilizzato da Socrate nelle sue dimostrazioni, per portare alla luce la verità, era
il
dialogo
.
Ma in che maniera si sviluppava la sua metodologia dialogica?
Alla base di tutto c’è la famosissima (e forse abusata) dichiarazione socratica
per cui
la sapienza appartiene a colui che sa di non sapere
, e che si configura da
un lato come una forma di consapevolezza riguardante l’assenza di una cono-
scenza definitiva, e dall’altro come movente fondamentale del desiderio di co-
noscere. Dunque l’uomo, per conoscere se stesso e giungere alla verità, deve in
primo luogo prendere coscienza del fatto di non sapere nulla. Tre sono i motivi
centrali di questa affermazione:
>
una critica alla sicurezza degli impianti naturalistici e metafisici che infonde-
vano certezze alla filosofia precedente;
>
una
posizione
agnostica
sull’esistenza e la natura di dio;
>
uno sprone alla
ricerca
incessante
delle verità
.
I dialoghi che Socrate era solito intrattenere (e quelli riportati dal
corpus
plato-
nico) dimostrano che il primo passaggio della metodologia socratica era pro-
















