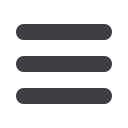
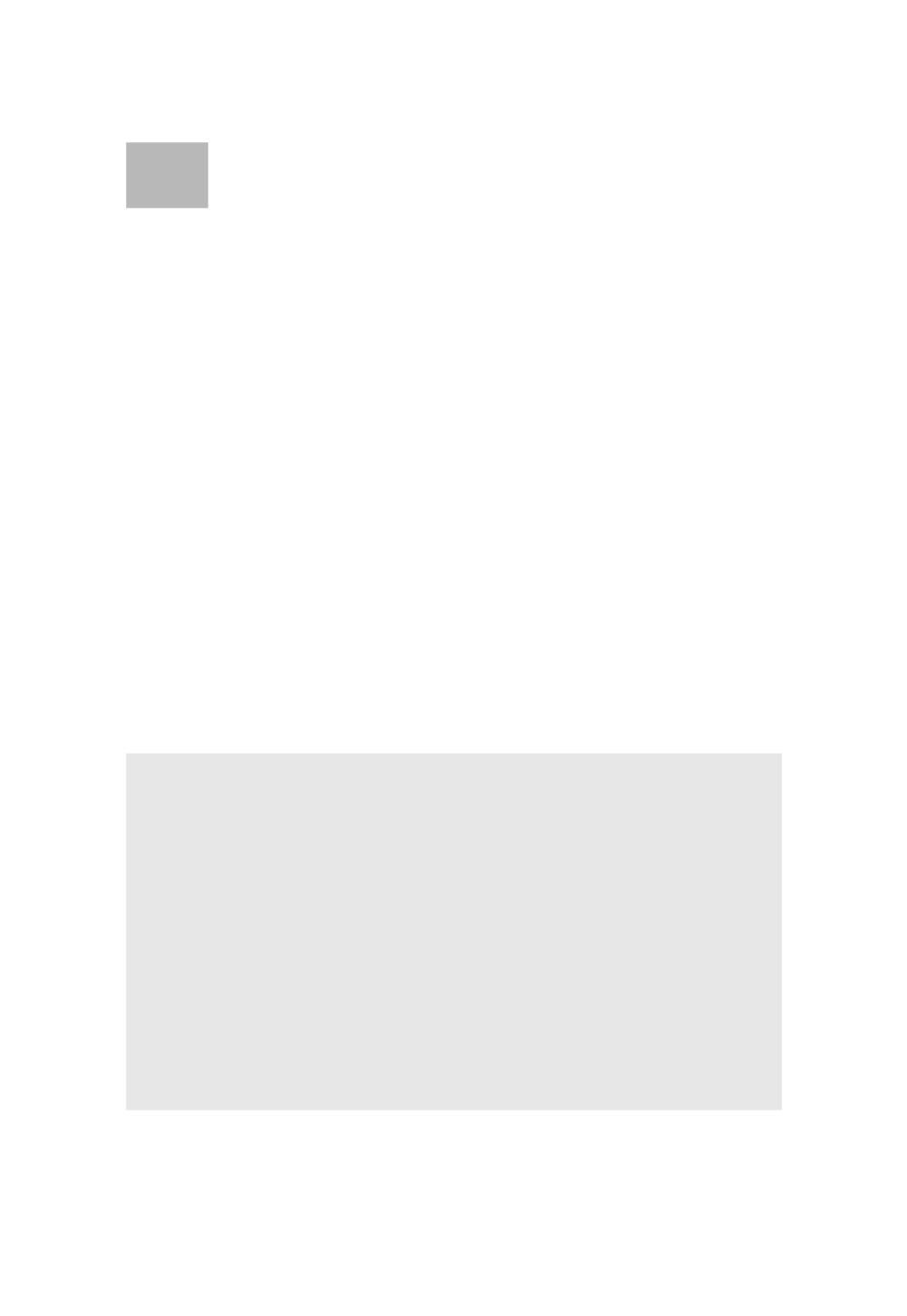
7
Capitolo Settimo
Socrate
7.1
Cenni biografici
Senza dubbio la speculazione di Socrate rappresenta una
fondamentale svolta
nella filosofia occidentale. Egli inaugura, infatti, un modo di fare filosofia rigo-
roso e completamente nuovo rispetto alle esperienze precedenti (ad eccezione
dei sofisti).
Socrate nasce ad Atene, con tutta probabilità tra il 470 e il 469 a.C. da padre
scultore e madre levatrice (come si vedrà successivamente il mestiere della ma-
dre ricoprì grande importanza nell’elaborazione della futura teoria del filo-
sofo). Allievo di Anassagora, approfondisce i suoi primi studi in astronomia e
geometria. Partecipa, come soldato, alle battaglie di Potidea, Delio e Anfipoli.
Pare che in battaglia, come sostenuto dalle testimonianze di Alcibiade, Socrate
fosse uomo di tempra ferrea e solida, incurante del dolore, del freddo e degli
altri patimenti. Si tramanda di lui un’immagine austera, scorbutica e fisicamen-
te molto lontana dall’ideale greco della bellezza.
Socrate e Alcibiade. La sessualità dell’antica Grecia
Socrate aveva una moglie, Santippe, e tre figli (due dei quali, secondo Aristotele, gli sarebbero
stati dati da una sua concubina). Ma l’altro rapporto amoroso di cui si è discusso riguardante
Socrate è quello con il giovinetto Alcibiade. Nell’antica Grecia l’
omosessualità
era comunemente
riconosciuta e accettata, e non si opponeva affatto all’eterosessualità. Aveva tuttavia anch’essa
le sue regole peculiari. In particolare si configurava come una sorta di rapporto a metà strada
tra l’amore (fisico e morale) e l’educazione. Dunque aveva dei forti aspetti pedagogici, ma non
si esauriva solo in questo. Le coppie di uomini omosessuali erano infatti spesso costituite da un
adulto e da un giovane, ed erano fortemente regolate da pratiche condivise. Ecco quello che dice
in proposito uno dei più importanti filosofi del XX secolo, Michel Foucault.
I Greci non immaginavano affatto che un uomo avesse bisogno di una natura diversa (“al-
tra”) per amare un uomo; ma tendevano a ritenere che ai piaceri presi in una relazione
simile si dovesse dare una forma morale diversa da quella richiesta quando si trattava di
amare una donna. In questo tipo di rapporto, i piaceri non tradivano, in chi li provava, una
natura fuori del normale; ma la loro pratica richiedeva degli stilemi particolari.
(Michel Foucault,
L’uso dei piaceri. Storia della sessualità
, vol. II)
Non esistono suoi scritti e questo non perché siano andati perduti nel tempo,
quanto perché esplicita esigenza del filosofo di Atene è quella di affidare la
















