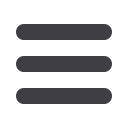
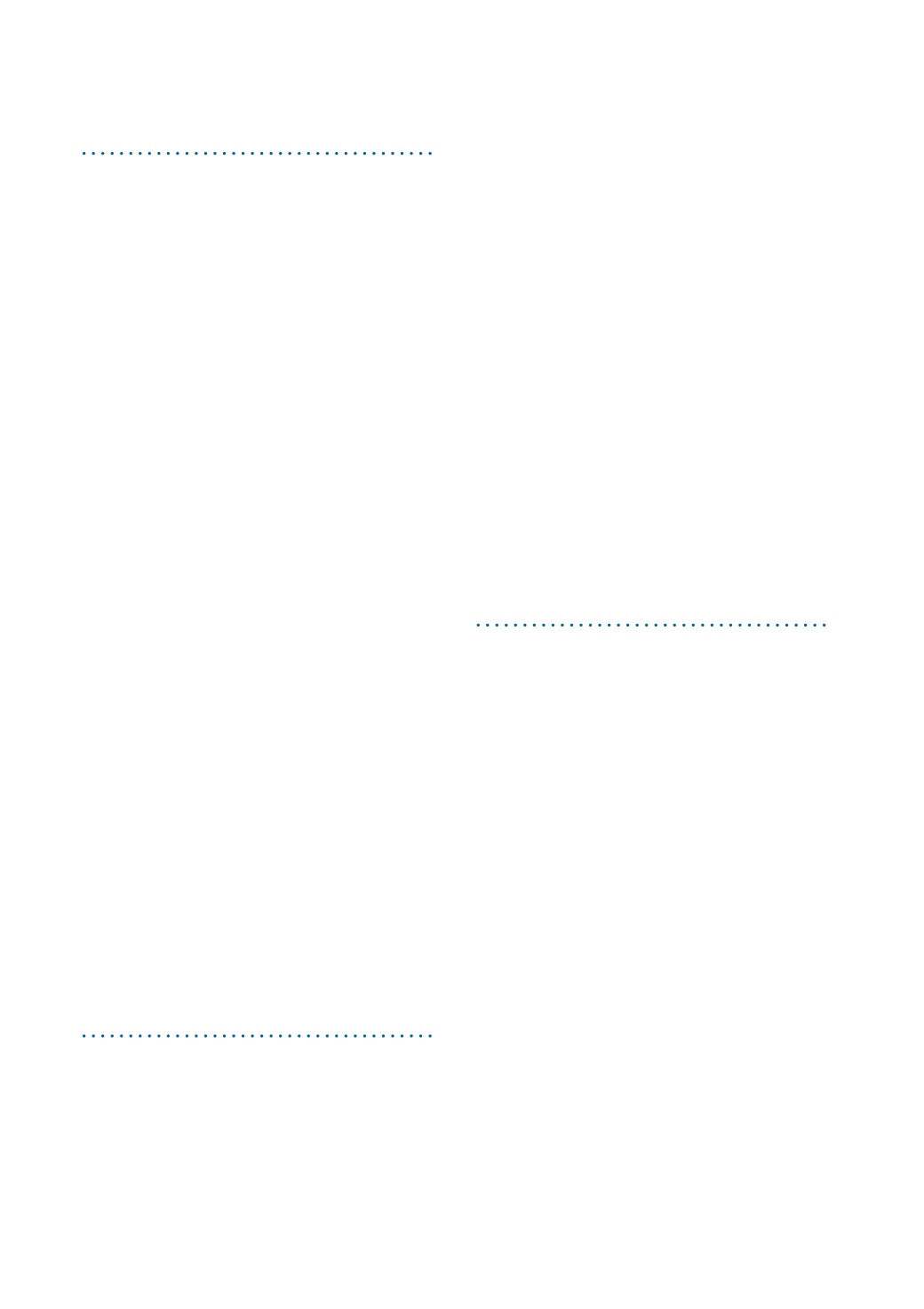
[
422
]
Capitolo 13
EPITELI GHIANDOLARI
13.1 CARATTERISTICHE GENERALI
Gli
epiteli ghiandolari
sono formati da cellule spe-
cializzate nel processo di secrezione, ovvero l’elabo-
razione di sostanze che vengono successivamente ri-
ǯ ϐ ϐ ǡ
proteggere e regolare altre cellule. La secrezione rap-
î ϐ
-
che delle cellule, non solo di quelle epiteliali.
Il
processo di secrezione
può essere continuo e
discontinuo. Nella
secrezione continua
il secreto vie-
ne liberato immediatamente all’esterno della cellula
senza accumularsi prima nel citoplasma. Un esempio
di secrezione continua è rappresentato dalle cellule
mucipare dello stomaco. Nella
secrezione disconti-
nua
, invece, il secreto viene immagazzinato in vesci-
cole delimitate da membrana (granuli di secrezione)
che successivamente si fondono con la membrana
plasmatica riversando il prodotto nell’ambiente ex-
tracellulare. In questo caso il processo di esocitosi
si verifica all’arrivo di uno stimolo di natura nervo-
sa o ormonale. La maggior parte delle ghiandole en-
docrine e le ghiandole esocrine maggiori annesse al
sistema digerente (pancreas, fegato) presenta questa
modalità di secrezione. Le cellule secernenti possono
elaborare un
secreto
che può essere proteico, glico-
proteico, glucidico o lipidico. Tutti gli organuli cellu-
lari prendono parte in misura diversa al processo di
secrezione. Le cellule epiteliali ghiandolari, dunque,
possono presentare all’interno del citoplasma per-
centuali diverse di determinati organuli, necessari
per elaborare un secreto specifico. Quindi dal punto
di vista ultrastrutturale, le cellule a
secrezione protei-
ca
presenteranno un reticolo endoplasmatico rugoso
(RER) molto sviluppato, mentre quelle a
secrezione
glicoproteica
presenteranno un apparato di Golgi
molto esteso; quelle a
secrezione lipidica
, infine, pre-
senteranno un abbondante reticolo endoplasmatico
liscio (REL) oltre a numerosi mitocondri.
13.2 CLASSIFICAZIONE E
DERIVAZIONE EMBRIONALE
DELLE GHIANDOLE
Il
tessuto epiteliale ghiandolare
può essere sud-
diviso in due categorie in base al destino del secreto
elaborato. Si possono dunque distinguere le ghiando-
le esocrine o a secrezione esterna e le ghiandole en-
docrine o a secrezione interna. Le
ghiandole esocri-
ne
sono caratterizzate dalla presenza di una porzio-
ne secernente, definita
adenomero
, e da una strut-
tura specializzata chiamata
dotto escretore
median-
te il quale riversano il secreto all’esterno dell’organi-
smo (per es., le ghiandole sudoripare e le ghiandole
sebacee) o in cavità comunicanti con l’esterno (per
esempio, le ghiandole digestive come pancreas e fe-
gato che riversano il secreto nel lume intestinale). Le
ghiandole endocrine
, invece, non presentano il dot-
to escretore, e riversano il secreto, definito
ormone
,
nei vasi sanguigni che irrorano la ghiandola stessa.
Sia le ghiandole esocrine che quelle endocrine si
formano dall’
epitelio di rivestimento superficiale
,
nel quale un ammasso di cellule (
zaffo epiteliale
) proli-
fera e successivamente si invagina nel tessuto connetti-
vo sottostante (
Figura 13.1
). Quando l’ammasso cellu-
lare resta in contatto con l’epitelio di rivestimento su-
perficiale, si formano le ghiandole esocrine. In questo
caso, lo zaffo epiteliale genera un cordone solido di cel-
lule, la cui parte più profonda forma la porzione secer-
nente della ghiandola, mentre la porzione di collega-
mento si differenzia nel dotto escretore. Nel caso delle
ghiandole endocrine, invece, l’ammasso di cellule per-
de il collegamento con la superficie epiteliale forman-
do delle strutture isolate che riversano il loro secreto
direttamente nei capillari sanguigni (
Figura 13.1
).
13.3 GHIANDOLE ESOCRINE
Le ghiandole esocrine possono essere classificate se-
guendo diversi criteri relativi alla loro organizzazio-
ne strutturale e alla loro forma.
In base al numero di cellule possono essere sud-
divise in:
•
ghiandole esocrine unicellulari
, formate da una
sola cellula;
•
ghiandole esocrine pluricellulari
, formate da
più elementi cellulari.
Le ghiandole pluricellulari possono poi essere ul-
teriormente classificate in base alla sede anatomica,
la forma ed il numero della porzione secernente e del
dotto escretore, e la modalità di secrezione delle cel-
lule secernenti (
Figura 13.2
):
• in base alla sede si dividono in:
intraepiteliali
ed
ex-
traepiteliali
, queste ulteriormente divise in:
parie-
tali
(intramurali) ed
extraparietali
(extramurali);
• in base alla forma dell’adenomero, ovvero la por-
zione secernente della ghiandola, sono suddivise
in:
tubulari
,
alveolari
,
acinose
,
tubulo-alveola-
ri
e
tubulo-acinose
;
Ȉ ϐ
-
gli adenomeri si distinguono ghiandole:
semplici
,
ϐ
e
composte
;
• in base alla modalità di secrezione le cellule secer-
ϐ ǣ
olocrine
,
apocrine
e
mero-
crine
. Queste ultime possono essere ulteriormen-
ϐ ǣ
sierose
,
mucose
e
miste
in base
alla natura del secreto.
















