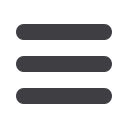
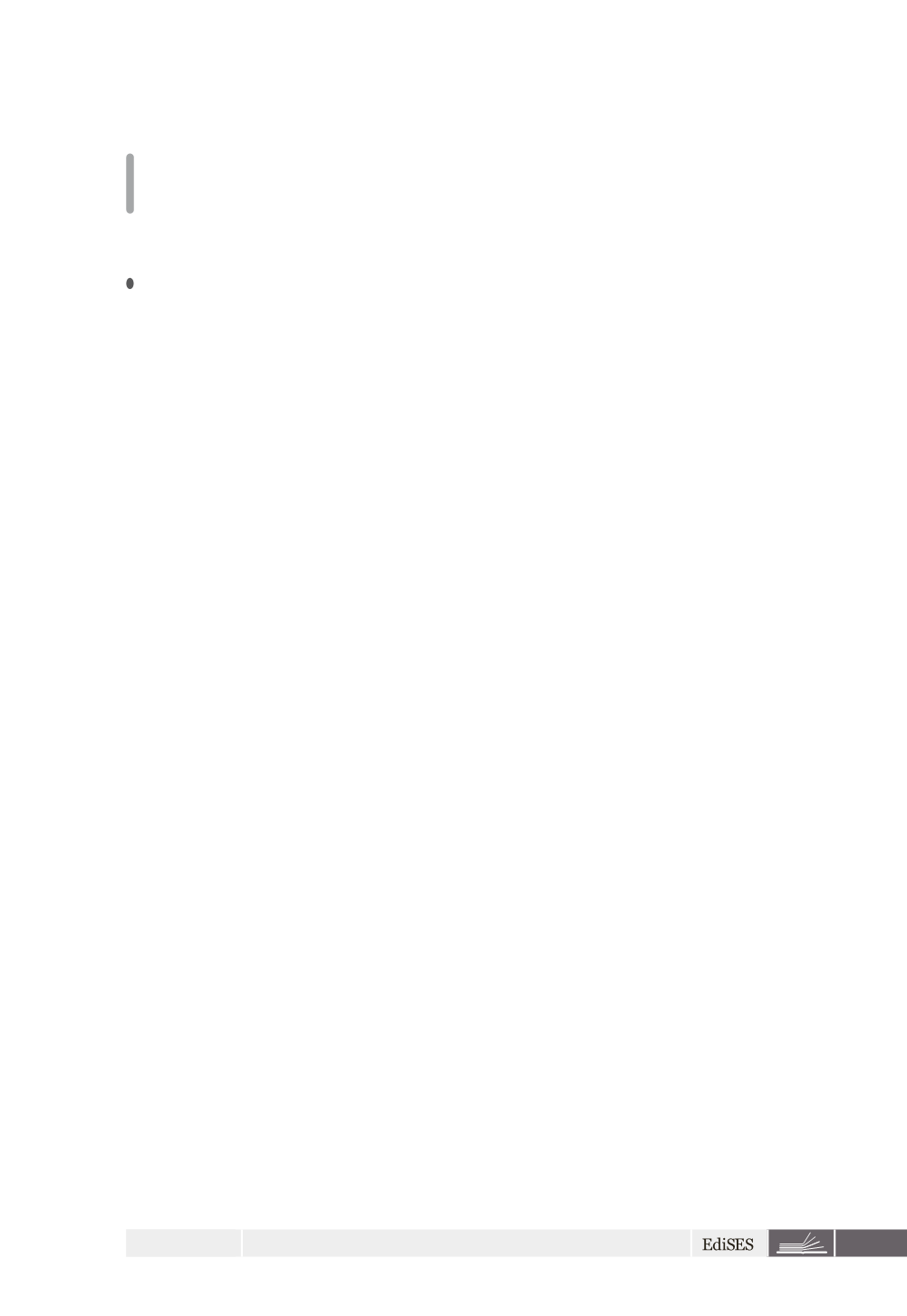
www.
edises
.it
Risposte commentate
La storia della fotografia
151) D.
Fissata per convenzione al 7 gennaio 1839, data della presentazione
ufficiale della
dagherrotipia
all’Accademia delle Scienze di Parigi, la nascita del-
la fotografia deriva dall’unione di due correnti distinte di studi: la prima, dedi-
cata ai fenomeni ottici, porta all’evoluzione della camera oscura; la seconda alla
messa a punto di sostanze chimiche, reattive in caso di esposizione alla luce.
152) C.
Nella messa a punto dei procedimenti di sviluppo dell’immagine i
pionieri della fotografia, in particolare Daguerre per il bianco e nero ed
Eastman per il colore, si attennero al funzionamento dell’occhio umano. Non
a caso, la macchina fotografica viene spesso presa a paragone per spiegare il
meccanismo della
visione
: l’iride corrisponde al diaframma, la retina alla pelli-
cola, il cristallino e la cornea all’obiettivo. Il diaframma si comporta esatta-
mente come il muscolo dell’iride, aprendosi o chiudendosi a seconda dell’inci-
denza della luce e permettendo la messa a fuoco.
153) C.
L’analogia tra occhio e macchina vale anche per la visione dei colori.
La
retina
si comporta come la pellicola: i coni consentono di ricostruire i colo-
ri, mentre i bastoncelli sono i sensori responsabili della visione del nero e del
bianco. Studiando il funzionamento delle lenti e dei prismi, gli scienziati han-
no scoperto che nella luce bianca sono presenti le frequenze di tutti i colori
dell’iride. La luce bianca può, quindi, essere composta e ricomposta a piaci-
mento. Mentre la normale emulsione della pellicola dà forma al bianco e nero,
ciascuno dei tre strati dell’emulsione a colori impressiona un colore diverso:
analogamente ai coni e ai bastoncelli funzionanti nella retina. L’occhio, però, è
più raffinato della fotocamera: mentre nella pellicola ogni colore ha la medesi-
ma sensibilità alla luce, nell’occhio, in condizioni di scarsa luminosità, s’inten-
sifica l’attività dei bastoncelli, che, oltre al bianco e al nero, definiscono i con-
torni e le forme.
154) A.
Il saggio
Oculus artificialis teledioptricus sive telescopium
venne pub-
blicato a Würzburg nel 1685 dal frate tedesco Johann Zahn. Nei suoi studi
sulla prospettiva Leonardo da Vinci (1452-1519) descrisse per la prima volta la
camera oscura, assimilandola, sia pure in maniera approssimativa, all’occhio
umano. Gerolamo Cardano (1501-1576), per riuscire a ottenere immagini me-
glio definite, coprì il foro della camera oscura con uno
specillo
(o
lenticchia
,
come veniva anticamente chiamata la lente) a forma di menisco convesso, d’in-
venzione forse araba. A Giambattista Della Porta (1535-1615), commediografo
e scienziato, si deve poi la conversione della camera oscura in apparecchio per
















