
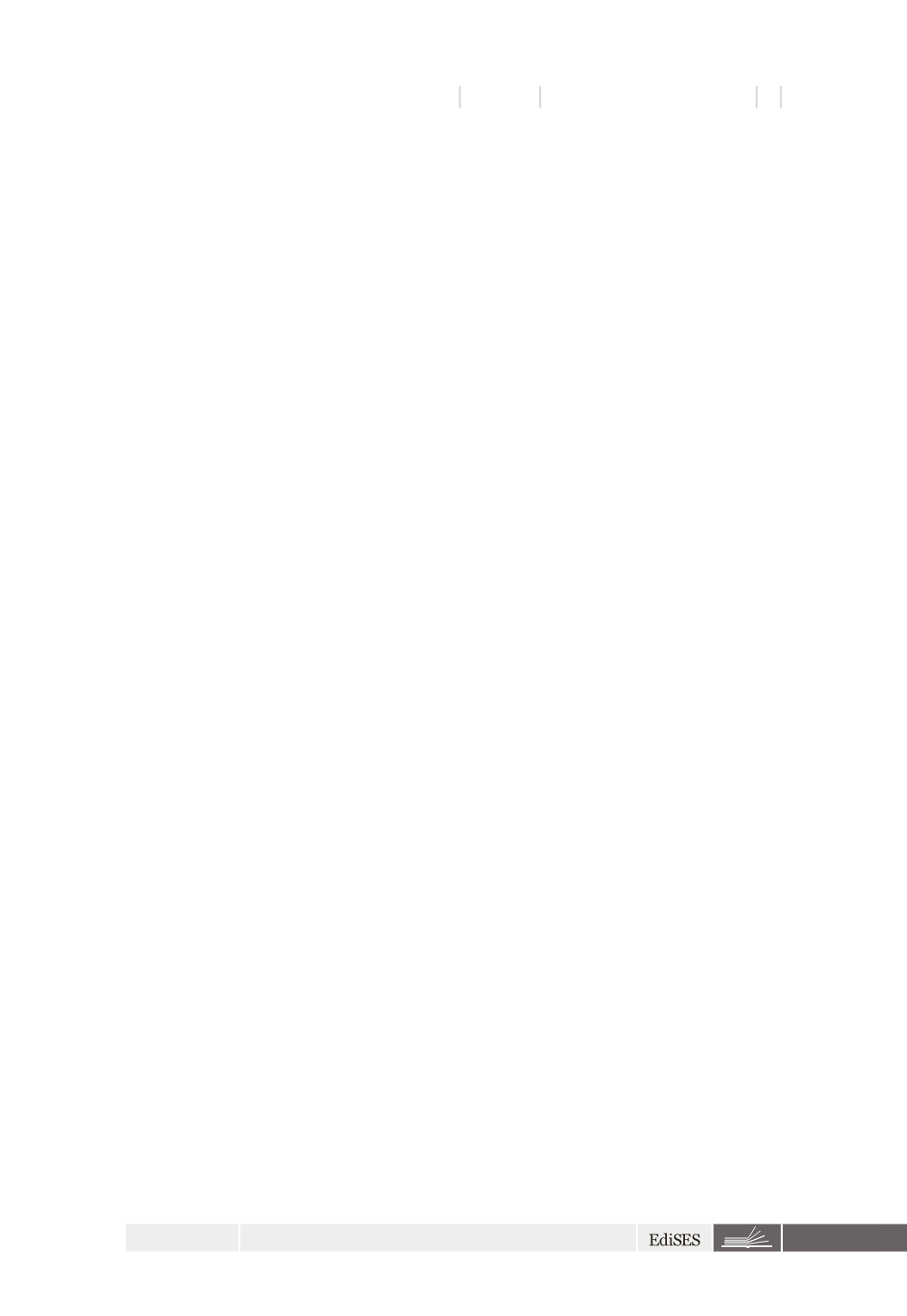
Capitolo 1
Finalità della didattica del greco
7
www.
edises
.it
>
>
aver maturato, tanto nella pratica della traduzione, quanto nello studio della
filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare,
di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi
anche distanti dalle discipline specificamente studiate;
>
>
saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazio-
ni ed essere in grado di collocare il pensiero scientifico anche all’interno di
una dimensione umanistica.
La peculiarità del Liceo classico risiede nello studio della lingua e cultura gre-
ca; la
comprensione dei caratteri distintivi della civiltà greca
, come di quella
latina, prende avvio proprio dalla
conoscenza delle strutture linguistiche
. Lo
studio della morfologia, della sintassi e del lessico, la riflessione sulle radici
etimologiche e sulle aree semantiche, l’analisi retorica e stilistica del testo lette-
rario, la pratica della traduzione, costituiscono il punto di partenza per la cono-
scenza dei nuclei tematici e dei fondamenti costitutivi del pensiero degli autori
del passato, la base per la comprensione dei valori espressi dalla cultura classica
nei vari ambiti di pensiero (filosofico, letterario, artistico, politico, scientifico);
inoltre, costituiscono lo strumento di riflessione necessario per acquisire una
maggiore padronanza dei mezzi espressivi della lingua italiana
, in vista di un
suo uso più corretto e rigoroso.
Ma va detto anche che lo studio delle strutture linguistiche, l’esercizio di
decodifica dei testi in lingua greca (o latina), l’operazione di analisi, destrut-
turazione, comprensione di senso e successiva ri-codifica in lingua italiana,
in una parola la pratica della
traduzione
, si configura come un’operazio-
ne intellettuale di estrema complessità, in quanto coinvolge conoscenze e
abilità che non possono essere ricondotte alla semplice applicazione del re-
pertorio di regole studiate. Si richiede allo studente la capacità di operare
collegamenti e confronti tra le strutture della lingua di partenza e di quella
di arrivo, che in parecchi casi possono sottintendere strutture di pensiero
tra loro differenti; si richiede altresì di accompagnare le conoscenze della
morfosintassi alla comprensione dell’elemento lessicale, al fine di capire il
senso del messaggio espresso nel testo da tradurre. Si richiede ancora la
capacità di trasferire conoscenze di contesto (biografia dell’autore, carat-
teristiche del periodo storico-culturale in cui l’opera si colloca, elementi di
civiltà, conoscenza dei costumi di vita del tempo e degli usi religiosi) all’o-
perazione intellettuale della traduzione, affinché la decodifica del testo sia
quella corretta e la resa in italiano dimostri la reale comprensione di quanto
espresso dall’autore. Alla luce di tutte queste considerazioni, e di altre che si
faranno in seguito, il lavoro di traduzione si presenta davvero impegnativo
e complesso, perché comporta la messa in campo di conoscenze, abilità e
competenze, che sono in parte specifiche, in parte trasversali. La traduzio-
ne, dunque, si configura, non solo come il punto di partenza per lo studio
del mondo classico, ma come il punto di arrivo di un percorso di appren-
dimento che permetta allo studente di mettere a frutto il suo sapere e il
suo saper fare, applicando all’analisi e alla comprensione del testo letterario


















