
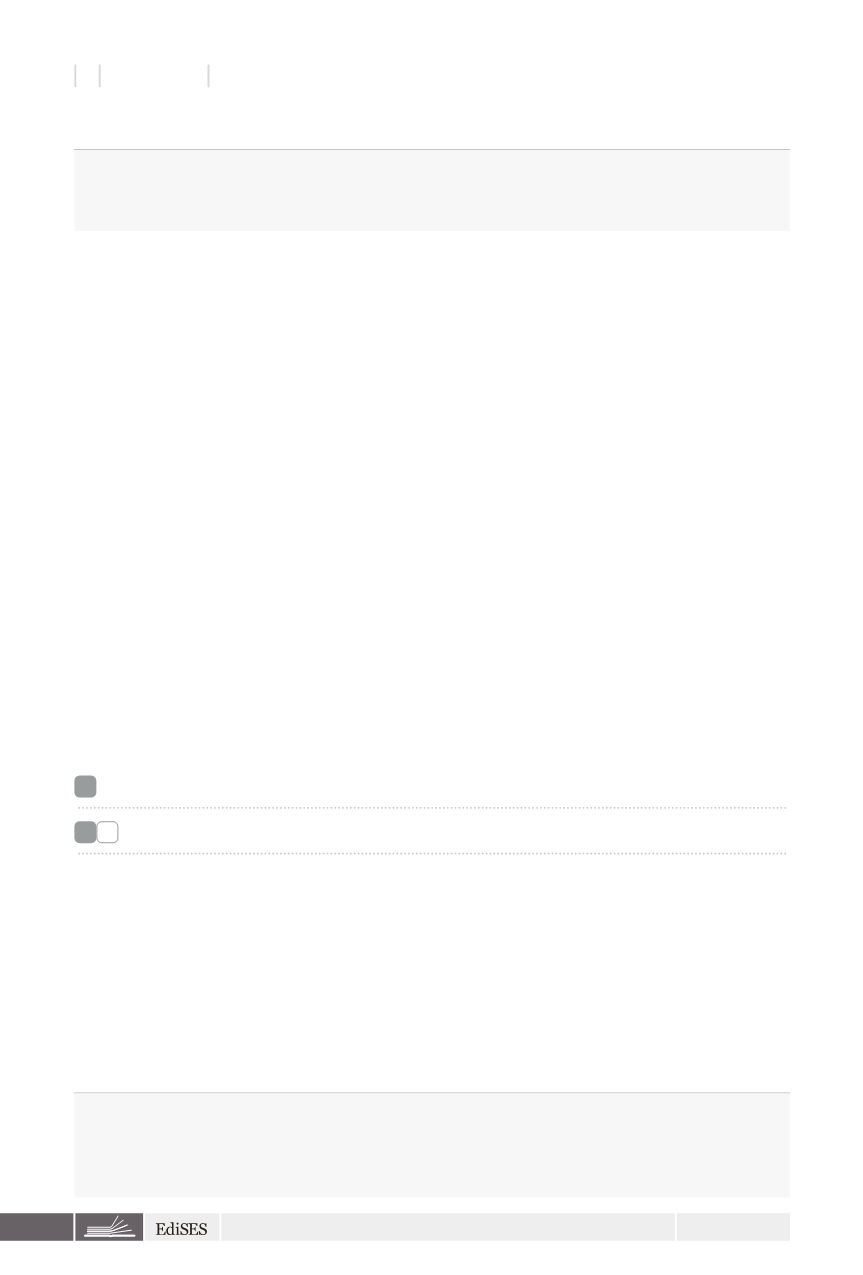
www.
edises
.it
Sono norme giuridiche quelle che impongono di rispettare la segnaletica stradale,
pagare le tasse, non danneggiare la proprietà altrui, saldare i propri debiti e così
via.
Il carattere “coattivo” della norma giuridica, ovvero la sua obbligatorietà, che implica
l’applicazione di una sanzione per il caso della violazione della stessa, è, dunque,
imprescindibile. È proprio questo elemento centrale della norma giuridica che con-
tribuisce in modo determinante a differenziarla da altri tipi di norme, come quelle
morali o religiose, che, come detto, appartengono ad una sfera non coattiva: le nor-
me etiche, morali, sociali, vincolano infatti solo nel cd.
foro interno
(della coscienza)
ovvero sotto il pro lo meramente sociale, di pura cortesia.
La norma giuridica, in de nitiva, non va confusa con la semplice regola. Sia la norma
giuridica sia la semplice regola sono prescrittive. La norma giuridica si distingue,
però, per la giuridicità, ossia per la caratteristica d’essere inclusa in un
ordinamento
(insieme di norme) pienamente riconosciuto da una società organizzata (cd. “prin-
cipio di effettività dell’ordinamento”) e per dover essere rispettata da tutti i compo-
nenti di tale società.
La distinzione tra regole sociali e norme giuridiche, dunque, si basa sulla loro diversa
obbligatorietà e non sul loro contenuto, che in alcuni casi può coincidere e in altri
può essere diverso.
A questo punto, si può dare una prima de nizione del concetto di
ordinamento
giuridico
, da intendersi come l’insieme di norme giuridiche prodotte da un gruppo
sociale che mirano a regolare e organizzare la vita di tale gruppo.
Lo Stato è un ordinamento giuridico a ni generali, dotato di potere sovrano nell’am-
bito del proprio territorio.
1.2
•
La struttura e le caratteristiche della norma giuridica
1.2.1
•
Struttura della norma giuridica
Dal punto di vista della
struttura
, si possono individuare nella norma giuridica due
parti: una prima parte contenente
la descrizione di una situazione
(o
fattispecie
) e
una seconda parte contenente
l’affermazione di una conseguenza
(o
statuizione
) posi-
tiva o negativa.
Dalla
fattispecie legale
, che è la previsione di un fatto generale e astratto, si distin-
gue la
fattispecie concreta
, che consiste nel fatto che si è effettivamente veri cato; se
il giudice accerta che la fattispecie concreta coincide con quella legale deve applicare
al caso sottoposto al suo esame la conseguenza che è prevista in astratto dalla norma.
ESEMPIO
In virtù dell’art. 2043 c.c., secondo il quale “Qualunque fatto doloso o colposo,
che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno” (fattispecie legale o astratta), se il conducente di un autoveicolo
danneggia accidentalmente un motoveicolo in sosta (fattispecie concreta), questi


















