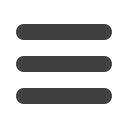

www.
edises
.it
Gli esempi più pregnanti di totalitarismo europeo che la storia ricordi sono lo
Stato fa-
scista
– incarnato principalmente nel regime fascista italiano (1922-1943) e nel regime
nazionalsocialista tedesco (1933-1945), i quali innalzarono alla guida della Nazione, ri-
spettivamente, il
Duce
e il
Führer
, capaci di impersonare lo spirito e i ni delle rispettive
collettività nazionali – e lo
Stato socialista
– basato su quella che Karl Marx chiamò la
dittatura del proletariato
– frutto della
Rivoluzione bolscevica
scoppiata nel 1917 nell’Impe-
ro russo, il cui ideale fondante era una società priva di classi sociali. Lo Stato socialista è
entrato in crisi in Unione Sovietica e nell’Europa dell’Est a partire dagli anni novanta del
secolo scorso, con il tracollo dell’ideologia comunista e il progressivo affermarsi di quella
liberista.
2.5.2
Lo Stato democratico e sociale
La seconda metà del secolo scorso è stata occupata dal pieno dispiegarsi della forma
di
Stato democratico e sociale
, che si differenzia non solo dallo Stato autoritario ma
anche dallo Stato liberale, per i seguenti aspetti:
>
la base sociale dello Stato si allarga attraverso il suffragio universale e diretto (
Stato
pluriclasse
), con il conseguente riconoscimento del più ampio
pluralismo politi-
co
(concorrenza fra diversi partiti politici),
economico
(compresenza di molteplici
organizzazioni sindacali in rappresentanza delle diverse categorie economiche e
produttive),
sociale
(massima libertà di associazione riconosciuta ai privati),
cultu-
rale
(libertà di insegnamento, diritto di istituire scuole e istituzioni di alta cultura,
libertà della scienza e dell’arte) e
religioso
(riconoscimento dell’eguale libertà di
tutte le confessioni religiose);
>
la Costituzione, che racchiude e riconosce i principi e i valori fondanti dell’ordina-
mento, può essere modi cata soltanto da una legge approvata con un procedimen-
to più complesso e da una maggioranza più ampia di quella richiesta per l’approva-
zione di una legge ordinaria (
Costituzione rigida
);
>
il principio di legalità si evolve in
principio di legalità costituzionale
, con la con-
seguenza che anche la legge ordinaria deve conformarsi alla Costituzione e, a ga-
rantire che ciò avvenga, è preposto un organo giurisdizionale particolare, la
Corte
costituzionale
;
>
il
principio di separazione dei poteri
non viene superato, ma si arricchisce di nuove
funzioni e nuovi organi e, inoltre, si af da a una gura
super partes
con funzioni di
garanzia (Presidente della Repubblica) il compito di assicurare l’equilibrio fra i vari
poteri dello Stato;
>
la necessità di includere nello Stato anche le fasce di popolazione più deboli im-
pone una
politica economica e sociale interventista
, nalizzata a ridistribuire la
ricchezza;
>
l’intervento statale si concretizza anche nella promozione di un’
economia mista
,
caratterizzata dalla proprietà pubblica e privata dei mezzi di produzione, dalla par-
tecipazione diretta dello Stato allo sviluppo economico attraverso le imprese pub-
bliche, da politiche regolatorie volte a realizzare ni sociali.
Nel ventunesimo secolo, le democrazie pluraliste si trovano ad affrontare s de anco-
ra in larga parte inedite, fra cui quella lanciata dagli imponenti fenomeni migratori,
che ne potrebbero, nel lungo periodo, modi care in maniera de nitiva il volto. Sul
piano economico, la
globalizzazione
e il
neoliberismo
impongono politiche di priva-
















